Prima di narrare la vicenda è importante presentare Alessandria nel XVI secolo e il suo ruolo militare nell’impero spagnolo. Al confine con il ducato di Savoia, collegata a Genova, tramite i passi appenninici, e a Milano e Venezia, grazie al suo porto sul Tanaro, era in una posizione strategica perfetta.
Le truppe spagnole dirette nelle Fiandre non attraversavano lo stretto della Manica, ritenuto troppo pericoloso, ma imbarcate a Barcellona, sbarcavano a Finale o a Genova e da lì, attraverso il Cadibona o i Giovi, raggiungevano Alessandria. Qui, dopo una sosta più o meno lunga, ripartivano per la meta finale, dopo aver attraversato il Piccolo San Bernardo o, il Moncenisio, e la Franca Contea.
Il passaggio continuo di uomini e salmerie favoriva i contatti fra soldati e alessandrini, si pensi alle forniture di vettovaglie, ai commerci più o meno leciti e al contrabbando. Quanti oggetti, bottino di guerra, sono stati venduti ai mercanti locali. Chissà quante opere d’arte sono finite nelle case dei nobili alessandrini.
Comunque questi continui arrivi causavano anche non pochi problemi alla cittadinanza, che già doveva provvedere al mantenimento del presidio ordinario.
Il numero dei componenti di questo oscillava fra i 5000 e i 7000 uomini. I soldati non vigilavano solo sulla città e i dintorni, ma spesso erano inviati di rinforzo a contingenti impegnati in operazioni militari anche in fronti lontani.
Molti presidiari poi avevano famiglia in Alessandria o vi possedevano dei beni, possiamo quindi immaginare la poca disponibilità da parte loro ad allontanarsi dalla città, magari con il rischio di non tornare.
Al presidio si dovevano aggiungere poi le formazioni di passaggio per Alessandria.
Non si trattava di mille o due mila uomini, a volte si arrivava a numeri elevati: un solo esempio, nel 1603, partono da Alessandria per le Fiandre 18.000 soldati (su una popolazione di 14.000 abitanti) dopo 22 mesi di permanenza e di relativi oneri per la città.
In quell’epoca non esistevano caserme (come nei secoli successivi) dove alloggiare i soldati in arrivo, per cui la maggior parte di loro (in primis gli ufficiali) veniva ospitata presso le famiglie cittadine, che dovevano mantenerli in tutto e per tutto.
A questo onere si aggiungevano contribuzioni di ogni genere, a cominciare dal mantenimento di eventuali servitori o concubine.
Fra l’ottobre del 1600 e marzo del 1603 gli alessandrini sborsano giornalmente 140 scudi per il mantenimento delle truppe in città.
Quando non si riesce a dare più alloggio, allora i soldati si accampano ovunque, fuori le mura, nelle vie della città, nelle piazze, causando non pochi disagi alla popolazione e non poche tensioni.
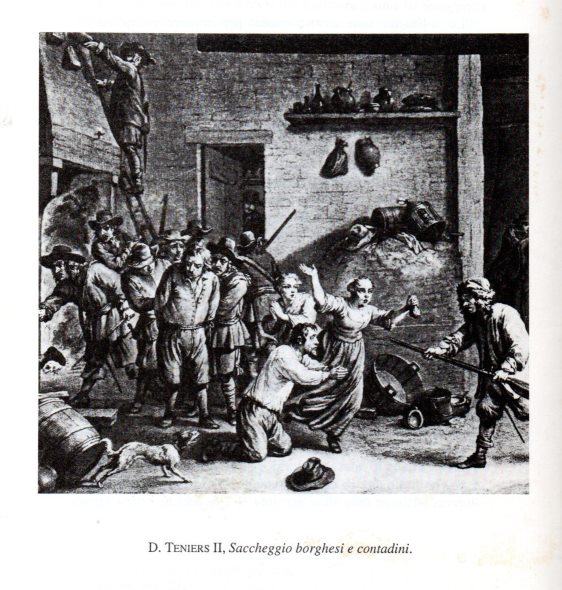 Tensioni che potevano esplodere in risse o in vere e proprie sommosse: nel 1626 i soldati del presidio, lamentando il ritardo nella corresponsione del soldo, a carico del Comune, assediarono gli amministratori della città, là dove si riunivano, fino a quando non venne loro garantito il pagamento del dovuto.
Tensioni che potevano esplodere in risse o in vere e proprie sommosse: nel 1626 i soldati del presidio, lamentando il ritardo nella corresponsione del soldo, a carico del Comune, assediarono gli amministratori della città, là dove si riunivano, fino a quando non venne loro garantito il pagamento del dovuto.
Solo che il Comune, non avendo risorse, fu costretto a prendere il denaro in prestito al 7 % di interesse.
I soldati erano una minaccia per tutto: per il benessere della comunità, per l’onore delle donne e delle famiglie, per la salute, uno su quattro era portatore di malattie, da quelle veneree alla peste.
L’ episodio in questione per certi aspetti può apparire curioso, ma non lo è. Quando viene citato ne “Gli 800 anni di Alessandria” viene presentato così:” Non mancano episodi gustosi o divertenti. Nel 1573 tre soldati spagnoli per protestare contro il loro trasferimento imbrattano di sterco gli stemmi sulle porte del Duomo e dei palazzi cittadini.”
Scritta così sembra quasi una goliardata. Leggiamo come la presenta Gerolamo Ghilini, autore degli “Annali di Alessandria”: “Essendo di là (Alessandria) partito il presidio ordinario per andare in Fiandra, e venuta in luogo di esso altrettanta fanteria napolitana, tre soldati del suddetto presidio investigarono la maniera molto infame per indurre il governatore di questa città in sospetto di qualche ribellione e perciò facesse per ogni sicurezza ritornare in Alessandria il suddetto presidio, al quale rincresceva molto andarsene in Fiandra. Fatta dunque fra loro una congiura, di notte imbrattarono di sterco umano le porte del Duomo, di San Marco, di San Martino, e il simile fecero all’arme del re di Spagna su la casa di Lodovico Perboni e in altri luoghi (…).”
La narrazione continua con la scoperta dell’orribile misfatto e con il conseguente intervento del vescovo, Guarnero Trotti, e dell’inquisitore, Gian Battista Porzelli. E’ un atto dovuto, visto che sono state imbrattate le porte del duomo e della sede dell’inquisizione alessandrina, il convento di san Marco, situato allora nell’ attuale area compresa fra via Cavour, piazza duomo, via Faà di Bruno e via Pontida. A ciò si aggiungano gli stemmi reali, specie quelli sulla casa di Lodovico Perboni, magistrato della città.
Vengono promesse ricompense, si ascoltano gli “amici” (gli informatori dell’inquisizione) e alla fine si scoprono gli autori del delitto. Sono tre soldati biscaglini, i quali non demordono. Si rivolgono al podestà, lo spagnolo Francesco Sessè, e accusano del crimine i soldati napoletani e gli alessandrini.
Il podestà arresta e sottopone a tortura un certo numero di cittadini, i quali, fra i tormenti, ammettono tutto e anche di più.
Vescovo e inquisitore però, certi della loro indagine, avvenuta in maniera più razionale e con metodo, non si fanno intimidire e passano al contrattacco: mons. Porzelli si reca a Milano, per conferire addirittura con il governatore dello stato, marchese d’Ayamonte, che interviene presso il podestà, facendo scarcerare i cittadini alessandrini e imponendo l’arresto dei tre.
Questi sono processati e condannati a remare sulle galee reali. Ma la pena non potrà essere applicata perché moriranno la notte prima di partire per Genova.
Ghilini parla di veleno, e veleno sicuramente fu, non dicendo altro se non celebrando i meriti investigativi e diplomatici di mons. Porzelli.
Non si indagò oltre. Erano morti, ormai condannati, giustizia era stata fatta…
La domanda però sorge spontanea: la misteriosa morte dei tre colpevoli cosa nasconde? Si è voluto impedire che i soldati rivelassero dell’altro?
Erano coinvolti altri militari o addirittura personaggi di rango più alto? Perché il podestà prese le parti dei tre? E quale fu il ruolo del governatore della città, anch’egli spagnolo?
Fu uno scontro fra potere militare, più rozzo, e potere religioso, meglio radicato nel territorio e più raffinato nelle procedure investigative?
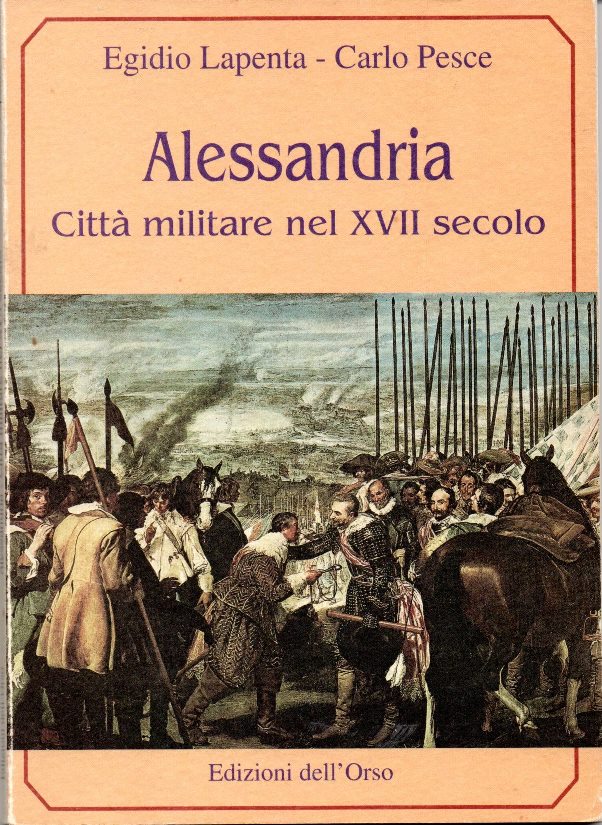 C’è poi da domandarsi come mai quei tre fossero ancora in città. Ghilini dice che si erano nascosti. Ma non erano disertori. Era partito tutto il presidio, oppure no? Alle dipendenze di quale ufficiale erano?
C’è poi da domandarsi come mai quei tre fossero ancora in città. Ghilini dice che si erano nascosti. Ma non erano disertori. Era partito tutto il presidio, oppure no? Alle dipendenze di quale ufficiale erano?
Sono ascoltati come testimoni e anche difesi con una certa determinazione, sembra profilarsi addirittura uno scontro fra ispanici e “italiani”, alessandrini e napolitani (verso questi ultimi Ghilini manifesta spesso stima).
Sono domande a cui purtroppo non danno risposta neppure Schiavina e Avalle, che riprendono senza modifiche la narrazione degli “Annali”. Forse bisognerebbe cercare nell’ Archivio di stato di Alessandria, dove sono presenti molti documenti dell’amministrazione spagnola.
La morte dei colpevoli per avvelenamento (in Italia c’è una certa tradizione in merito) pone più di una domanda.
Egidio Lapenta


Commenta per primo