Francesco Forte è un vecchio professore, ordinario di Scienza delle finanze dell’Università di Torino, quasi novantenne (è nato a Busto Arsizio nel 1929) nonché un protagonista della vita economica e politica del Paese, dall’inizio degli anni Sessanta in poi. La sua autobiografia è di grande interesse e si fa leggere quasi come un romanzo, pur essendo al tempo stesso profonda e documentata.
La prima cosa che mi è venuta in mente a fine lettura è stata la parabola dei talenti (Matteo, 25, 14/30). C’è chi ne riceve cinque dal suo “Signore” e ne restituisce dieci, chi due e ne dà quattro e chi uno e non dà niente (ed è scacciato). Ho pensato che Forte ha ricevuto cinque talenti, ma li ha almeno raddoppiati. Certo è “nato bene”. É figlio di un giudice, Procuratore del Re, operante a Sondrio, dove la famiglia risiedette dal 1939. Un altro zio era giudice pure lui, a Milano. Uno insegnava Diritto ed Economia nell’Università ambrosiana e aveva, a Crema, la maggior biblioteca di scienze giuridiche economiche e sociali dopo quella dell’Università di Milano (p. 107). Uno zio di Forte, che lui dice “liberale nazionalista”, è stato un famoso personaggio alle origini del neofascismo del Movimento Sociale Italiano, Ezio Maria Grey (p. 32). La famiglia possedeva ville storiche sin dai trisnonni. Egli, però, non perse un colpo (anche perché eticamente e culturalmente ben allevato da entrambi i genitori). Ebbe certo molta fortuna, ma anche un bel po’ di virtù (nel senso del Machiavelli). Fu un ottimo scolaro e poi un ottimo liceale. Si laureò in Legge a Pavia a ventidue anni nel migliore dei modi, ma a vent’anni era già collaboratore e redattore dell’importante “Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze” del suo maestro, Benvenuto Griziotti, che lo destinò subito alla carriera universitaria. Divenne subito assistente ordinario e a venticinque supplente all’Università di Milano del grande studioso, nonché famoso ministro delle finanze, Ezio Vanoni. Giovanissimo, si trovò a fare il responsabile della pagina economica del “Giorno” e, più oltre, il manager dell’industria dolciaria Ferrero. Tenne pure una borsa di post-dottorato all’Università della Virginia, diventando collaboratore e amico di due premi Nobel dell’Economia come James Buchanan e Ronald Coase (p. 156 e seguenti). Tornò in Italia nel 1961, avendo vinto il concorso come ordinario di Scienza delle Finanze, andando a Torino su quella che era stata la cattedra di Luigi Einaudi. Aveva trentadue anni. Più oltre ebbe un ruolo sempre di primo piano nella gestione della politica economica del Partito Socialista, specie nel periodo craxiano, in cui fu ministro delle Finanze.
Il suo approccio è sempre stato quello detto liberalsocialista, ma in lui il “socialista” sembra qualificare il liberalismo. In Italia il liberalismo, almeno sino a Zanone (1976), non è stato mai prevalentemente di sinistra. Perciò il liberalismo sociale ha dovuto sposarsi con la socialdemocrazia saragattiana e poi, in modo quasi naturale, con il socialismo craxiano. Ciò è tanto vero che nel 1953 Forte faceva già campagna elettorale col fratello del suo maestro, Brunetto Griziotti (p. 134), per il PSDI, in cui era un dirigente provinciale di primo piano. Anche per questo si trovò ben presto – come intellettuale di acclarato valore nel campo della scienza economica e soprattutto delle finanze – ad avere un ruolo più o meno importante nei ministeri economici e negli enti economici di stato come l’ENI. Al proposito sono molto importanti, e veramente utili a ogni storico dell’economia, le pagine sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica del 1962 e sui suoi limiti, anche in termini di formazione di nuovi potentati economici con confusione tra privato e pubblico che hanno alimentato sia il debito pubblico che i processi corruttivi dello Stato (pp. 175-187).
L’aspetto di gran lunga più intrigante del libro, e che anzi pare a me il vero filo rosso di queste memorie, è quello sui misteri d’Italia, su cui approfittando forse del fatto di essere ormai un signore di ottantanove anni, e anche del fatto che molti – e credo anzi quasi tutti – quelli di cui parla sono morti, dice cose spesso “stuzzicanti”, che forse potrebbero qua e là interessare ancora non solo lo storico dell’economia, ma anche qualche “appassionato” di faccende giudiziarie.
Si parte dall’uccisione di Mussolini e di Claretta Petacci. Forte aveva allora sedici anni, ma la cosa lo impressionò per forza in quanto avvenuta non lungi dalla sua Sondrio, tanto più che ad occuparsi di quelle morti, e del connesso affaire dell’oro di Dongo, dovettero essere prima suo padre e poi il suo zio Pubblico Ministero a Milano. Egli tende ad accreditare quel che tra i comunisti ho sentito chiamare “sostituzione di persona”, ossia la tesi che colui che si sarebbe presentato come il colonnello Valerio, Walter Audisio di Alessandria, alla banda partigiana che aveva catturato Mussolini e altri alti gerarchi, fosse Pietro Longo (fratello di Luigi?). La presenza sulla scena di tal Longo sarebbe stata comprovata da un tribunale (p. 87), anche se a me pare altamente controvertibile, nonostante il libro, qui citato (p. 422n.), di U. Lazzaro Dongo. Mezzo secolo di menzogne (Mondadori, 1993). Molto più dettagliati sono i riferimenti all’assassinio in cielo, nell’ottobre 1962, per esplosione dell’aereo, del mitico fondatore e Presidente dell’ENI, Enrico Mattei (pp. 223-237 e soprattutto 226-227): assassinio su cui da un lato Forte richiama dati sulla paura di salire in aereo con Mattei di persone citate con nome e cognome, dopo vari avvertimenti o attentati mancati, e dall’altro le dimensioni dell’affare che Mattei veniva trattando con la nuova Algeria di Ben Bella, e che morto lui si ridimensionò molto, facendo venir meno il possibile primato dell’ENI nel rapporto con quel Paese appena decolonizzato. L’assassinio di Mattei non sarebbe da attribuire ai giganti petroliferi delle Sette Sorelle, come nel famoso film su Mattei interpretato da Gian Maria Volonté, bensì all’estrema destra francese-algerina dell’OAS, ostile al consentire che alla Francia colonialista succedesse, in ambito petrolifero, l’Italia democratica (pp. 226-237). Comunque il protagonismo di Forte in materia di politica energetica è stato tale che Pasolini ne ha (o avrebbe?) fatto, col nome di ingegner Carlo, il protagonista (p. 228) del suo romanzo postumo, e incompiuto, Petrolio (1972/75, ma 1992).
Naturalmente sono molto importanti, nel racconto “da testimone” di Forte, tutte le pagine, altamente drammatiche, sull’assassinio di Moro (pp.245-254), col famoso contrasto tra la linea della trattativa, per salvare un innocente anche rilasciando una brigatista gravemente ammalata, e quella della fermezza patrocinata dal PCI. La linea della trattativa era sostenuta in modo unanime dal PSI di Craxi. Al leader socialista morto esule in Tunisia, Bettino Craxi, Forte fu vicinissimo nei drammatici giorni del sequestro Moro. Vivendo lui pure all’albergo Raphael di Roma, lo frequentava ogni giorno. Sarebbe stato lui a persuaderlo del valore universale di tale linea, specie in base all’empirismo etico di Giuliano Pontara (che tra l’altro è il maggior studioso italiano di Gandhi). Sull’umanitarismo socialista (p. 246), ma pure sulla grandezza politica di Craxi (p. 290), Forte dice cose tutte da ricordare. Lo apprezza in sommo grado, pur differenziando il proprio liberalsocialismo (o liberalismo socialista) dal socialismo liberale di Craxi, ritenuto più aperto allo statalismo economico e – previa auspicata socialdemocratizzazione del PCI – all’unità della sinistra (p. 297). Forte considera Craxi come il maggior leader politico della storia della prima repubblica dopo De Gasperi (p. 299), e lo spiega (pp. 290-299). Notevolissime sono pure tutte le pagine sull’affare della loggia P2 e soprattutto sul caso di Roberto Calvi (pp. 272-280), il presidente del Banco Ambrosiano finito impiccato, nel luglio 1982, sul Ponte dei Frati Neri di Londra, dopo un grave ammanco della sua banca molto connesso alla Banca Vaticana: lì ci sono dettagli sicuramente inediti e da riprendere, oltre che altamente drammatici in riferimento alla personalità stessa del banchiere (pp. 272-280). Pure intensamente drammatiche, e ricchissime di osservazioni di prima mano, sono le pagine sull’affare Enimont (pp. 340-343), ossia sulla famosa fusione tra la Edison di stato e la Montecatini ormai di Raul Gardini, con ben tre suicidi eccellenti, senza contare la misteriosa morte del ministro democristiano Bisaglia (p. 261) e misteriosi attentati o incendi a carico di Siro Lombardini (pp. 261-262). Forte tende a ritenere le morti in oggetto omicidii mascherati da suicidi. In linea generale egli ci mostra da un lato la realtà di tre soli gruppi supercapitalistici forti, con uno dei quali almeno sarebbe stato (o sarebbe?) necessario allearsi, per ogni aspirante protagonista epocale: cosa che Craxi – benché da lui consigliato – non avrebbe compreso (p. 294); dall’altro la pericolosità del potere, non solo in tempi di terrorismo, ma anche “normali”, essendo esso comunque nel mirino di forze – mafiose e non, interne e internazionali – che quando gli affari sono di proporzioni immani non si fanno scrupolo di ricorrere all’intimidazione e persino all’omicidio.
La coinvolgente narrazione di Forte si snoda da Mussolini a Berlusconi, ma il secondo è un termine ad quem. Ci si può perciò augurare un seguito, che dal 1994 giunga ai giorni nostri: compatibilmente con la “veneranda età” dell’autore. Ma non dubitiamo del fatto che Forte avrà la forza di farlo.
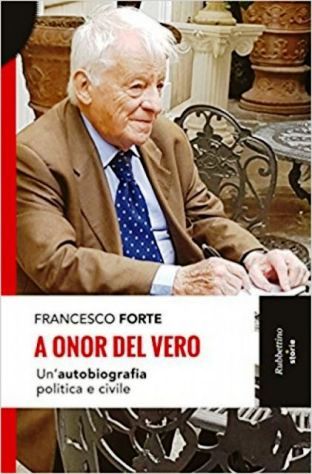
(FRANCESCO FORTE, A onor del vero. Un’autobiografia politica e civile, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2017, pagg. 448, E. 15,30).
Fonte: FRANCO LIVORSI, Francesco Forte: 50 anni di misteri italiani. Dalla fucilazione del duce a Berlusconi, “Qui Libri”, luglio-agosto 2018, pp. 35-36.


Commenta per primo