Introduzione
Quest’anno si celebra l’850° compleanno di Alessandria. Già, ma come abbiamo fatto a stabilire la data di nascita della nostra città? Cosa sappiamo di chi l’ha voluta, di chi l’ha osteggiata, di chi l’ha costruita e abitata? Cosa sappiamo del perché è stata edificata proprio dove si trova ancora oggi e cosa sappiamo del perché è stata chiamata così? Per rispondere abbiamo scelto un saggio di Geo Pistarino che conta ben 33 pagine ed è molto complesso. Ma, poiché ci è sembrato centrare tutte le risposte alle nostre domande, abbiamo pensato di riportarle qui, tacendo le parti non congruenti con i quesiti che ci eravamo posti all’inizio.
Geo Pistarino
La doppia fondazione di Alessandria
Rivista di Storia Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1997
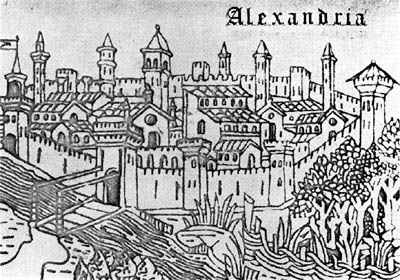 “La fondazione di Alessandria, fra la convergenza dell’Orba con la Bormida e quella di quest’ultima col Tanaro, venne a colmare la mancanza d’un grosso centro abitato nella pianura fra Tortona ed Acqui. L’operazione venne formalmente intrapresa, stimolata e diretta, più o meno apertamente, dai consoli delle città della Lega, che evidentemente se ne assunsero la responsabilità, mancando il beneplacito imperiale, come d’obbligo, forse essi medesimi scelsero il nome della nuova città? Fu davvero finanziariamente sostenuta, non si sa bene come (prestito? donativo?) dal governo di Genova, come dicono gli Annalisti genovesi, che riteniamo bene informati?
“La fondazione di Alessandria, fra la convergenza dell’Orba con la Bormida e quella di quest’ultima col Tanaro, venne a colmare la mancanza d’un grosso centro abitato nella pianura fra Tortona ed Acqui. L’operazione venne formalmente intrapresa, stimolata e diretta, più o meno apertamente, dai consoli delle città della Lega, che evidentemente se ne assunsero la responsabilità, mancando il beneplacito imperiale, come d’obbligo, forse essi medesimi scelsero il nome della nuova città? Fu davvero finanziariamente sostenuta, non si sa bene come (prestito? donativo?) dal governo di Genova, come dicono gli Annalisti genovesi, che riteniamo bene informati?
Una risposta del tutto esauriente appare impossibile, data la contradditorietà delle altre fonti del tempo, narrative e documentarie.”
“L’imperatore, nel testo del reclamo contro Cremona del 1184 indica esplicitamente i promotori ed autori della fondazione della nuova città, la quale trasse origine de tribus locis, Gamunde vicelicet et Meringin et Burguh: cioè Gamondio, Marengo e Bergoglio….L’antica curtis di Rovereto venne inglobata topograficamente solo in un secondo momento nel centro demico posto in essere dalle decisioni dei consoli della Lega e dall’azione degli immigrati confluiti da Gamondio, Marengo ed altri luoghi… L’infelice campagna federiciana fece il resto, consentendo il libero afflusso di nuovi immigrati che portò il tessuto demico di Alessandria al complesso degli otto «luoghi» di cui parla il trattato di pace tra Federico imperatore e Tortona, citando gli «homines qui de octo villis infrascriptis apud PaJearh collecti sunt: Marenge, Gamundi, Ouilli, Four, Bergul, Solero, Wargnent, Rouere».
“Quale fu esattamente il luogo in cui sorse il nuovo agglomerato demico? Nei primi vent’anni della sua storia la nostra città presenta nelle fonti quattro diverse denominazioni: Alessandria, Cesarea, Palea, Rovereto…Il vero e proprio toponimo dell’area su cui sorse la civitas nova è però quello di Palea, che, secondo la più diffusa interpretazione corrente, vuole indicare il luogo palustre; nel nostro caso specifico la petraia fluviale alla confluenza tra la Bormida ed il Tanaro, od anche, come mi sembra abbia inteso Francesco Cognasso, il punto maggiore del modesto rialzo del· suolo che lo sottrae alle inondazioni ed agli impaludamenti,”
“Quando possiamo collocare la fondazione della nuova città, se ci fu un vero e proprio atto formale, come resta ancora da dimostrare?
Quando essa compare alla storia, il 3 maggio 1168, ha già raggiunto una configurazione topografica, urbanistica ed amministrativa definita, quale dimostra la sua struttura di governo della comunità secondo l’ordinamento consolare della collettività, di cui tuttavia non conosciamo i particolari burocratici. Certamente agirono nella configurazione dell’assetto civico le suggestioni della Lega; ma non dovettero mancare gli stimoli e le esperienze genovesi dal momento che la Superba si mostrò interessata alla costituzione della nuova città, prima in via privata, poi con l’intervento dal finanziamento pubblico”.
“L’insofferenza per le strutture feudali, che lo scontro tra l’imperatore e gl’insorgenti Comuni ha determinato anche nel ceto agrario, le aspirazioni associative dei nuclei rurali, che la proiezione d’istanze economiche nuove e di ricerca di traffico che pervadono il contado prospettano alla Lega e, di riflesso. alla Repubblica del Tirreno opportune, anzi tempestive possibilità di stimolo, d’intervento, di coordinazione. Anche Genova sa, per le esperienze acquisite in Liguria, in Provenza, in Sardegna, in Oltremare, come suscitare fermenti ribellistici, determinare moti più o meno spontanei nella richiesta di nuovi ordinamenti di governo. L’area della confluenza tra la Bormida ed il Tanaro nel cuore del Monferrato, dove confinano i limiti di diocesi diverse, di diverse professioni di obbedienza tra papa ed antipapa, e dove una serie di curtes regie controlla il tenitorio, ora in sintonia ora in dissonanza con gl’interventi sia marchionali sia imperiali. rappresenta un settore facilmente vulnerabile.”
“Oggi [la fondazione di Alessandria] a noi appare, ed è nella storia, un grande evento. Allora fu una semplice mossa politico-militare di sfondo economico, dettata dalla strategia del momento, che poteva anche esaurirsi con la vittoria di Federico.”


Commenta per primo