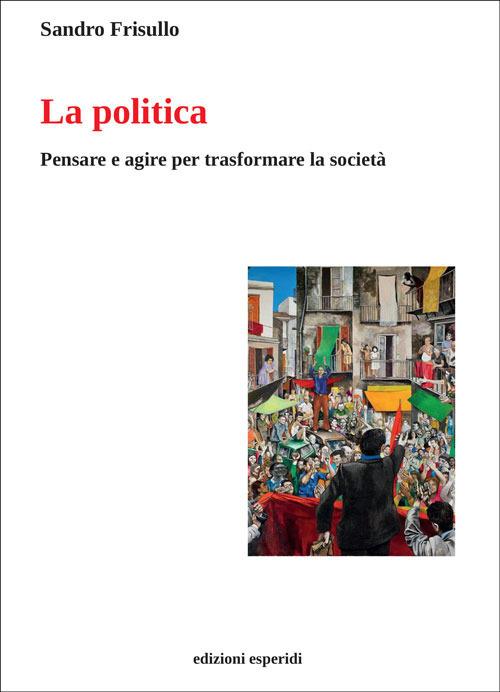 Anche in questo suo ultimo libro, “La politica. Pensare e agire per trasformare la società” (Edizioni Esperidi), è presente la grande passione civile e politica dell’autore. Sandro Frisullo se la porta addosso come un abito che non dismette nonostante il passare degli anni. Giovanissimo dirigente nazionale del Partito Comunista Italiano (membro del Comitato Centrale), è stato segretario politico di una importante federazione dello stesso partito, sindaco, consigliere provinciale e vice presidente della Giunta Regionale Pugliese. Ora, è ancora infaticabile dirigente di un partito di sinistra. Si comprende bene allora perché nel libro ci sia una grande delusione, e perfino dolore, per l’attuale declino e involgarimento della politica e il bisogno acuto di dare il suo contributo per tentare di trovare una via d’uscita. Lo fa ricorrendo ad uno ‘strumento’ assai poco utilizzato dall’attuale ceto politico di ogni orientamento: quello della riflessione e dello studio, per la ragione evidente che per governare la “complessità” la sola ‘ginnastica politica’ non basta, che per una formazione politica -piccola o grande che sia- la capacità di mobilitazione è poca cosa se non avviene alla luce di una direzione culturale, di una analisi aggiornata, di una prospettiva chiara.
Anche in questo suo ultimo libro, “La politica. Pensare e agire per trasformare la società” (Edizioni Esperidi), è presente la grande passione civile e politica dell’autore. Sandro Frisullo se la porta addosso come un abito che non dismette nonostante il passare degli anni. Giovanissimo dirigente nazionale del Partito Comunista Italiano (membro del Comitato Centrale), è stato segretario politico di una importante federazione dello stesso partito, sindaco, consigliere provinciale e vice presidente della Giunta Regionale Pugliese. Ora, è ancora infaticabile dirigente di un partito di sinistra. Si comprende bene allora perché nel libro ci sia una grande delusione, e perfino dolore, per l’attuale declino e involgarimento della politica e il bisogno acuto di dare il suo contributo per tentare di trovare una via d’uscita. Lo fa ricorrendo ad uno ‘strumento’ assai poco utilizzato dall’attuale ceto politico di ogni orientamento: quello della riflessione e dello studio, per la ragione evidente che per governare la “complessità” la sola ‘ginnastica politica’ non basta, che per una formazione politica -piccola o grande che sia- la capacità di mobilitazione è poca cosa se non avviene alla luce di una direzione culturale, di una analisi aggiornata, di una prospettiva chiara.
Con la “caduta del Muro” le forze progressiste sono state chiamate a sfide che finora hanno perso. E proprio da qui prende le mosse il libro. Suddiviso in due parti, la seconda contiene per così dire la documentazione della sua costante ‘militanza’ anche pubblicistica con la pubblicazione di suoi articoli su varie testate. Ma l’approfondimento culturale è contenuto nella prima parte, dove con agili capitoli si affrontano le questioni più complesse: dalle diseguaglianze generate dalla globalizzazione alla deriva oligarchica della politica, dalla crisi della democrazia alle conseguenze umane e sociali della rivoluzione digitale. Bisogna dire che se, da un lato, i troppi temi affrontati in poche pagine creano per la necessaria sinteticità grumi tematici aggiuntivi da sciogliere, dall’altro, però, testimoniano l’apprezzabile urgenza dell’autore di dar conto della complessità del mondo cercando di tralasciare il meno possibile, perché tutto contribuisce ad una migliore comprensione.
L’impegno a non derogare da un necessario rigore analitico e a fornire una bussola culturale nella estrema difficoltà e ampiezza delle questioni affrontate è stato, dunque, sicuramente rispettato. Convincenti sono le pagine riguardanti il processo di condizionamento della vita degli Stati da parte dei “grandi poteri finanziari, tecnologici e mediatici” e la conseguente forma che progressivamente ha assunto l’economia-mondo: vale a dire “il comando oligopolistico della finanza e l’uso capitalistico delle tecnologie digitali”. Efficace è la denuncia del progressivo impoverimento della nostra democrazia, del suo evidente rischio di trasformazione (in parte già avvenuta) in una “democrazia minima” o, addirittura, in una “democratura” di tipo orbaniano. Forse troppo perentoria -e bisognosa di ulteriore verifica- appare, specie alla luce della poderosa rivoluzione in atto della robotica e della I.A., l’affermazione che la nuova economia del web non “smaterializza” i processi produttivi.
Frisullo, in ogni caso, non elude la questione di fondo dell’intera sinistra e delle forze progressiste: quella del “Che Fare?” di fronte alla disumanità di un “capitalismo senza liberalismo”, di una politica ridotta a merce. Finora, data l’altezza della sfida e non avendo risorse teoriche e analitiche aggiornate con cui affrontarla, non pochi intellettuali di sinistra si sono arresi ad una deriva dottrinaria misticheggiante, ammettendo così implicitamente la vittoria inappellabile del capitalismo nel mondo reale. Mario Tronti, per esempio, teorico dell’ “autonomia del politico”, convinto dell’immanenza del divino in noi, pone l’istanza di una “metanoia collettiva, una trasvalutazione dei valori correnti” e Aldo Schiavone, marxista non dell’ultima ora, come ho già avuto modo di scrivere, dopo aver affossato il socialismo, ricorre ad un “progetto visionario”, “onirico”. E l’elenco potrebbe continuare a lungo. La risorsa principale della sinistra è diventata così la scorciatoia eticistica e moralistica che disattende l’avvertenza dei classici per i quali “la morale è una scienza frivola se non la si coniuga con la politica” (Helvetius), “una scienza puramente speculativa”, “un detto” e non “un fatto” (Leopardi).
Anche per Frisullo, come naturalmente per tutti, non è facile rispondere al che fare della sinistra in questa età di post-politica. In particolare nell’ultimo capitolo è però evidente lo sforzo di non abbandonare la strada del realismo, quella cioè di tenere insieme valori e concretezza storica, economia e politica senza subordinare questa all’altra. Cerca di tracciare i lineamenti di una possibile etica laica- impresa non da poco finora proibitiva per la sinistra-, cioè di un’etica che ricava valori storico-positivi senza cadere nel relativismo, che, insomma, riconosce il primato della vita positiva evitando il riduttivismo economicistico, che riesce a conciliare i diversi livelli (economico, politico, giuridico, morale) della vita sociale e i bisogni di breve periodo con quelli di lungo periodo.
Non c’è dubbio che la sfida per la sinistra -e per la sua sopravvivenza- sia proprio questa. Frisullo anche con questo libro ha dato il suo contributo, sapendo bene però che solo se diventa impresa politica comune il cambiamento può portare ai risultati sperati.
Egidio ZACHEO


Commenta per primo