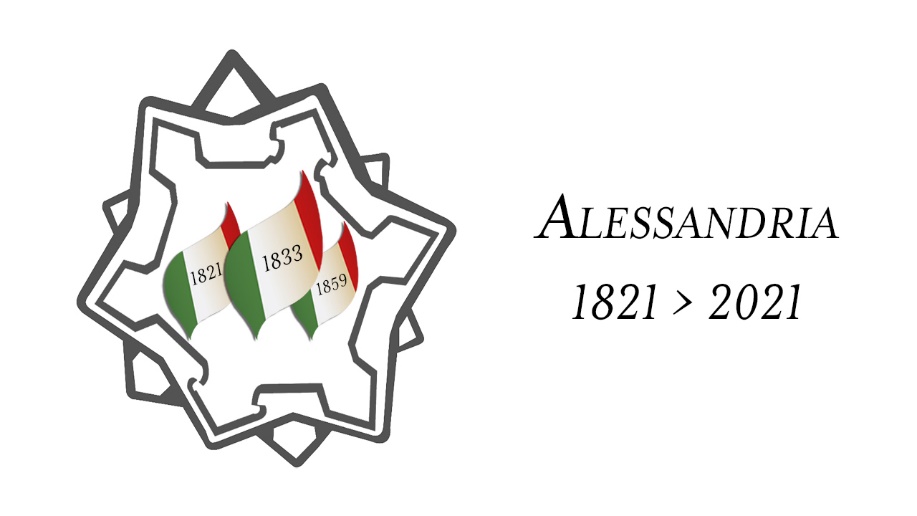

L’altro Piemonte per la Costituzione e l’Italia 1821 – 2021
10 marzo – Apertura formale
Palatium Vetus – ore 10.30
La diretta è visibile al seguente link:
https://alessandria1821.it/evento-10-marzo-2021/
<https://alessandria1821.it/evento-10-marzo-2021/>
Comunicato Stampa
Alessandria, 02-03-2021 La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, aderendo all’invito che le è pervenuto da un gruppo di soggetti culturali guidato dall’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Alessandria “Carlo Gilardenghi”, dalla Società di Storia Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, e dall’Archivio di Stato di Alessandria, con il coordinamento scientifico del prof. Guido Ratti, e la collaborazione del dott. Roberto Livraghi, intende sostenere un progetto di eventi e di appuntamenti che svolgerà, compatibilmente con i limiti impostici dalle misure anti-pandemia, nel corso di tutto l’anno 2021.
Hanno aderito al progetto diversi enti locali, tra cui in primo luogo la Provincia di Alessandria e i Comuni di Alessandria e Acqui Terme, insieme a un nutrito gruppo di istituzioni della cultura del nostro territorio: Accademia Urbense – Ovada; Amici del Plana – Alessandria; Associazione Cultura e Sviluppo – Alessandria; Biblioteca Civica “Francesca Calvo” – Alessandria; Centro di Cultura di Alessandria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Città Futura – Alessandria; Cittadella 1728 – Alessandria; Comitato di Alessandria dell’Istituto per la Storia del Risorgimento; Comitato di Novara Verbano Cusio Ossola dell’Istituto per la Storia del Risorgimento; Conservatorio “Antonio Vivaldi” – Alessandria; Fondazione Francesca e Pietro Robotti d’Italia – Fubine; Istituto per la Storia della Resistenza di Biella-Vercelli-Valsesia; Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola; Museo Etnografico “C’era una volta” – Alessandria; Novi nostra – In Novitate – Novi Ligure; Società Alessandrina di Italianistica – Alessandria; Università del Piemonte Orientale – DIGSPES.
“La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – afferma il presidente, notaio Luciano Mariano – ha aderito con grande interesse al programma di studi messo a punto in occasione della rievocazione dei moti del 1821 che rappresentano una pietra miliare nella storia del nostro Paese e l’inizio di un nuovo capitolo della storia europea. In questo contesto, il ruolo di Alessandria e della sua Cittadella è stato fondamentale e anche Palatium Vetus, sede del nostro ente, è stato teatro di quegli avvenimenti storici: da residenza del governatore sabaudo a sede del nuovo governo provvisorio della città. Giorni di grande fermento che hanno interessato tutto l’Alessandrino e numerose province del Piemonte attraversate dal fremito della Costituzione. Nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, il nostro auspicio è che questo progetto culturale possa realizzarsi in tempi brevi e in tutta sicurezza stimolando lo studio e l’approfondimento da parte di esperti e di ricercatori in materia. Un grazie sincero a tutti coloro che sono impegnati nell’iniziativa, con i migliori auguri di buon lavoro”.
“Benchè in buona misura offuscata per l’effetto monopolizzante delle celebrazioni del 150° dell’Unità nel 2011 e a causa della pandemia che ha bloccato o soltanto, si spera, ritardato le rare iniziative isolate previste per il bicentenario dei primi moti costituzionali liberali – ha dichiarato Guido Ratti – questa ricorrenza resta comunque di grandissimo rilievo nazionale, locale e internazionale. Di fatto il moto piemontese del ’21 – col suo logo “Monarchia, Costituzione, guerra all’Austria” – è la chiave del processo che si concluderà quarant’anni più tardi con l’unificazione della penisola ed è un moto che parte dalle periferie sabaude”.
Tutto è iniziato nella notte tra il 9 ed il 10 marzo 1821 ad Alessandria, in Cittadella e in città, ad opera dei militari Regis, Bianco, Palma, Baronis, Ansaldi e dei civili Rattazzi, Dossena, Appiani, Luzzi: poco dopo si sono mosse Pinerolo e Fossano e infine, costretta dall’iniziativa periferica, si è aggregata anche Torino con la “piccola corte” del principe ereditario. Da lì è partito il Risorgimento nazionale seguendo il copione definito dal proclama pubblicato in Alessandria il 10 marzo 1821 mentre dal pennone della Cittadella sventolava un primo tricolore che si richiamava esplicitamente all’Italia e alla guerra di liberazione dal predominio austriaco: una bandiera i cui colori erano molto probabilmente non il bianco rosso e verde ma quelli della carboneria, a strisce orizzontali, nera rossa e blu
Anche se spesso sottovalutata da letture in chiave prevalentemente locale, l’importanza di questo moto è dovuta tanto al suo carattere monarchico costituzionale più che rivoluzionario, quanto alla sua dimensione internazionale. Partita dal mondo settario carbonaro all’inizio del 1820 dalla penisola iberica, dopo aver contagiato l’Italia meridionale, l’insurrezione per la costituzione è approdata infine in Piemonte cumulando sconfitta dopo sconfitta principalmente ad opera dell’intervento austriaco.
Con “L’altro Piemonte per la Costituzione e per l’Italia” si vuole rendere Alessandria e l’Alessandrino protagonisti di una narrazione che s’è finora concentrata su figure di spicco come Carlo Alberto, Collegno o Santarosa e su corte e capitale sabauda; ma insieme “altro Piemonte” comporta una dilatazione ampia dei confini regionali per indagare i rapporti delle periferie subalpine, le tante “altre Italie” della penisola, protagoniste come l’Alessandrino di questa fase iniziale del Risorgimento; e di respiro ancor più ampio è il tentativo di seguire le strade degli sconfitti del ’21, comprenderne le esperienze e il contributo che hanno dato ad altri popoli, il valore aggiunto che sono stati col loro esempio di vita, per il processo unitario.
Non è dunque campanilismo rivendicare la funzione focale di Alessandria in tutta la fase epica del Risorgimento dal ’21 al ’33 e al ’59: funzione che eleva la fortezza e la città ad una dimensione non meramente simbolica di “altare della patria”: una funzione che probabilmente andrebbe meditata con attenzione nell’immaginare il futuro della Cittadella e della città stessa.
In fondo è proprio a questo che serve la storia: trovare nel passato ispirazioni utili per la soluzione dei problemi presenti.
Gli storici che hanno accettato di aiutarci in questa operazione storiografica sono una quarantina: un numero importante che testimonia l’interesse per una proposta non consueta. Una buona metà di loro lavora o ha lavorato in una decina di università italiane – da Napoli a Verona e ad Aosta per citare solo i vertici estremi – e uno appartiene all’Università greca di Tessalonica. Gli altri relatori provengono dagli spazi della solida ricerca storica locale, legata alle società e alle riviste storiche provinciali. A loro e alle loro ricerche va soprattutto il merito di aver posto le basi di un lavoro che proseguirà ancora a lungo col supporto delle più importanti associazioni storico culturali attive in Provincia e in Regione oltre che con le istituzioni universitarie territoriali.
Il percorso de L’altro Piemonte per la Costituzione e l’Italia 1821 – 2021 è suddiviso in due fasi: la prima avrà luogo il 10 prossimo 10 marzo e costituirà l’apertura formale della celebrazione del bicentenario del 1821 con le autorità patrocinanti e finanziatrici e gli istituti organizzatori.
La fase successiva, dei contributi scientifici e storiografici, sarà realizzata – grazie alla disponibilità confermata dai relatori – non appena le condizioni sanitarie del paese lo consentiranno secondo il tracciato indicato nella seconda sezione del programma allegato.
10 MARZO 1821 – 10 MARZO 2021. IL SIGNIFICATO DI UNA DATA
Il 10 marzo 2021 cadrà l’anniversario di un evento che 200 anni fa ha dato il via all’epopea del Risorgimento nazionale. In quella data, come è noto, un gruppo di militari, dopo aver preso nella notte il controllo della Cittadella di Alessandria e dopo averla aperta al manipolo dei “carbonari” alessandrini, innalzò il tricolore sul pennone della fortezza proclamando l’adozione della Costituzione spagnola nel Regno di Sardegna e l’istituzione di un governo col compito di guidare la monarchia sabauda sia sul percorso costituzionale, sia su quello dell’unificazione nazionale.
Firmato da quattro civili, Giovanni Appiani, Giovanni Dossena, Urbano Rattazzi (omonimo del più noto protagonista del “connubio” con Cavour) Fortunato Luzzi e da quattro militari, Guglielmo Ansaldi, Luigi Baronis, Carlo Bianco di St. Jorioz e Isidoro Palma di Borgofranco (cioè la Giunta provinciale provvisoria di governo) in nome della Federazione carbonara italiana, il proclama è decisamente esplicito: “È costituita una Giunta provinciale provvisoria di Governo, incaricata di provvedere alla salvezza ed ai bisogni della Patria ed al fine della Federazione. Essa è indipendente da qualunque altra Autorità, e non cesserà di esercitare gli atti del Governo sintantoché non siasi costituita una Giunta nazionale pel fine della Federazione. Si riterrà legittimamente costituita la Giunta nazionale quando il Re avrà reso sacra ed inviolabile la sua persona e legittimata la sua autorità come Re d’Italia colla prestazione del giuramento alla Costituzione di Spagna”.
La mossa e l’esempio alessandrini furono determinanti perché si estesero subito ad altre guarnigioni piemontesi costringendo i moderati torinesi Santorre Santarosa, Giacinto Provana di Collegno e Guglielmo Moffa di Lisio a rompere gli indugi col riluttante erede al trono Carlo Alberto e ad uscire allo scoperto sposando in toto l’indirizzo alessandrino.
Rivedendo queste giornate si coglie intanto un dato degno di riflessione e una peculiarità: i moti sono partiti dalla periferia, “dall’altro Piemonte”, mentre le narrazioni sono prevalentemente torinocentriche; i moti sono perlopiù opera e iniziativa di “peones” mentre le narrazioni privilegiano i (presunti) capi; la localizzazione piemontese dei moti è riduttiva ed errata perché il moto fu anche locale-regionale, ma il marzo 1821 in Piemonte fu soprattutto l’epilogo di un’epopea cominciata in Spagna nel gennaio del ’20 e proseguita in Sicilia e a Napoli con diramazioni precedenti e successive anche ben oltre questi confini; il termine “rivoluzione”, poi, applicato all’epopea del ’20-21 è sbagliato e fuorviante perché mai vennero chieste teste di sovrani e tantomeno si parlò mai di repubblica.
La dimensione mediterranea emerge perfettamente (assai più di quella locale-regionale) dal manifesto alessandrino del 10 marzo, da cui si desume anche come l’adozione della carta spagnola del ‘12 sia stata certo una scelta politica (tra i due modelli costituzionali possibili nell’Europa del primo ‘800 – lo spagnolo molto avanzato che piaceva ai “carbonari” e quello francese molto conservatore per il quale pare propendessero i cospiratori torinesi), ma soprattutto sia stata il tentativo estremo di alimentare con nuove energie il movimento costituzionale apertosi nel ’20 a Cadice dando allo stesso tempo una chance di successo alla “rivoluzione piemontese” che da sola non avrebbe potuto reggere (come di fatto non resse).
Un altro dato interessante del proclama alessandrino (che, si ricordi bene, precede ogni atto della giunta di governo di Torino) è l’uso del termine “Federazione” riferendosi prima di tutto alle società segrete italiane, ma contemporaneamente evocando l’immagine di un’Italia di stati alleati: un’unione, anche qui l’indicazione è esplicita, sotto la guida di Casa Savoia. In questo modo si chiarisce bene ed assume una dimensione piuttosto concreta il concetto di un’Europa dei popoli che si oppone all’Europa degli stati patrimoniali dei re di cui l’impero asburgico era l’esempio più eclatante.
Un’ulteriore indicazione interessante del proclama del 10 marzo riguarda i colori della bandiera inalberata in Cittadella duecento anni fa. Non pare si possa escludere del tutto il bianco-rosso-verde, ma il riferimento preciso e ripetuto alla Federazione fa pensare con maggiori probabilità ai colori azzurro-rosso-nero della bandiera delle sette carbonare.
E comunque da quella notte tra il 9 ed il 10 marzo 1821 – quando la guarnigione inalberò il tricolore costituzionale iniziando la rivoluzione piemontese ed attendendo invano l’arrivo del principe di Carignano determinato a condurre la generosa gioventù subalpina a battersi contro l’Austria – la Cittadella di Alessandria è diventata il simbolo della lotta degli Italiani per le libertà costituzionali e per l’indipendenza dallo straniero.
I Federati chiedevano ai Savoia una Costituzione, cioè un sistema di leggi fondamentali che rendessero i “regnicoli” (come si diceva allora) uguali di fronte allo Stato senza differenza alcuna di condizione sociale o di funzione o di confessione religiosa. E chiedevano di chiamare a raccolta gli italiani per la guerra contro quell’impero d’Austria che da Milano a Napoli controllava e decideva vita e destino degli italiani. Alessandria già tra il 1814 e il 1815 aveva subito e pagato l’occupazione di una grossa guarnigione imperiale e quindi non è difficile capire l’adesione locale al moto. Ma i Savoia, che pure qualche responsabilità ce l’avevano non solo per i tentennamenti di Carlo Alberto, richiesero subito un nuovo intervento austriaco. L’esperienza costituzionale piemontese non durò neppure un mese, ma i costituzionali sconfitti presso Novara e costretti alla fuga continuarono a lavorare anche dall’esilio – ove molti di essi persero la vita – per l’unificazione della penisola e per darle un assetto costituzionale.
In tutto questo processo iniziato il 10 marzo 1821, Alessandria seppe costruirsi un ruolo di primo piano, presto riconosciuto in tutto il Piemonte e presso i patrioti italiani. Nel 1833 ci riprovò con Andrea Vochieri e i mazziniani della Giovine Italia, poi altri democratici alessandrini diedero un contributo importante alle guerre d’indipendenza che portarono nel 1861 all’unificazione di quello Stato che Dossena, Rattazzi, Franzini, Ansaldi e gli altri patrioti del 1821 avevano sognato e per il quale avevano sacrificato la vita.
Alcuni numeri del 1821
Inquisiti: 3841, di cui:
Divisione Militare di Torino: 715 Divisione Militare di Alessandria: 687
Ufficiali: 606
Torino: 140 (città 33, provincia 107) Alessandria: 35 (città 13, provincia 22)
Sottufficiali e truppa: 682
Torino: 108 Alessandria: 25 (di più a Casale, Genova Saluzzo)
Dipendenti statali: 741
Alessandria: 33 Torino: 28
Borghesi: 1258
Alessandria: 342; Torino: 222; Novara: 196; Genova: 174.
(ad Alessandria 145 prosciolti, a Torino solo 49)
Studenti: 300
Torino 28; Genova: 22; Alessandria: 15 (dato riferito alle sole città)
Condanne alla pena di morte: 140
tutte in contumacia tranne tre: (il carabiniere Laneri, per i fatti in Savoia) e due ufficiali della Brigata Genova per l’occupazione della Cittadella: il cap. Giacomo Garelli e il cap. Isidoro Palma (i primi due vennero passati per le armi, mentre il terzo “essendo frutto di cattiva preda” venne rilasciato ed espulso dai regi stati: era naufragato vicino a Montecarlo mentre con una piccola imbarcazione cercava di raggiungere Marsiglia: la cattura a causa di una burrasca non era prevista).
Condannati alessandrini o comunque per i fatti di Alessandria
Morti entro gli anni ’20 in esilio o combattendo:
Giacomo Garelli, condanna eseguita luglio 1821
Giovanni Dossena, muore in Spagna 1827
Giovanni Appiani, muore in Spagna 1822
Carlo Franzini, muore a Londra 1828
Fortunato Luzzi, muore suicida In Inghilterra 1824
Alessandro Rattazzi, muore in Francia 1826
Urbano Rattazzi, muore a Barcellona 1822
Charles Barandier, muore in Grecia 1825
Graziati
Guglielmo Ansaldi, muore a Savigliano 1851
Luigi Baronis (con Mazzini nel 1834), amnistiato 1842
Angelo Carlo Bianco di Saint Jorioz, muore in Belgio 1843
Michele Regis, muore a Saluzzo 1851
Isidoro Palma di Borgofranco, ottiene l’indulto 1842
Programma

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
L’altro Piemonte per la Costituzione e per l’Italia
1821 – 2021
Istituto per la Storia della Resistenza “Carlo Gilardenghi”- Alessandria
Società di Storia Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti
Archivio di Stato di Alessandria
col patrocinio di
Provincia di Alessandria
Comune di Alessandria
Comune di Acqui Terme
Comune di Casale Monferrato
hanno aderito
Accademia Urbense – Ovada
Amici del Plana – Alessandria
Ass. Cultura e Sviluppo – Alessandria
Biblioteca Civica “Francesca Calvo” – Alessandria
Centro di Cultura di Alessandria dell’Università Cattolica de Sacro Cuore
Città Futura – Alessandria
Cittadella 1728 – Alessandria
Comitato di Alessandria dell’Istituto per la Storia del Risorgimento
Comitato di Novara Verbano Cusio Ossola dell’Istituto per la Storia del Risorgimento
Conservatorio Vivaldi – Alessandria
Fondazione Francesca e Pietro Robotti d’Italia – Fubine
Istituto per la Storia della Resistenza di Biella-Vercelli-Valsesia
Istituto per la Storia della Resistenza e della Soc. contemporanea nel Novarese
e nel Verbano Cusio Ossola
Museo Etnografico “C’era una volta” – Alessandria
Novi nostra – In Novitate – Novi Ligure
Scuola di Formazione forense “Giorgio Ambrosoli”
Società Alessandrina di Italianistica – Alessandria
[Archivio di Stato di Asti]
[Archivio di Stato di Verbania]
Università del Piemonte Orientale – DIGSPES
Università delle Tre Età – Alessandria
Programma
Parte I
10 marzo – Apertura formale
Palatium Vetus – ore 10.30
Introduzione
Guido RATTI, Una cittadella per l’indipendenza. Duecento anni dopo il marzo 1821.
Canto degli Italiani
Audio-video a cura del Conservatorio Vivaldi di Alessandria
Luciano MARIANO, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
Saluti istituzionali
(da Palatium Vetus)
Iginio OLITA, Prefetto di Alessandria
Gianfranco BALDI, presidente Provincia di Alessandria
Gianfranco CUTTICA DI REVIGLIASCO, Sindaco di Alessandria
Mariano SANTANIELLO, Presidente Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea
Elisa MONGIANO, Presidente Società di Storia Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti
Video istituzionale: Cittadella e città: il tricolore per l’Italia
Guido RATTI – L’altro Piemonte per la Costituzione e per l’Italia.
Inno alla gioia
(audio-video a cura del Conservatorio Vivaldi di Alessandria
Parte II
L’altro Piemonte per la Costituzione e per l’Italia
1821 – 2021
Sessioni scientifiche
NB Le relazioni scientifiche raggruppate in sessioni come da prospetto qui di seguito riportato, grazie alla paziente disponibilità e alla collaborazione dei Relatori, degli Enti patrocinatori e di quelli promotori, si svolgeranno in presenza dei relatori e del pubblico consentito non appena la situazione sanitaria del paese lo consentirà
1
Cittadella e città: il tricolore per l’Italia
Alberto Ballerino, SSAA, Alessandria, marzo 1821
Paola Bianchi, Un. Valle d’Aosta, Città e cittadella nel teatro dei fatti del 1821: fra eredità napoleoniche e nuovi slanci costituzionali
Roberto Livraghi, SSAA, Ideali, speranze e drammi del 1821. Vicende personali e collettive alla radice di una nuova classe dirigente alessandrina
Cesare Manganelli, ISRAL, Giovanni Dossena: lettere dall’esilio
Annalisa Dameri, Politecnico Torino, Demolire, ricostruire, potenziare. Città e cittadella: un rapporto complesso
Barbara Viscardi, Unitre Alessandria, I moti tra storia e letteratura: il Regalo del Mandrogno
2
A monte della “révolution piémontaise”
Renata De Lorenzo, Un. Napoli, Tra moti e rivoluzioni nel 1820-21: un primato napoletano
Gioia Angeletti, Un. Parma, Byron e il ‘circuito delle rivoluzioni’, 1819-23
Diego Saglia, Un. Parma, Shelley e il ‘circuito delle rivoluzioni’, 1819-23
Robertino Ghiringhelli, già Un. Cattolica Milano, Romagnosi e i conciliatoristi
Demetrio Xoccato, L’attività settaria in Piemonte alle soglie del 1821: dall’Adelfia ai Sublimi Maestri Perfetti
Dionigi Roggero, Il “parroco di campagna” Francesco Bonardi, attivista dell’organizzazione buonarrotiana dei Sublimi Maestri Perfetti
3
Dentro la “révolution piémontaise”
Paolo Alvazzi del Frate, Un. Roma Tre, Ferdinando Dal Pozzo tra diritto e politica
Bianca Montale, già Un. Genova, Emanuele Pes di Villamarina: nuova luce sui suoi memoriali “ad futuram memoriam
Pierangelo Gentile, Un. Torino, Vittorio Emanuele I, Carlo Alberto, Carlo Felice: questioni di famiglia alla luce del ’21,
Gian Paolo Romagnani, Un. Verona, La vigilia dei moti e l’illusione delle riforme. Il 1821 visto dal palazzo delle Segreterie di Stato
Dionigi Roggero, Gian Giacomo Francia, consignore e sindaco di Cella Monte, giacobino e segretario del Corpo Legislativo di Parigi
Guido Ratti già Un. Torino, Il ’21 immaginario: il berceau savoiardo dei Savoia nella bufera della “révolution piémontaise”
4
Il ’21 dell’altro Piemonte
Marco Dolermo, I moti del ’21 negli scritti di un ebreo progressista (sionista): Raffaele Ottolenghi (1860-1917
Fausto Miotti, SSAA, Il 1821 a Tortona
Renzo Piccinini, Novinostra-In Novitate, 1821: Pier Domenico Figini e Ferdinando Isola, due novesi ai moti di Alessandria
Carlo Prosperi, SSAA, La città e la provincia di Acqui durante i moti costituzionali del 1821
Elena Riva, Un. Cattolica Milano, Giuseppe Pecchio e il 1821
Andrea Testa, Alerino Palma di Cesnola: un esule del ’21 dimenticato
Marcello Vaudano, Ist.Storico della Resistenza Biella Vercelli, Biella verso l’unità d’Italia. 1815-1856. Un’esperienza di ricerca didattica
5
Il contesto nazionale e internazionale
Francesco Aimerito, Un. Piemonte orientale, Rivoluzione e controrivoluzione nella legislazione giudiziaria degli anni ’20 dell’800
Renato Balduzzi, Un. Cattolica di Milano, Note sulla cultura costituzionale nei primi decenni dell’800
Roberta Lombardi, Un. Piemonte orientale, Giandomenico Romagnosi
Michele Rosboch, Un. Torino, Progetti di riforma delle comunità locali nella prima Restaurazione sabauda.
Isidoro Soffietti, già Un. Torino, Il progetto di riforma del sistema giudiziario del Regno di Sardegna e il suo fallimento (1820-1821)
6
Il lungo lascito del ‘21
Alberto Cavaglion, Il collegio Foa di Vercelli
Giancarlo Libert, SSAA, Una famiglia astigiana nel Risorgimento
Ezio Claudio Pia, Il Platano – Asti, Il Medioevo delle “piccole patrie” e la storiografia di epoca risorgimentale: il caso astigiano
Deborah Besseghini, Un. Torino, Carlo Vidua in Messico: le rivoluzioni e il futuro
Elena Borgi, Accademia delle Scienze Torino, Il “magnifico dono”. Carte, libri e manoscritti di Vidua all’Accademia delle Scienze
Davide Tropeano, Ist.Storico della Resistenza Biella Vercelli, Carlo Giuseppe Ferraris: l’esilio in Argentina fra scienza e impegno politico
7
Diaspora, ritorni e alte storie
Paolo Cirri, Com. Novara Ist. per la storia del Risorgimento, Carlo Alberto a Novara e lo scontro armato dell’aprile 1821
Lionello Archetti Maestri, SSAA, Una lettera di Giovanni Godetti dall’Africa nera
Daniela Bonino, Giuseppe Avezzana: da San Salvario a San Salvario 1821-1871
Giancarlo Libert, SSAA, Esuli del 1821 in Argentina
Roberto Alciati, Un. Firenze, Il ritorno in Italia dell’esule casalese Luigi Castagnone
Alma Novella Marani, [Lettura di Giancarlo Libert], Charles-Carlos Pellegrini: dalla Torino del 1821 alla Buenos Aires dei “caudillos”
Francesco Surdich, già Un. Genova, Caratteristiche e conseguenze della diaspora nel continente americano dei protagonisti dei moti del 1821


Buongiorno,
Ho visto con molto interesse il video su “L’altro Piemonte per la Costituzione e l’Italia 1821 – 2021”.
Scrivo per poter avere informazioni sulla lista degli inquisiti per i moti del 21.
Vorrei conoscere la voce bibliografica di questa lista per poterla consultare per intero.