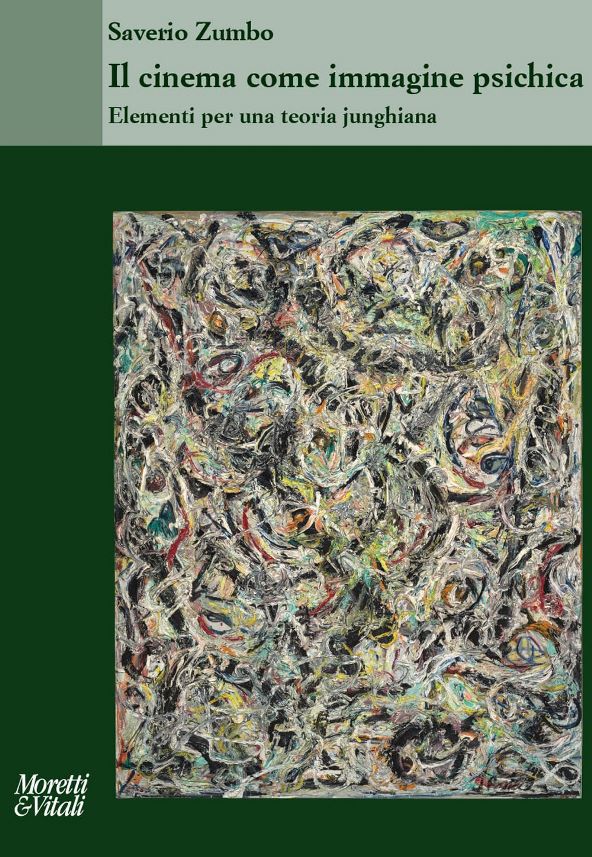 Alla fine del 2023 Saverio Zumbo – tra gli amici più impegnati a far vivere un cinema di qualità – e la discussione su di esso – in Alessandria, nonché docente di “Storia e teoria del cinema” presso l’Università di Genova – ha pubblicato un importante libro presso la Moretti & Vitali: Il cinema come immagine psichica. Elementi per una teoria junghiana (pagg. 198, E. 20). L’autore si era già segnalato per altri tre libri importanti, tra cui uno su Michelangelo Antonioni (Falsopiano, Alessandria, 2002) e uno sul “primo Kubrick” (Mimesis, Milano, 2018). Ma quest’ultimo libro mi pare il suo più importante, perché dà un contributo decisivo, certamente il maggiore in Italia, alla definizione di una metodologia della critica cinematografica, e anche del cinema in sé, di tipo espressamente junghiano. Conosco bene questo libro, che ho potuto discutere a lungo con l’autore, mio buon amico, nel suo farsi e poi nel suo insieme, non perché io potessi insegnare qualcosa a Zumbo in questo campo, in cui anzi mi è piaciuto imparare, ma perché la questione mi coinvolge fortemente come junghiano convinto da molti decenni.
Alla fine del 2023 Saverio Zumbo – tra gli amici più impegnati a far vivere un cinema di qualità – e la discussione su di esso – in Alessandria, nonché docente di “Storia e teoria del cinema” presso l’Università di Genova – ha pubblicato un importante libro presso la Moretti & Vitali: Il cinema come immagine psichica. Elementi per una teoria junghiana (pagg. 198, E. 20). L’autore si era già segnalato per altri tre libri importanti, tra cui uno su Michelangelo Antonioni (Falsopiano, Alessandria, 2002) e uno sul “primo Kubrick” (Mimesis, Milano, 2018). Ma quest’ultimo libro mi pare il suo più importante, perché dà un contributo decisivo, certamente il maggiore in Italia, alla definizione di una metodologia della critica cinematografica, e anche del cinema in sé, di tipo espressamente junghiano. Conosco bene questo libro, che ho potuto discutere a lungo con l’autore, mio buon amico, nel suo farsi e poi nel suo insieme, non perché io potessi insegnare qualcosa a Zumbo in questo campo, in cui anzi mi è piaciuto imparare, ma perché la questione mi coinvolge fortemente come junghiano convinto da molti decenni.
Il punto che m’interessa è questo: oltre che per l’esplorazione e aiuto della psiche sofferente nel profondo, ma non folle, che diciamo nevrotica; ed oltre che come formidabile forma di riflessione, dal vivo della psiche, sui problemi ultimi dell’uomo (in specie morali e religiosi), lo junghismo funziona anche come psicologia della cultura (nel caso in oggetto cinematografica)?
Direi di sì, in base a Zumbo, a un punto tale che avrei voluto che Zumbo proponesse il suo lavoro, nel sottotitolo, come estetica cinematografica junghiana. Ma giustamente Zumbo ha voluto restare, sia pure con libertà, nel suo contesto disciplinare.
Prima di procedere oltre mi piace provare a chiarire taluni punti, che mi riportano con forza da un lato a discussioni di mezzo secolo fa e più proprio con gli amici Adelio Ferrero, Roberto Prigione e Enrico Foà – protagonisti del Circolo del Cinema degli anni Sessanta – cui ora si connette, con lodevole e qualificato attivismo, il Circolo del cinema alessandrino “Adelio Ferrero”; dall’altro mi riportano a taluni massimi problemi della psicologia analitica, cui qui ci richiama l’amico Zumbo. A quel tempo, all’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso, c’erano due modi d’intendere la critica cinematografica.
Il primo, che qui Adelio Ferrero aveva reso egemonico tra amici e appassionati, tendeva a una critica delle idee che valutava i film come opere che esprimevano il senso del divenire collettivo, ad esempio le idee e speranze di individui, ritenuti rappresentativi di un’epoca, e in parte evocavano speranze ulteriori. L’opera d’arte valeva insomma in quanto esprimeva lo spirito della storia di un dato luogo e tempo, e al tempo stesso spingeva ad andare avanti. Questo modo d’intendere i film si rifaceva alla rivista “Cinema nuovo” di Guido Aristarco (di cui Adelio Ferrero era il più importante collaboratore dopo il direttore): rivista cinematografica legata alla filosofia hegelo-marxista di Lukàcs, che teorizzava il realismo critico (l’arte è valida perché rispecchia, anche a prescindere dalle posizioni soggettive di un autore, il divenire di tutto un mondo, e così ha un effetto progressivo pure sul divenire reale ulteriore).
Il secondo modo d’intendere la critica cinematografica, proprio del mensile “Filmcritica”, si rifaceva a un approccio teorico più attenta allo stile che all’ideologia, con apertura a stili, opere e visuali diversi, dagli autori più impegnati e colti a quelli di thriller o della “nouvelle vague”, connettendosi a un filosofo marxista italiano che aveva maturato un approccio neoempirista, che connetteva Marx più a Hume che a Hegel ,e che cercava nell’arte, e non al di là dell’arte, lo specifico dell’arte stessa: Galvano della Volpe, nella Critica del gusto (1964). Il noto critico comunista Lino Micciché aveva tale visuale.
Nel primo approccio tendevano maggiormente a riconoscersi quanti cercavano di rivitalizzare il marxismo occidentale e di sinistra, idealistico rivoluzionario, spesso “psiuppardi”, oltre che comunisti togliattiani; nell’altro i comunisti critici, che per quella via cercavano pure il dialogo con le avanguardie dell’Occidente.
In quel tempo, nel nostro contesto, cui Adelio Ferrero dava l’impronta, il massimo apprezzamento andava a Luchino Visconti, comunista e massimo esponente del neorealismo, più impegnato politicamente e come artista “rivoluzionario”, da La terra trema (del 1948, oggetto allora di una specie di culto) a Rocco e i suoi fratelli (1960) al Gattopardo (1963). Seguiva, quasi alla pari, il culto per Michelangelo Antonioni, soprattutto perché era sempre centrale, in lui, il tema dell’alienazione, vista come esistenziale, ma soprattutto “borghese”; mentre il terzo grande regista italiano di quegli anni, niente affatto neorealista almeno nelle opere più mature e rappresentative, Federico Fellini, era guardato con un certo sospetto e ironia, anche se era impossibile disconoscerne la grandezza, ma sempre – da parte di questi amici – con molte riserve. Solo io ed Enrico Foà, in quel vasto gruppo, amavamo Fellini più degli altri due “grandi”: il che era spiegato – o sussurrando o apertamente – nel caso di Enrico col fatto che era di formazione liberale “crociana” (si diceva a bassa voce), anche se sin dal 1965 posso testimoniare che votava PCI; e, nel mio caso, col fatto che sino a ventuno anni ero stato nietzscheano. Quando venne Aristarco a presentare 8 e 1/2 di Fellini, con apprezzamento e varie riserve, io intervenni sostenendo che era un assoluto capolavoro.
Comunque non si era rozzi neanche in quell’ambito, tanto che si apprezzava molto Dreyer, ma pure Bergman e, con riserva, anche Fellini.
Ma man mano che ci si inoltrava negli anni Settanta, si prese a scoprire pure la specificità della dimensione spirituale o religiosa in senso forte. In ciò certo Il Vangelo secondo Matteo (1964) di Pasolini ebbe un ruolo antelucano. La dimensione più interiore e spirituale interessa moltissimo me come Zumbo, anche in quanto convintamente junghiani. (O meglio, siamo junghiani anche per il ruolo che in noi ha tale dimensione spirituale profonda). Ma Zumbo vi immette, in questo libro, qualcosa di assai più rilevante, che concerne non solo la tendenza neospiritualistica dello junghismo, ma la specifica teoria psicologica in questione.
Questa psicologia junghiana ha al centro la scoperta della specificità e autonomia antropologica della “dimensione psichica”. I contenuti dell’inconscio non sono solo simboli sostitutivi di bisogni irrealizzati, o proibiti, repressi o autorepressi (specie sessuali in Freud, e di potenza in Adler), bisogni espressi e mascherati nei sogni: sono, invece, istanze antropologiche a priori, dette complessi. Potremmo dire che i complessi nello junghismo sono situazioni paradigmatiche di tipo antropologico, che non sono dipendenti dall’esperienza (o primariamente dall’esperienza), ma la preformano. Anche il complesso di Edipo, a sfondo sessuale e in origine legato al rapporto morboso del bambino piccolo con la madre e di latente conflitto col pdre per l’amore esclusivo della mamma, è archetipico. Ma ci sono pure tanti altri complessi, anche di tipo spirituale, d’anima, che per Jung sono irriducibili alle sole frustrazioni sessuali infantili, dotati di forte autonomia. Sono potenti immagini motrici legate al diventare quello che più intimamente siamo. Questa dimensione immaginale originaria si fa vedere o intravedere, e interagisce con tutto il resto della nostra vita.
Ora gran parte del cinema fa di tutto per mantenere nascosto quest’enigmatico mondo interiore, nella filmografia hollywoodiana o di tale matrice. Essa basa il suo narrare sulla totale immersione diretta da parte dello spettatore nella rappresentazione filmica. Si cerca di farlo sentire immerso nella storia raccontata, come se egli fosse dentro gli eventi, tanto più ritenuti veri quanto più risultino emotivamente coinvolgenti, insomma suggestivi in massimo grado, quasi ipnotizzati dallo spettacolo. Come quei film per cui canzonavano un poco le nostre mamme che dei film che a loro erano tanto piacuti dicevano: “A fasìa tànt piànse”.
Ma ciò che è narrato, al di là della suggestione quasi ipnotica che quel genere di film, anche nelle espressioni più alte, vuole trasmettere, è in realtà un insieme di immagini e situazioni che non vale solo in quanto dà un sentimento di realtà, ma si presenta come una realtà creata ex novo, conforme al nostro spirito del profondo: è – direi io – come la luce nei quadri di Caravaggio, che è interiore; oppure l’immagine universale che Michelangelo cercava, neoplatonicamente (alla scuola di Marsilio Ficino) di trovare nella pietra che scolpiva, che andava ben al di là della ritrattistica romano antica o anche dei modelli di perfezione greco-classici. Ora questo dar conto del vero nascosto, di quel che non si vede ma è sotteso, è stato un portato decisivo del film di avanguardia, da Fino all’ultimo respiro di Godard (1960) al resto. A un certo punto si vede un giovanissimo Jean-Paul Belmondo, ladro d’auto, che mentre guida si rivolge agli spettatori, mandandoli al diavolo, con deliberata rottura dello stile d’identificazione tra spettatore e film proprio dell’approccio hollywoodiano (e non) di cui si è detto. Il regista, di tal genere “veritativo”, insomma, non si nasconde più dietro al film, ma si mostra come tale, col suo pensiero. Spesso si fa un film nel film, o si rompe la narrazione con intervento che non cela, ma mette in campo l’autore.
Così nel film-documentario di Jean Rouch I maestri folli (2011) viene documentato un rito di possessione in tribù del Ghana, riprese nel 1955, in cui le immagini appaiono così vere che il regista stesso dichiara di partecipare della possessione. (Si tratta di un fenomeno che studiando certi rituali antichissimi come la tarantola, in Sud e magia de 1959, Ernesto De Martino ha ben documentato, e però anche sperimentato, talora sentendo vera l’irruzione del paranormale in questione).
Qui naturalmente il lettore può chiedersi legittimamente che cosa c‘entri tutto questo con Jung. C’entra perché questo proporre immagini dotate di una fortissima realtà psichica – causanti e non causate (almeno in ultima istanza), connesse ad una sorta di fondo psichico universalmente umano – apre a un mondo spirituale specifico, per così dire facendolo venire fuori. Questo è esattamente quello che Heidegger cercava nei presocratici e, allo stesso livello, nella poesia di Hölderlin: l’essere nella sua verità antropologica (detta esistenziale) e non nella sua quotidianità banale, o comunque niente affatto a tutti comune, detta esistentiva. Ma Zumbo ci dice, e documenta, che quest’universale in re, questo vero più profondo di e su noi stessi, ce lo fa vedere pure il cinema: tanto più il cinema che prova a dircelo, e la critica cinematografica che lo intenda.
Il più cospicuo esempio di ciò, nella sua analisi, mi pare che concerna Fellini (su cui un suo ampio studio con tale approccio secondo me sarebbe benedetto). Fellini, profondamente junghiano, analizzato per anni da un analista che ha portato per primo più di ogni altro Jung in Italia, Ernst Bernhard, di ciò ha fatto tesoro. 8 e 1/2 al proposito è una miniera. Il film stesso è costruito come uno straordinario esempio di immaginazione attiva. Su ciò Zumbo dice molte cose interessanti approfondendo testi di Marie-Louise von Franz (fedelissima e profonda continuatrice di Jung), e del misticheggiate antropologo aperto al sufismo iraniano, Henry Corbin.
Prima di cogliere che significhi per il cinema e nel cinema quest’immaginazione attiva, ricordo brevemente che cosa essa sia nello junghismo. Si tratta di un metodo analitico elaborato da Jung, che si affiancava a quello delle “libere associazioni” spontanee che il paziente, in analisi, fa associando tutto quel che gli viene in mente, in modo sempre più disinibito, in riferimento a propri sogni (nell’approccio junghiano anche connettendoli, in taluni casi, e con un piccolo aiuto dell’analista, a miti perenni dell’umanità coevi, con processo chiamato “amplificazione”). Ora come in analisi ci si abbandona – senza freni inibitori, man mano che passano settimane mesi o talora anni – ai propri sogni, accompagnati dalle “libere associazioni”, e così si fa emergere ciò che era represso ma latente, allo stesso modo, senza l’analista, si può fare anche a occhi aperti, lasciando l’immaginazione libera di scorazzare come un cavallo selvaggio su un grande prato. Il famoso Libro rosso (postumo, 2009) di Jung, composto e da lui illustrato tra vigilia della Grande Guerra e sua fine, e limato sino al 1928, era un esempio, anzi il primo disvelamento, di questa immaginazione attiva. Si tratta di un metodo per molti junghiani non privo di pericoli (in cui certo incorse pure Jung tra 1913 e 1916) perché l’abbandonarsi alle immagini che vengono su dall’inconscio ci può pure fare “uscire pazzi”, e infatti Jung stesso, nel richiamato 1913/1916, cercava di prendere le sue misure di cautela facendo tali forme di abbandono, al fantastico spontaneo, dopo esercizi di Yoga e così via. Persino l’Ulisse (1920) di Joyce è un’opera del genere, che proprio Jung, nel 1932, vide come grande romanzo di svelamento del nostro fondo oscuro ai limiti della schizofrenia. Ma sia o non sia ciò pericoloso, l’apporto che può dare l’immaginazione attiva allo svelamento dell’Essere più profondo in noi è grande.
Così in 8 e ½ Jung – certo usando una trama di massima –lascia che la sua anima di regista, presente quasi in prima persona, scorazzi in lungo e in largo, facendo venir fuori quelle immagini interiori fissate in lui almeno dall’infanzia e fanciullezza: quei “personaggi” immanenti in ciascuno che Hillman chiama il nostro “piccolo popolo” interiore: personaggi che alla fine del film tornano in una sorta di girotondo finale, come se il regista ci dicesse: “Ecco, io sono tutto questo. Ecco il mio Essere”. Per Zumbo pure l’amato pittore junghiano Jackson Pollock, il cui quadro Occhi nel caldo (1946), è in copertina, era uno così. La strana immagine è visione del suo Essere psichico profondo, non tratta “da fuori”, ma “da dentro”. Come Zumbo ci ricorda pure nelle ultime parole del libro.
Tutto ciò a me sembra molto interessante e anche molto fecondo concettualmente e psichicamente.
di Franco Livorsi


Molto molto interessante, fecondo di stimoli e liberatorio
Grazie