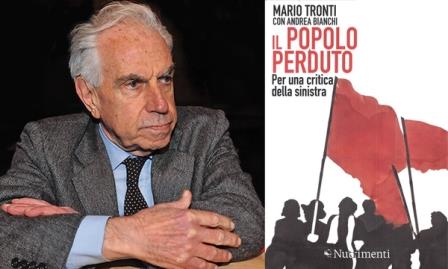 “Città Futura” nei giorni scorsi ha già proposto un bell’articolo di Mauro Calise su Mario Tronti[1], pensatore e politico di matrice marxista di sinistra recentemente scomparso. In poche e chiare righe Calise ha saputo dire quali siano stati i tratti fondamentali di un pensiero che ha palesemente anticipato ed ispirato parte non piccola della contestazione degli anni Sessanta in Italia, e che ha poi avuto sviluppi interessanti sino a noi: l’operaismo marxista (innanzitutto), e poi il decisionismo “di sinistra”, e la stessa nuova religiosità interiore. Tronti è un autore che leggo molto volentieri da una vita, spesso in appassionato dissenso. Nei giorni scorsi sono pure andato a vedere i titoli delle pubblicazioni di Tronti, in commercio e non, tramite Internet, notando che ne conosco bene parecchi, e altri meno. Provvederò al più presto anche su ciò. Non vedo anzi l’ora di poterlo fare, per ragioni che non starò qui a spiegare in dettaglio, ma che forse emergeranno dal contesto.
“Città Futura” nei giorni scorsi ha già proposto un bell’articolo di Mauro Calise su Mario Tronti[1], pensatore e politico di matrice marxista di sinistra recentemente scomparso. In poche e chiare righe Calise ha saputo dire quali siano stati i tratti fondamentali di un pensiero che ha palesemente anticipato ed ispirato parte non piccola della contestazione degli anni Sessanta in Italia, e che ha poi avuto sviluppi interessanti sino a noi: l’operaismo marxista (innanzitutto), e poi il decisionismo “di sinistra”, e la stessa nuova religiosità interiore. Tronti è un autore che leggo molto volentieri da una vita, spesso in appassionato dissenso. Nei giorni scorsi sono pure andato a vedere i titoli delle pubblicazioni di Tronti, in commercio e non, tramite Internet, notando che ne conosco bene parecchi, e altri meno. Provvederò al più presto anche su ciò. Non vedo anzi l’ora di poterlo fare, per ragioni che non starò qui a spiegare in dettaglio, ma che forse emergeranno dal contesto.
Ma intanto dire qualcosa “a ruota libera” su Tronti e sulla corrente “operaista”, di cui fu dall’inizio esponente di primo piano, parlando un po’ da testimone e un poco da “marxologo”, ma senza i limiti ovvi di spazio che un quotidiano impone ai suoi collaboratori permanenti (come “Il Mattino” a Calise), non mi pare vano. Per ora propongo un “semilavorato”, ma in futuro penso che commenterò taluni testi trontiani che vorrei approfondire.
Io leggo e medito Tronti da sessant’anni, e cinquantanove anni fa l’avevo pure conosciuto in un’occasione non da poco per la corrente da lui impersonata (l’operaismo marxista in Italia), come dirò. Tronti aveva preso a farmelo conoscere, sin dal 1962, Gianfranco Faina, che allora aveva insegnato un poco nella media superiore in Alessandria ed era poi diventato un mio vero amico.
Anche Faina, di Genova Sampierdarena, era un bel personaggio. Era stato segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana a Genova tra 1954 e 1956, ma nel 1956 era stato espulso dalla sua Sezione per essersi opposto totalmente – com’era nel suo stile da crociato permanente della causa in cui di volta in volta credesse – all’intervento con i carri armati contro gli ungheresi, che nel ’56 avevano preteso di rendersi neutrali da Mosca e che furono allora massacrati a migliaia, e forse in decine di migliaia, dai “compagni sovietici”. Mi raccontò egli stesso taluni particolari che sarebbe stuzzicante riproporre qui, ma non lo faccio perché il ricordarli in dettaglio mi porterebbe troppo fuori strada.
Poi Faina aveva scoperto Rosa Luxemburg, con la sua teoria-prassi dell’azione diretta, prevalentemente spontanea (ma anche non), nella storia, da parte delle masse: il massenstrik, lotta “naturale” delle masse contro lo sfruttamento, per lei da intendersi come chiave di volta del divenire sociale e, in specie, della rivoluzione anticapitalistica. Sono certo che la pensasse generalmente così anche Karl Marx. La coscienza di classe rivoluzionaria non sarebbe portata “dall’esterno” ai proletari, altrimenti appena capaci di sindacalismo di mestiere (“tradeunionista”), da un’avanguardia politica antagonista, o partito “veramente socialista”, o “veramente comunista”, che si coaguli attorno al socialismo “scientifico”, come aveva detto Lenin nel Che fare? (1902), ma crescerebbe via via nel loro seno. Ritenere il contrario, come se i semplici lavoratori fossero nell’insieme dei poverini da illuminare da parte dei pretesi coscienti, per Rosa Luxemburg era “reazionario”.[2] In proposito per Faina e molti altri il testo centrale della Luxemburg cui attingere era il libro Sciopero di massa, partito e sindacato, del 1906.
Tra il 1963 e il 1967, poi, uscirono due raccolte di scritti di Rosa Luxemburg fondamentali, che subito centellinai con straordinario interesse.[3]
Faina di tutto ciò si era entusiasmato da anni[4], mentre, intanto, subiva anche l’influenza della filosofia della scienza della scuola di Vienna, e, qui, dell’empirismo logico di Giulio Preti, il quale ultimo pochi anni prima aveva scritto Praxis e empirismo (1957), e quella del John Dewey della Logica come teoria della ricerca (1938).[5] Nonostante la sua tendenza al “pensiero-prassi” in rivolta, Faina aveva infatti un forte interesse per la filosofia come scienza e per il pragmatismo. Quel che gli sembrasse “vero”, lo voleva subito “fare”. L’attivismo faceva parte della sua personalità profonda. Faina conosceva pure a fondo il Marx economista, con tutte le sue complesse formule ed elaborazioni, che per lui erano scienza in senso forte, seppure di tipo aperto ed incompiuto (anche se più oltre divenne anarchico situazionista, con uno spirito che mi ha fatto sempre pensare a quello di Carlo Cafiero[6], che per me era stato tale e quale). Appassionatosi di Rosa Luxemburg, e leggendo Marx in quella chiave – come insuperato scienziato economico-sociale “puro” – Faina sin dalle origini si era aggregato ai “Quaderni rossi” di Raniero Panzieri, nati a Torino nel 1961, e quasi subito, più o meno altrettanto, di Mario Tronti.
Panzieri, la cui opera “omnia” è stata curata dal mio compianto amico – ed ex collega presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano – Stefano Merli, era stato una figura molto importante della sinistra socialista.[7] Nenni, dal 1955 alla ricerca di una via autonoma dai comunisti, aveva voluto Panzieri come direttore del mensile del P.S.I. “Mondo operaio”.
Ma il legame forte Raniero Panzieri l’aveva avuto soprattutto con Rodolfo Morandi, storico vicesegretario nazionale del P.S.I. di Nenni, figura di straordinario spessore morale, e organizzatore geniale, che aveva riorganizzato quel partito tra il 1948 e la morte (1955), in un rapporto strettissimo ma emulativo con i comunisti, tendente alla riunificazione “socialista” della sinistra in un contesto che oggi si direbbe socialista democratico “di sinistra” (però comprensivo dello stesso leninismo). Rodolfo Morandi, di cui a suo tempo la Einaudi pubblicò le opere, e che oggi è un personaggio dimenticato, ha avuto un percorso straordinario da Mazzini al leninismo, in base ad una tendenza profonda che io oggi direi di “socialismo etico”. Rodolfo Morandi è stato studiato con cura in un libro che è il solo importante su di lui, Rodolfo Morandi. Il pensiero e l’azione politica (1971) da Aldo Agosti. Si tratta di opera che io pure discussi nel 1972 sul settimanale nazionale del PSIUP (“Mondo nuovo”), accentuandone, un poco strumentalmente, il filocomunismo in vista di un’unificazione tra PSIUP e PCI che – pur non ancora decisa – mi pareva, e presto risultò essere, ormai inevitabile per il PSIUP (1964/1972), diventato per molte ragioni elettoralmente marginale tra 1970 e 1971. In quella discussione, certo di un qualche significato nella piccola storia del PSIUP (storia poi raccontata da Aldo Agosti alcuni anni fa in altro libro importante edito sempre da Laterza, da me discusso qui e poi su “Critica marxista”)[8]. Al tempo del libro su Rodolfo Morandi, dopo il sottoscritto, su “Mondo nuovo”, intervennero sia il segretario del partito (Tullio Vecchietti) che l’inquieto vulcanico oratore, giornalista e politico Libertini.
Lucio Libertini, dal percorso molto travagliato che gli fece attraversare tutti i partiti della sinistra dai socialdemocratici di Saragat a Rifondazione Comunista, nel 1958 pubblicò, con firma sua e di Panzieri, alcune tesi sul controllo operaio della produzione, subito criticate dai comunisti.[9] Si riscopriva la democrazia operaia come possibile via al socialismo alternativa al comunismo di stato come alla socialdemocrazia riformista.
Quel testo del 1958, firmato insieme da Raniero Panzieri e Lucio Libertini, può essere inteso come la nascita dell’operaismo marxista in Italia, anche se nel nostro Paese prima del 1915, più o meno tra il 1900 e la Grande Guerra (ed anzi sino al 1926), si era già sviluppata la corrente operaistica del sindacalismo rivoluzionario, sorelliano e non sorelliano, tanto che quando nel 1974 divenni contrattista presso la cattedra di “Storia delle dottrine politiche” a Scienze Politiche presso l’Università di Torino, cattedra tenuta da Gian Mario Bravo – che aveva apprezzato un mio vasto saggio, Lenin in Italia, sul leninismo nella cultura della sinistra italiana, pubblicato nel 1971 su “Classe”, la bella rivista che Stefano Merli pubblicava allora presso l’editore Dedalo[10] – e Bravo m’invitò a scegliermi un argomento solido di cui occuparmi per alcuni anni invece di passare da un tema all’altro come allora nel mio muovermi ancora da politico appassionato io facevo, gli avevo detto che avrei volentieri lavorato, per il tempo necessario, ad una possibile storia dell’operaismo marxista in Italia, appunto da Arturo Labriola ed Enrico Leone sino a Vittorio Foa, Raniero Panzieri, Mario Tronti e compagni. La cosa al compianto Gian Mario Bravo – che tanti contributi importanti ha dato in materia di storia del marxismo, dell’anarchismo, del socialismo e del comunismo, pur con l’approccio marxista-leninista e a lungo filosovietico che gli era proprio – non interessò. Mi disse che era meglio scegliere un personaggio – con spessore teorico – poco studiato, per il mio futuro accademico. Allora mi occupai di Amadeo Bordiga (e in seguito di tante altre cose).
Il sindacalismo rivoluzionario in Italia era stato decisivo nel primo grande sciopero generale “nazionale” del 1905, nello sciopero generale di Parma del 1907, e certo era stato ben presente pure nella settimana rossa del 1914. Il sindacalismo rivoluzionario nel 1912 si era pure dato un’organizzazione più stabile, l’Unione Sindacale Italiana (USI), contro la CGIL, nata riformista nel 1906. Poi molti capi del sindacalismo rivoluzionario, in odio al tran tran dell’Italia giolittiana, allo scoppio della Grande Guerra del 1914-1918 erano diventati interventisti “di sinistra”, e poi, in una cospicua minoranza, o erano diventati “legionari” dannunziani o fascisti (Filippo Corrodi morì in trincea; Alceste De Ambis, già protagonista dello sciopero generale di Parma del 1907, divenne l’ispiratore della Carta del Canaro, la costituzione democratica e sociale di D’Annunzio al tempo dell’occupazione di Fiume del settembre 1919 – dicembre 1920, e non divenne fascista; uno dei quadrumviri della marcia su Roma, Michele Bianchi, era un ex sindacalista rivoluzionario, e così Edmondo Rossoni e Paolo Orano[11].
Nel saggio su Lenin in Italia (1971) parlavo molto anche del primo opus di Mario Tronti, Operai e capitale (1966), che raccoglieva importanti articoli e saggi dello stesso Tronti dal 1962[12]. In taluni passaggi di Lenin in Italia lo criticavo in modo eccessivo (soprattutto per l’enfasi un poco retorica in cui esprimeva il suo operaismo). Alcune cose su Tronti, lì, mi sembrano ancora giuste, e altre no (e anzi francamente “ingiuste”), ma un lettore appena un poco smaliziato avrebbe potuto cogliere facilmente il mio orientamento da “Odi et amo”.
Tronti già nel 1958 aveva ridimensionato l’importanza dei Quaderni del carcere di Gramsci per il marxismo teorico in Italia, in polemica con la linea fortemente idealistica presente nel marxismo italiano (togliattiano), in un volume a più voci che s’intitolava proprio La Città Futura. Saggi su Gramsci[13] (“Città Futura” era stato il titolo di un numero unico scritto totalmente dal giovane Gramsci, a Torino, alla fine del 1917: non ultima ragione, per cui io proposi “Città Futura” come nome della nostra associazione politico-culturale, e poi sito e giornale on-line, più di vent’anni fa in Alessandria). In alternativa al Gramsci dei Quaderni del carcere[14], considerato più o meno sotterraneamente idealista e riformista, Tronti proponeva una sorta di ritorno a Marx, in un primo tempo da lui riscoperto sulla scia di Panzieri. In sostanza con Panzieri e Tronti il socialismo marxista tornava ad essere socialista “scientifico”, ma in modo nuovo almeno dal 1961 in poi (come dirò).
Qual è l’importanza, e l’originalità teorica di questo marxismo “operaista”, e che cosa poi vi portò Tronti di suo, e perché e con quali esiti Tronti stesso poi si staccò parzialmente da esso giungendo “sin qua”?
Facciamo un poco di catalogazione concettuale. In Europa occidentale, a sinistra, il referente ideal-politico fondamentale, seppure mai unico, è stato il marxismo (come ha notato recentemente Aldo Schiavone[15]). Il suo materialismo, il suo economicismo e, dopo Marx, il suo statalismo sono tratti di ogni socialismo e comunismo, anche non marxista, dagli anni Novanta del XIX secolo in poi. (Ma ora a sinistra sembra imporsi un nuovo paradigma – sociale, ma pure ecologico e spirituale – come ho sostenuto qui, in testi poi riuniti nel mio libro Il Rosso e il Verde, nel 2021).[16]
Proviamo però a vedere la cosa storicamente. In tal caso, nella cultura del socialismo (compreso il comunismo), noi troviamo sempre come prevalenti due grandi correnti: il comunismo “leninista” e la socialdemocrazia riformista.
Il “comunismo” politico, al potere, è sempre “diventato” burocratico autoritario (covando però tale tratto anche in humus democratico-parlamentare, “riformista”, specie “nel” suo gran Partito, sempre costruito in modo fortissimo intorno all’apparato, che per quanto composto da tanti bravi compagni era pur sempre una burocrazia, sovrana all’interno, che dava la linea, quasi sempre approvata all’unanimità o al 95%, pure ai militanti operanti nelle istituzioni, e ai compagni di ogni ordine e grado).
E la socialdemocrazia riformista è sempre risultata pronta alla collaborazione con forze moderate ed anche ultra-moderate: collaborazione prima tattica e poi sempre strategica (sino agli eccessi noti del “così fan tutte”). Si tratta di un’oscillazione pendolare, tra “komunismo” e socialdemocrazia riformista, in fondo tra Longo e Saragat, così persistente nella storia da far cascare al poveruomo “le braccia”, per non parlar d’altro, perché sembra che si cada sempre dalla padella nella brace. (In seguito, nel XXI secolo, si è caduti persino “per terra”, senza socialismo, né leninista né riformista: insomma, “senza padella e senza brace”; il che non è allegro).
Ma c’è stata una grande corrente socialista che non ha accettato né il “komunismo” né la socialdemocrazia riformista, neanche “all’italiana” (né tantomeno lo “stalinismo socialdemocratizzato”, che il mio amico Merli attribuiva al PCI). Dico subito che non avendo spazio sociale e soprattutto politico e culturale sufficiente, questa corrente “terza” è sempre stata costretta, dopo taluni grandi tentativi di svincolarsi da entrambi quei potentissimi fratelli-coltelli, a rifluire in uno dei due, spesso passando persino dall’uno all’altro: o nella socialdemocrazia “saragattiana” o nel “komunismo” italiano. In generale questa corrente del “né questo né quello” ha sofferto, sia in ambito “komunista” che socialdemocratico riformista, essendo irriducibile a entrambi (in sostanza essendo “un’altra roba”, che poco si adattava a “quei due”, pur finendoci sempre dentro, o a ridosso, per carenza di “spazio politico” sufficiente o di capacità politica).
Questa “terza corrente” della sinistra, che io ho molto amato, ha avuto due anime: una la direi “massimalista” e l’altra appunto “operaista”.
Pur essendo stato il massimalismo caratterizzato anche da figure nobilissime ai vertici come alla base, alcune tra le quali io ho fatto in tempo a frequentare con vera amicizia, ritengo che il massimalismo – o comunque si voglia chiamare tale tendenza – sia stato la corrente sterile del socialismo: più una remora che una risorsa per la sinistra. L’errante (massimalista) era nobile d’animo, libero, franco, rispettoso e generoso; o lo era molto spesso. Ma non poteva essere mai né comunista né socialista: a volte perché “non ci arrivava”, e a volte perché era sanamente “oltre”. Il massimalismo – comunque si chiamasse – è stato la corrente degli scontenti “a vita” del “komunismo” come della socialdemocrazia riformista. Persino nel vecchio PSIUP alessandrino c’erano molti i quali si sentivano ed erano sentiti come “veramente di sinistra” perché criticavano i comunisti dal mattino alla sera, benché fossero spesso lontanissimi dai luoghi di lavoro. In sostanza il massimalismo, quale fosse o sia il suo nome, è stato l’area di quelli che hanno fatto di tutto per impedire alla strategia dominante della sinistra di cui facevano parte – o del “komunismo” o della socialdemocrazia – di raggiungere lo sbocco politico (rivoluzionario o riformista che esso fosse): una specie di “coscienza infelice” della sinistra.
Quando tale tendenza è riuscita a prevalere, sempre per un tempo breve, nel più rappresentativo partito o socialista o “komunista” di cui facesse parte, ne ha fatto fallire la strategia senza poter affermare la pretesa strategia propria. Così nel primo dopoguerra il massimalismo riuscì ad impedire ai socialisti riformisti alla Filippo Turati di andare al governo (necessariamente con liberali e popolari), ma così finì per tenere per mille giorni “sgovernato” il Paese, del che approfittò il fascismo; e riuscì ad impedire ai comunisti, che non volle raggiungere per tempo, nel biennio rosso 1919-1920, di nascere come partito di massa maggioritario nella sinistra, mentre i riformisti, esclusi, avrebbero potuto raggiungere Giolitti e Sturzo come troppo tardi provarono a fare nel 1923-1924, dopo la marcia fascista su Roma; e il partito socialcomunista di massa avrebbe potuto fare la sua parte di forza antagonistica. Potrei seguitare l’esemplificazione relativa al massimalismo come corrente che non è mai né antagonista né riformista; che sempre rifiuta sia l’antagonismo “vero” che il riformismo “possibile”, a tutto vantaggio della destra: ma dettagliare il tutto servirebbe solo ad attizzare polemiche inutili e ci porterebbe troppo fuori strada.
Ma in questa terza sinistra – intrecciata o no con massimalisti e neo-massimalisti – c’è pure l’ala del marxismo o socialismo o comunismo – non faccio questione di parole – operaista. Ho intuito sin dal 1963, in modo fortissimo, che essa era “altra roba”: una potenziale vera alternativa tanto al burocratismo comunista (autoritario come socialdemocratizzato) che al collaborazionismo spinto (socialdemocratico). Questa corrente, quando l’ho scoperta, mi ha sempre interessato. Senza saperlo lo stesso Maurizio Landini a mio parere ne fa parte (è un vero “operaista” nel senso del discorso che vengo svolgendo), e infatti secondo me sarebbe stato o sarebbe il solo possibile leader di una nuova sinistra di alternativa democratica con basi di massa, che però per la nobile vocazione di Landini al sindacalismo “di-vittoriano” puro, e un poco al vecchio sindacalismo rivoluzionario, non si farà (e quando Landini eventualmente tra anni lo vorrà, sarà troppo tardi). Da molti decenni sono lontano politicamente dall’operaismo marxista, ma persino ora leggo molto volentieri i libri della tendenza, compresi quelli di Antonio Negri[17]. Non ho mai concordato e non concordo, ma mi fanno molto pensare. M’interessano. E Mario Tronti mi ha interessato ed interessa più di ogni altro della tendenza.
All’inizio degli anni Sessanta l’operaismo, connesso pure al leninismo, mi era parso alternativa democratica e rivoluzionaria. Fu così da quando scoprii tale corrente. E per questo nel PSIUP dal 1964 al 1972 fui il responsabile del lavoro politico di fabbrica della federazione del PSIUP di Alessandria, e dal 1969 al 1971 feci parte della segreteria regionale piemontese del PSIUP, di cui era segretario Mario Giovana, col compito, dato a me ed a Franco Ramella, di coordinare il lavoro operaio del partito in Piemonte. Nel frattempo il mio quasi coetaneo Fausto Bertinotti, che perciò allora vedevo molto spesso, faceva parte per il PSIUP, dopo Gianni Alasia, della Segreteria regionale della CGIL. Dal 1963 leggevo e meditavo soprattutto Tronti, cui il mio amico Faina era allora legato. Ma nell’operaismo marxista c’era un humus comune, che veniva da Vittorio Foa e Raniero Panzieri.
Vittorio Foa nel 1961 aveva pubblicato l’articolo di fondo dei “Quaderni rossi”. Poi se n’era staccato perché per lui, che dopo essere stato nove anni “in carcere” sotto il fascismo, era stato soprattutto un sindacalista della FIOM, legatissimo al comunista proletario suo segretario generale (Giuseppe Di Vittorio), essere in radicale dissenso con la FIOM era impensabile. Foa aveva un’inquietudine ideologica totale, credo connessa al fatto che aveva un’intelligenza probabilmente vulcanica, ma il punto “fermo” per lui era il legame con i grandi sindacati operai. Pure con tale tratto, che in lui non venne mai meno, le memorie di Vittorio Foa (1991), che i suoi amici gli avevano quasi estorto, sbobinando testi che egli poi mise a punto, sono un libro assolutamente straordinario non solo nella grande memorialistica, ma anche nella storia dell’operaismo marxista.[18] Pure le opere di Vittorio Foa sarebbero da raccogliere con pazienza certosina. Ne varrebbe davvero la pena.
Ma che c’era di tanto originale e di politicamente rilevante nel marxismo operaistico?
Anche qui posso provare a fare un minimo di nomenclatura dottrinaria riferita al marxismo. Questo ha avuto due correnti, che anche in tal caso poi sono tre.
La più forte corrente è stata quella che di solito si chiama determinismo economico e, come essa l’ha soprattutto definito, “socialismo scientifico”. Il socialismo scientifico ha considerato il marxismo come una scienza, né più né meno di quella di Galileo, Newton o Einstein in Fisica. Il marxismo ci avrebbe dato la prima o definitiva fisica economica, guida sicura dell’azione politica. Così pensava Engels, più influente, anche suo malgrado, dell’alter ego, Karl Marx, di cui semplificava e approfondiva gli assunti, però in schemi spesso troppo rigidi. Così pensava Karl Kautsky. Così pensava Lenin, per il quale il socialismo come scienza rivoluzionaria del divenire sociale era la pietra angolare del partito socialista proletario o comunista (sin dal suo grande testo “giovanile” del 1894 Che cosa sono gli amici del popolo e come combattono contro i socialdemocratici[19]). Così pensava e avrebbe sempre pensato Bordiga[20]. Così provarono a tornare a pensare taluni marxisti teorici degli anni Sessanta e Settanta. Come Ludovico Geymonat (per difendere – per alcuni anni d’intesa con il nostro compianto grande amico di Tortona, Enrico Bellone – la “scienza” dagli assalti di un irrazionalismo ritenuto pericolosamente dilagante e in sé reazionario)[21]. Come Louis Althusser, che invitava a “rileggere il Capitale” di Marx ed era convinto che la storia, essendo fatta da tutti e da nessuno in base a “leggi” economiche reiterabili (scoperte da Marx), non avesse “soggetto”, come a suo dire pensava Lenin[22]. Come Lucio Colletti, che intanto svalutava del tutto il legame tra marxismo e idealismo, negando che la teoria di Marx, almeno dopo la prima gioventù, avesse avuto carattere dialettico, cioè volto a vedere la realtà come contraddittoria in sé, basata sull’urto degli opposti ad ogni livello, anche nella coscienza proletaria. Le leggi scientifiche anche del divenire sociale dovevano essere logicamente stringenti e storicamente verificabili, come in ogni scienza del tipo della matematica e fisica. Poi cercava di vedere se la teoria del Capitale di Marx sulla crisi necessaria e fatale del sistema, che renderebbe fatale la rivoluzione proletaria, avesse base scientifica[23]; alla fine si persuase che non l’aveva, ritenendo perciò ineluttabile la pura Modernizzazione, per cui si spostò sempre più a destra, sino a diventare berlusconiano (tanto che oggi in Parlamento la destra si riunisce in una sala chiamata “Lucio Colletti”). Persino il riformismo della “Critica Sociale” di Turati, nella misura non ampia in cui fu “teorico”, fu soprattutto di tal pasta “scientifica” (in tal caso ad essere fatale economicamente sarebbe stato il riformismo, per legge dell’evoluzione sociale complementare a quella dell’evoluzione naturale: legge, volta ad affermare un continuo progresso senza avventure “rivoluzionarie”, che il marxismo economico di Eduard Bernstein avrebbe dimostrato dal 1899, suscitando una polemica di Rosa Luxemburg, a ruota, espressa nel grande saggio Riforma sociale e rivoluzione).[24]
L’altra corrente del marxismo, oltre a quella del marxismo come scienza dell’economia e della connessa rivoluzione proletaria “inevitabile”, vedeva invece il marxismo come filosofia della liberazione umana: liberazione da uno smarrimento di sé socialmente dominante sotto il capitalismo – o alienazione capitalistica – rispetto a qualcosa di universalmente umano che c’è già nell’umanità in cammino, ma pure in ogni uomo, che è infinito per sé. In tal caso leggeva tutto Marx alla luce delle opere giovanili sino al 1844, in cui il legame con Hegel era stato più forte. Questo era idealismo (o almeno era un materialismo intriso di idealismo, in Italia esemplarmente incarnato da un grande studioso un po’ dimenticato, turatiano o socialdemocratico “di sinistra”, che ha dato contributi di prim’ordine sulla filosofia dall’antichità al marxismo, e che Togliatti e Gramsci discutevano dal 1920: Rodolfo Mondolfo[25]; a lui si deve persino la definizione del marxismo come “filosofia della prassi”, così comune nei Quaderni del carcere di Gramsci).
L’idealismo, da Hegel a Gentile, aveva spesso confuso l’universalmente umano – il Soggetto infinito che per l’idealismo filosofico è presente a priori, latente, in ognuno di noi – con lo Stato, asso piglia tutto nella storia (da Hegel a Giovanni Gentile): mentre per il cosiddetto hegelo-marxismo, che dal Marx del 1844 andava a Gramsci e Togliatti, e a Nicola Badaloni, lo Stato di tutti e di ciascuno sarebbe da fare, nella necessaria Prospettiva di emancipazione[26]. Questa linea era confluita in Gramsci, come sua costante (svolta a fondo nei Quaderni del carcere): ora con un’accentuazione più decisionistica intorno al 1917 (e forse dal 1914) e ora più democratico autogestionaria, tendente al potere dei consigli di fabbrica; o, infine, specie dal 1925 alla morte, volta a teorizzare il Partito liberatore: nei Quaderni del carcere “nuovo Principe”, nelle parti sul “Machiavelli” e la politica nello Stato moderno.
Il PCI dal 1926 e soprattutto dal 1944 vi si era riconosciuto, pur identificando stalinisticamente o leninisticamente – o come si vuole – il Gran Soggetto universalmente umano che fa la nuova storia col proprio partito. In tal modo, però, pur non attribuendo al marxismo il ruolo di scienza, si aveva una visione del mondo in cammino intesa come una specie di religione secolarizzata, in cui il Partito si fa portatore di una fede comune (una specie di mistica dell’Organizzazione “lavorista”, che ai veri comunisti “veniva naturale”). Ma questo poteva conciliarsi sia con un comunismo rivoluzionario più idealistico (ma pure fideistico, basato su una “concezione del mondo”) o con un comunismo socialdemocratico-leninista, che volendo tenere insieme il “fare la rivoluzione” e il “fare la democrazia” poteva essere sì “il sogno di una cosa” pasoliniano[27], ma anche un sogno che non arrivava mai, e che rischiava di non essere né carne né pesce, né comunismo di stato né socialdemocrazia riformista, nella realtà effettuale.
Ma il marxismo operaista cercava e forse cerca la risposta a entrambe le aporie. In che modo?
Confermava la decisiva idea che la storia, essendo soprattutto economica, non dipenda da capi o élites ma dal contrasto irriducibile tra datori di lavoro e lavoratori, tra borghesi e proletari, tra Capitale e lavoro dipendente. Ma invece di veder ciò come un che di legato ad automatismi economici, spostava e sposta l’accento dall’economia alla sociologia: dalle “leggi” economiche alle forze umani che da padroni o dipendenti – poco importa se padroni di Stato o privati – sono in campo. Le leggi dell’economia non dominerebbero la realtà, ma sarebbero il frutto dei rapporti reali tra forze umane operanti nell’ambito della produzione, distribuzione e consumo delle merci. L’economia era assorbita dalla sociologia; gli automatismi economici, o pretesi tali, venivano a dipendere, vengono ivi a dipendere, da ciò che accade ogni giorno nella relazione tra chi comanda e chi è comandato (nella società civile), e in specie nei luoghi di lavoro. Di lì veniva il riferimento al VI libro inedito del Capitale e ai Grundrisse di economia politica di Marx[28], enfatizzato da Tronti per primo e più di tutti gli altri. Si dice più o meno “basta” agli automatismi dell’economia che fa la storia, cui adeguarsi, da Engels a Althusser; oppure si sussume quel divenire preteso “oggettivo” a un soggetto collettivo sempre in atto, da cui le leggi economiche, come estrapolazioni astratte dalla realtà sociale, dipendono. La storia – per il nuovo operaismo marxista – non la fa né un singolo né un gruppo e nemmeno un partito, ma il produttore collettivo, che nel capitalismo “era” il “mondo operaio”, che sotterraneamente tutto muoveva (o “muove”). Sarebbero proprio gli operai, o proletari, a fare la storia, a un punto tale che la “vecchia talpa” della rivoluzione che tutto muove, persino l’antirivoluzione, che servirà alla rivoluzione, secondo la grande apostrofe del 1852 del Marx del 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, qui era presa per oro colato[29] Questa portentosa pagina era sempre stata percepita come una grandiosa metafora, più o meno retorica. Invece il marxismo operaistico la prendeva giustamente alla lettera (giustamente dal punto di vista di Marx, ben inteso). Le formule del Capitale ridurrebbero in leggi tendenziali astratte il moto concreto delle classi in conflitto nella società capitalistica. La teoria “scientifica” non dimostra la verità del movimento operaio nella storia, ma è esso a fondarla (per l’operaismo marxista): senza di che – vera o falsa – quella “scienza” nulla conterebbe. L’antagonismo sociale non sarebbe insomma “post rem”, ossia “dopo la cosa”, effetto dell’Idea comunista “diffusa”, in quanto scienza (da Engels a Althusser) o anche in quanto fede in un nuovo mondo possibile (da Gramsci a Berlinguer, fatti gli ovvi distinguo non da poco tra loro, ben inteso). Non sarebbe una costruzione dei creatori di storia (singoli, o partito, o partiti, o sette, o quel che si vuole), ma “in re” (nella realtà: già operante in grandissima parte nel sociale spontaneo, piaccia o meno a lor signori, anzi “a lor compagni”). La Storia si farebbe da sé persino curandosi poco di quel che fanno i vertici politici muovendo tanto la coda. Perciò la rivoluzione non si attende, ma si fa: è atto e in atto. Oppure non è niente. Quando vide il “niente” Faina si fece anarchico situazionista, e come tale morì anni dopo, per tumore, in carcere come terrorista, quasi tra le braccia di Toni Negri, come questi racconta in Pipe-line[30].
Su questa faccenda dell’autonomia o meno dei movimenti proletari di lotta, anche senza capi, si aprì la prima crisi dell’operaismo marxista in Italia, di cui Mario Tronti fu protagonista. Correva l’anno 1964 e il tutto ebbe per piccola scena la città della FIAT, che a Mirafiori allora aveva almeno sessantamila operai. Accadde nello studio-biblioteca di Panzieri, a Torino, in via Bligny. Dove tra il 1966 e il 1968 sarei stato più volte, poco oltre la morte di Panzieri (1964), insieme a Liliana Lanzardo, mia compagna di Università, e a suo marito Dario Lanzardo, che poi sarebbe diventato un cultore della fotografia come arte[31]. Ma qui va fatto un piccolo passo indietro nella storia.
La FIAT era il cuore del neocapitalismo italiano: duro in fabbrica nel corso del lavoro, ma sulla base di un sindacalismo di collaborazione aziendale intorno al sindacato interno (SIDA) legato alla UIL. I salari alla FIAT erano un po’ più alti che in altre aziende; c’era pure un certo paternalismo verso i dipendenti; ed una propensione politica socialdemocratica, ma tutto ciò era dato in cambio di un’obbedienza cieca pronta e assoluta delle maestranze sul lavoro, con controllo minuzioso uno ad uno anche in apposite cartelline, dei loro orientamenti politici e sindacali, come voleva il direttore tornato ai vertici dopo essere stato epurato per i trascorsi fascisti e rimasto poi in sella dal 1946 al 1966, Vittorio Valletta, superato poi dai nuovi diritti conquistati nell’autunno caldo del 1969: anche se Cesare Romiti avrebbe poi tentato, tanti anni dopo, di ripristinarne taluni metodi dopo la marcia dei dipendenti moderati, o dei quarantamila, del 14 ottobre 1980. Comunque alla FIAT dal 1955 non si scioperava più. Non si riusciva più a scioperare. Mi ricordo che Gianni Alasia, al tempo in cui ero nella segreteria regionale del PSIUP, mi raccontò che in quel 1955 una volta Nenni, segretario del PSI (ben prima della collaborazione di governo con la Democrazia Cristiana), venuto per un grande comizio, si era intrattenuto per più di un’ora con lui, allora segretario socialista della FIOM, per farsi raccontare come aveva potuto determinarsi quella storica sconfitta del sindacato di classe. “Mì l’hai cuntàilu per n’ura e passa, e chièl a smiava interesà. Ma poi al comizio aveva detto semplicemente che la reazione padronale aveva schiacciato momentaneamente il movimento dei lavoratori, che presto sarebbe tornato alla riscossa. Tutto lì …”
Ma il “1955” non durò sempre. Più oltre arrivò il miracolo economico, con tutti quei proletari venuti dal sud presto immessi nelle catene di montaggio dell’operaio “di massa” del tempo. E dopo un poco arrivò, sulla scia dei grandi moti pacifisti e operai degli anni Sessanta, una mezza rivolta operaia: i fatti di Piazza Statuto del 1962, in cui i lavoratori già della UIL avevano bruciato le tessere, e taluni avevano pure attaccato il sindacato collaborazionista della UIL provando a incendiarlo. Dominarono la Piazza per giorni, senza capi. I comunisti, con Diego Novelli in testa, parlarono di fascisti. Ma i “Quaderni rossi” vi videro l’inizio di un processo rivoluzionario politico di massa. Ricordo un comizio del giovane Canestri del 1962 – anno in cui per alcuni mesi fui funzionario, poco funzionante, del PSI ad Alessandria – a Ovada, in cui disse, entusiasmandomi giovanilmente, che gli operai avevano bruciato, in quei giorni, “le tessere della loro vergogna”. Quando una ventina di anni fa glielo ricordai, fece una piccola smorfia di dispiacere, per quell’estremismo da ventottenne (smorfia che, come sempre, andava a suo onore).
Tuttavia l’antagonismo sociale, che in effetti allora cresceva in ogni sfera, in anni splendidi di mutamento possibile della Storia mondiale, estremizzava pure l’estremismo. Panzieri vedeva sì sintomi di rivolta, ma riteneva che fossero potenzialità cariche di futuro che avrebbero potuto farsi processo rivoluzionario solo tramite il lavoro politico di avanguardie che operassero all’interno dei movimenti spontanei per molti anni. Mancava, per lui, una direzione politica conforme ai movimenti antagonistici spontanei. Nonostante l’operaismo in lui c’era, insomma, un fondo, morandiano, di leninismo. Invece Tronti e i suoi amici, tra cui allora era Faina, ritenevano che la classe operaia fosse intrinsecamente rivoluzionaria. Anche quando non scioperava affatto, l’antagonismo sotterraneo sarebbe stato incessante, manifestandosi in mille modi, dalle fermate improvvise al sabotaggio. “Noi”, mi diceva Faina, “partiamo dall’idea dell’autonomia politica della classe operaia” (poi questo si sarebbe detto “autonomia operaia”). O, come avrebbe detto in un intervento di cui io corressi solo l’italiano, un mio amico fornaciaio siciliano in un giornalino che facevo quando insegnai a Pontecurone (1965/1966), Natale: “L’operaio è il rivoluzionario dell’industria”[32]. Così Tronti uscì dai QR e fondò, nel 1964, il mensile “Classe operaia”. “L’unità” si chiedeva: “Chi li paga?”. Era la sua vecchia risposta al dissidentismo di sinistra, che era pure sua difesa di un’antica egemonia tra gli operai non regalata da nessuno, ma conquistata dal PCI sul campo, in lotte ininterrotte dal 1921, nell’antifascismo, nelle carceri e nelle isole di confino durante il regime, nella Resistenza e nella dura lotta contro la restaurazione del potere capitalistico in fabbrica negli anni Cinquanta.
Tronti aveva una visione complessa, evidente pure in un vasto saggio che concludeva Operai e capitale, ma già presente in un saggio sul “piano del Capitale” del 1963, che io lessi subito e che mi colpì moltissimo. Se la classe operaia è la forza dinamica prima dentro e contro il capitalismo e poi al di là del capitalismo, essa dovrebbe essere egemone pure nelle sue organizzazioni politiche, nei partiti e sindacati in cui si riconosca o cui dia un continuativo consenso, com’era il PCI, detto però – dagli operaisti – socialdemocratizzato o burocratizzato. Ma allora i partiti servivano?
Sì, rispondeva Tronti. Servono “tatticamente”. Sono “strumenti” del movimento delle masse proletarie in stato di rivoluzione permanente (a quel che riteneva l’operaismo, in specie quello da lui ispirato). I partiti hanno un ruolo tattico che non si può saltare e va spiegato. Per questo all’atto della rottura dei QR Panzieri disse che la linea di Tronti era “una scientifizzazione della politica di Togliatti”: una giustificazione del riformismo per la rivoluzione.
Fui pure testimone degli sviluppi di tale discussione. Accadde nel maggio 1964, quasi sessant’anni fa. Allora ci fu uno dei rarissimi convegni nazionali di “Classe operaia”, che si tenne a Piombino nella sede degli anarchici. Io ero del PSIUP, ma questo lì non disturbava nessuno. Giorgio Canestri, cui allora ero molto vicino, mi disse, un po’ ironicamente, che andavo a fare “il più”. Vidi così un Tronti molto vivace e dai capelli nerissimi. Aveva dieci anni più di me, che ne avevo ventitré appena compiuti. Gli interventi mi colpirono tutti. Conobbi allora pure Asor Rosa, al quale dissi di aver letto i suoi saggi su “Quaderni rossi” su letteratura e rivoluzione. “Come ti sono sembrati?”, mi chiese. Io gli dissi che mi erano piaciuti molto, ma che mi sembrava di cogliervi un fondo idealistico, hegeliano. Ridacchiò dicendomi che gli era già stato detto. Sentii pure gli interventi di Romolo Gobbi e di Romano Alquati, che dieci anni dopo avrei ritrovato come colleghi all’Università di Torino, che raccontavano di una FIAT – in cui nessuno scioperava – che sarebbe stata percorsa da mille forme di lotta sotterranee raccontate vivacemente, con un tale spontaneismo che Toni Negri intervenne per sottolineare il carattere decisivo del fare politica nei movimenti. E apprezzai molto Mario Tronti, che credeva in tutto ciò, ma lo connetteva a una complessa visione, in cui manifestava apprezzamento pure per Lelio Basso, che considerava “autenticamente marxista”, sebbene isolato.
Nell’ultimo saggio di Operai e capitale, Tronti, comunque, accentuava talmente la centralità operaia nella storia del capitalismo – come se Il Capitale di Marx avesse voluto dire La classe operaia (o, come si diceva allora, la “C.O.”) – che il capitalismo stesso avrebbe potuto essere inteso come sistema di “riproduzione della classe operaia”: era il Capitale a muoversi a calci sotto il perenne impulso della lotta operaia, impulso tanto più efficace quanto più forte fosse l’opposizione operaia al sistema, che così da essa sarebbe stato dislocato sempre più avanti (direi come la borghesia nel 1300 o 1400, che già sotto quel tardo Medioevo cresceva come un uovo nella gallina, in quel caso dalle uova “d’oro”). Di tanto in tanto qualche buon ostetrico accelerava la tendenza ad andare oltre il Capitale (per lui questi era stato Lenin, di cui forse in qualche momento sognò di essere emulo). Comunque su tale base – come ben presto Tronti teorizzò – anche nei partiti si doveva stare, sia pure dentro e contro, per dislocare il contesto sociale sempre più avanti. Così sin dal 1966 Tronti propose, senza smettere di una briciola – per allora – l’ideologia di cui ho detto, il rientro “tattico” nei partiti storici della sinistra, che per i suoi amici era il PCI (ma taluno di loro, come Asor Rosa, scelse il PSIUP, dove Dario Valori volle che entrasse nel Comitato Centrale).
Gli amici di Tronti che non lo seguirono, per i quali il momento politico partitico o statale era totalmente strumentale rispetto alla lotta diretta classe contro classe, formarono una tendenza che vede la storia sociale farsi da sé a livello molecolare, sotto la spinta del contrasto irriducibile tra lavoro salariato (o anche semplicemente servile) e Capitale, poco conta se privato o di Stato: il lavoratore agirebbe in modo tale da impedire il funzionamento dell’estorsione del plusvalore e profitto già durante il capitalismo. Per loro la struttura economico-sociale, intesa come operare delle forze sociali nella storia in prima persona, era ed è tutto, e la sovrastruttura, la politica politicante, i partiti, lo Stato, nulla: oppure un che di sempre marcio (a meno che non si pieghino ad essere un mero mezzo immediato dei movimenti proletari diffusi). Per Tronti – che nonostante le critiche di idealismo rivolte al gramscismo aveva un fondo idealistico (hegeliano) ed anche volontaristico (nietzscheano), trattenuto ma irriducibile – non poteva esserci nulla d’importante nelle forze politiche che non fosse la longa manus delle forze sociali; e, sotto il capitalismo, la longa manus sarebbe stata quella dell’operaio o lavoratore collettivo che, col suo antagonismo, muove il capitalismo stesso, provocandone sviluppo e crisi sempre più gravi sino al crollo. Ma non poteva neppure esservi antagonismo risolutivo senza quel gheriglio politico o della politica, che, in una visione che parta dai soggetti collettivi, doveva essere la classe politica, l’avanguardia politica solo apparentemente esterna, di una classe sociale, che sempre permea o permeerebbe la storia. Questa forza politica, questa soggettività pensante-volente, questo decisore collettivo, può sì avere un ruolo solo maieutico, essere cioè l’ostetrica della storia, ma se la donna (la classe che tutto fa) non deve morire di parto, l’ostetrica ci vuole, la sovrastruttura ci vuole, il partito di sinistra ci vuole, e forse pure il Welfare State, e ha un ruolo decisivo. Per lui Lenin era stato questo: il grande ostetrico del post-capitalismo proletario en marche. E infatti da senatore del PD nel 2017 commemorò in Senato, non so quanto capito e ascoltato, la rivoluzione di Lenin.
In Tronti c’era dunque un fondo idealistico di matrice hegeliana o hegeliano-attualistica (rinnegato, ma sempre risorgente), ma anche fortemente segnato dal volontarismo “nietzscheano” (non sul piano etico, ma della filosofia dell’essere come volontà). Perciò via via Tronti accentuò la centralità della tattica politica, scoprendo e teorizzando con grande forza il decisionismo di sinistra, una sorta di Carl Schmitt rimesso sui piedi, riletto e riproposto da sinistra, più o meno rovesciato nei fini come Marx aveva fatto con la dialettica di Hegel. Su ciò tenne pure un seminario a Torino, credo promosso da Norberto Bobbio, che allora era ordinario di “Filosofia della politica” nonché preside della Facoltà di Scienze Politiche, in cui muovevo i primi passi come docente. Il riferimento va al testo di Tronti Sull’autonomia del politico (1977). Ma testi specifici, su questo Schmitt riletto in chiave marxista di sinistra, sono nella raccolta di testi di Tronti Soggetti, crisi, potere (1980), numerosi e importanti[33].
Ma poi la Storia continuò ad essere sorprendente. Intanto, per la spinta della grande rivoluzione elettronica, cominciarono a sparire le grandi fabbriche. Sin dalla metà degli anni Settanta i trontiani “ortodossi” (o “eretici”, fate voi), elaborarono l’importante teoria dell’operaio “sociale”. Su ciò è da considerare soprattutto l’elaborazione di Antonio Negri.
Al tempo di Marx l’operaio tipico era stato “l’operaio professionale”, che ha un mestiere compiuto, una sorta di cultura delle mani importantissima (tanto da far ritenere a Marx totalmente possibile la dittatura del proletariato in senso stretto). Poi era arrivato il lavoro sempre più semplice e ripetitivo, come quello delle catene di montaggio, ossia l’“operaio massa”; questi poteva pure essere mezzo analfabeta, ma per fare poche mosse semplici e ripetute andava bene, e poteva benissimo passare dagli uliveti della Puglia o dalla Conca d’oro degli aranci della Sicilia in produzione. Ma poi era arrivata la rivoluzione elettronica. Il lavoratore era dappertutto e in nessun luogo, uomo in rivolta delle grandi periferie urbane, detto “operaio sociale”. Il capitale prova a asservirlo “ovunque”, così come esso è ormai “ovunque”, ma sarebbe ovunque anche la rivolta degli sfruttati (i quali col loro agire infrangono le leggi economiche del Capitale, come fossero in rivoluzione permanente), operai sociali o proletari puri che Antonio Negri e Michael Hardt poi chiameranno “moltitudini”[34]. Sull’operaio sociale, spesso in rivolta nelle periferie, e ieri a Parigi contro la riforma delle pensioni di Macron, specie dalla seconda metà degli anni Settanta del Novecento, puntava ora l’operaismo ex trontiano (o neo-trontiano), come l’Autonomia Operaia di Negri o l’anarchismo situazionistico di Faina, permeato dalla “vision” che ovviamente del tutto a prescindere da Faina ora si può vedere nel bellissimo film Joker (2019)[35], che certo lo avrebbe entusiasmato, come immagino possa aver entusiasmato Toni Negri. Si tratta però di vedere se non si tratti di jacqueries, come quelle furiose dei contadini poveri di secoli passati, troppo frantumati nel mondo del lavoro per potersi coagulare, se non tramite “profeti” redentivi, cioè “religiosi”. Comunque sarà il futuro a dircelo. Per ora i proletari senza grande fabbrica producono solo rivolte “selvagge”, che possono apparire rivoluzionarie, ma pure reazionarie, nel senso di suscitatrici di reazione di destra che poi non possono, se mai vogliano, sconfiggere. Su ciò lascerei per ora aperta la valutazione.
Tronti dal 1966 è sempre stato più lontano da tutto quest’antagonismo proletario teorizzato da ex compagni che lo hanno sempre rimpianto; è sempre più stato persuaso che se è vero che non c’è nulla nel “politico” (sia capo, élite, movimento politico o persino Stato) che non sottenda un mondo sociale corrispettivo tutto vivo ed operante anche senza di esso, è pure vero che senza “politico” adeguato “il sociale”, mondo operaio compreso, non va da nessuna parte. Il vero decisionista sa intendere quel che si fonde con i movimenti della società in cui si riconosce, e fare le sue scelte. [36]Ad esempio io sono stato colpito quando subito prima della formazione del secondo governo Conte lessi un’intervista di Tronti, mi pare all’”Espresso”, in cui diceva che il PD, imbarcandosi in tale avventura, stava compiendo un errore storico, valorizzando una forza per lui insensata come il Movimento Cinque Stelle. Io invece apprezzai la manovra di Renzi per fermare “l’irresistibile ascesa” di Salvini, ma mi colpì il modo di ragionare di Tronti, e oggi mi chiedo se non avesse ragione, e se l’eccesso di tatticismo, anche per ottima causa, non sia un grande inganno.
Al tempo stesso, però, “anche” Tronti doveva interrogarsi sul senso di tanta ansia palingenetica a lungo cercata nel soggetto collettivo. Ha seguitato a ritenere ottime le ragioni della rivolta anticapitalistica, da Lenin e compagni all’operaismo marxista del secolo scorso. Ma via via ha dovuto riconoscere che a vincere sinora è stato il Capitale e non il Lavoratore, il padronato e non il proletariato. Ha maledetto il mondo presente persino assai di più di quanto avesse fatto nel secolo scorso, pur riconoscendo che indietro non si può tornare. Il Capitale ha vinto creando “l’uomo nuovo”, che sarebbe “il borghese di massa”, tantoche ormai staremmo “dentro una storia nemica”. Le vecchie soluzioni sono tutte vinte e improponibili. Allora bisognerebbe opporre a questa sorta di mondo dell’uomo sempre più alienato, e che viaggia verso l’abisso, un uomo spirituale, che qua e là fa pensare all’antinomia che gli gnostici, nel mondo tardo antico, ponevano tra uomini “iliaci” (materiali) e “pneumatici” (spirituali”). La prima rivoluzione ritenuta latente, di cui la storia è o sarebbe per così dire incinta, sarebbe proprio la “rivoluzione spirituale”, neo-cristiana nel fondo, come spiegava in opera che sarebbe da discutere, Dello spirito libero (2015). La vera libertà non sarebbe quella partecipativa (almeno per ora), del vecchio per lui glorioso ma superato socialismo e comunismo, e neppure la libertà dal potere altrui, o indipendenza, di tipo liberista, ma pure liberale, bensì quella interiore, capace di svincolarsi dalla storia però sovrastandola. Marx mirava a un mondo senza plusvalore (non solo col plusvalore “allo Stato”), in cui tutto fosse di tutti, che come purtroppo per ora si è visto, “non è di questo mondo” (almeno “sin qui”), ma anche il Cristo mirava a uno status altro dal mondo dominante, a una libertà da questo mondo di tipo interiore.
Tutto ciò m’interessa immensamente, e vi tornerò di certo, perché mi sembra un percorso misteriosamente omologo al mio (che vi sno arrivato in un cammino da Nietzsche e Marx, e Lenin, e Rosa Luxemburg e tutto l’operaismo marxista, e pure comunista, a Jung e oltre Jung, in un processo in cui la renovatio sociale ed ecologica deve legarsi alla religiosità “della” e “nella” vita). Di ciò ciascuno ha naturalmente il diritto di infischiarsi totalmente, magari esclamando “Roba da matti!” come su Facebook ha scritto un caro mio vecchio amico dopo avermi sentito parlare sul mio libro Psiche e eternità. Alla ricerca del dio perduto (2022)[37], in un sito di You Tube di Huffington Post; ma a me l’esclamazione polemica non ha fatto alcun male, e mi ha anzi divertito. Compagni e non compagni, ormai siamo in molti a pensarla così. C’è sempre una Grande Riforma, o rivoluzione, comunitaria ed ecologica da fare, ma la prima rivoluzione, pure per renderla possibile, è “in interiore homine”, è spirituale; non già per originale “pensata” mia o d’altri, ma perché, o anche perché, per andare oltre ci vuole uno spirito che percepisca la propria infinità, libertà e solidarietà “a monte” prima che a valle della Storia. Questo ci dice ora madama la Storia. “È la Storia, bellezza!”.
di Franco Livorsi
- M. CALISE, Mario Tronti, il pensiero di un’epoca, “Il Mattino”, 7 agosto 2023 e “Città Futura on-line”, 9 agosto 2023. ↑
- LENIN, Che fare? (1902), a cura di V. Strada, Einaudi, Torino, 1971. Si confronti con: R. LUXEMBURG, Problemi di organizzazione della socialdemocrazia russa (1904) in: Scritti politici, Introduzione e cura di L. Basso, Editori Riuniti, Roma, 1967. ↑
- R. LUXEMBURG, Lo sciopero generale – il partito – e i sindacati (1906), Edizioni “Avanti!”, Milano, 1919. Il testo è riportato pure, con alcune variazioni, nell’esemplare: R. LUXEMBURG, Scritti politici, cit. Pure prezioso è: R. LUXEMBURG, Scritti scelti, a cura di L. Amodio, Edizioni Avanti!, Milano, 1963. ↑
- Lo stesso Circolo da lui fondato a Genova all’inizio degli anni Sessanta si chiamava “Rosa Luxemburg”. ↑
- L’op. cit. di G. Preti fu edita da Einaudi a Torino nel 1957 ed è stata riproposta, con prefazione di S. Veca, da Bruno Mondadori, a Milano, nel 2007. L’op. decisiva di Dewey, del 1938, fu pubblicata da Einaudi, a Torino, nel 1949. ↑
- P. C. MASINI, Cafiero, Rizzoli, Milano, 1974. Un altro modo per cogliere “questo spirito” è vedere e meditare il bel film di Vittorio e Paolo Taviani San Michele aveva un gallo, del 1975. Secondo me Faina era uno come il protagonista di quel film. ↑
- Su Merli rinvio pure a: F. LIVORSI, Stefano Merli. Lo storico e il socialismo, “Il Ponte”; a. LI, n. 12, dicembre 1995, pp. 75-97. Si vedano i seguenti volumi di RANIERO PANZIERI, da Stefano Merli curati: Lettere 1940-1964, a cura sua e di Lucia Dotti, Marsilio, 1987, assolutamente centrale, per capire la tendenza, ma pure per capire Tronti; Scritti scelti. 1944-1956, Einaudi, 1982; Dopo Stalin. Una stagione della sinistra 1956-1959, Marsilio, 1986; Spontaneità e organizzazione. Gli anni dei Quaderni rossi 1959-1964, BSF, Pisa, 1994. ↑
- Il libro cit. di Aldo Agosti su Rodolfo Morandi comparve presso Laterza a Bari nel 1971. Si confronti pure con: F. LIVORSI, Morandi oggi, “Mondo nuovo”, XIII, n. 44, 14 novembre 1971. Sul PSIUP: A. AGOSTI, Il partito provvisorio. Storia del Psiup nel lungo Sessantotto italiano, Laterza, 2013. Si vedano pure: F. LIVORSI, Dialogo sull’Italia repubblicana e sul PSIUP, “Città Futura on-line”, 13 e 19 settembre 2015; Una storia del Psiup, “Critica marxista”, n. 5, 2014, pp. 72-79. ↑
- L. LIBERTINI – R. PANZIERI, Sette tesi sul controllo operaio, “Mondo operaio”, n. 12, febbraio 1958. Furono criticate da esponenti comunisti, come Luciano Barca, sullo stesso mensile socialista. Anche Paolo Spriano su “l’unità” criticò tali posizioni. Il focus per i comunisti era la lotta contro il cosiddetto “regime” democristiano. ↑
- F. LIVORSI, Lenin in Italia. Le componenti della sinistra di fronte alla concezione leninista della classe e dello Stato, “Classe”, XIII, n. 44, 14 novembre 1971, pp. 325-389. Da confrontare, per coglierne l’origine, con i miei articoli “antelucani” in proposito: Gli scritti di Lenin sul socialismo italiano, “L’idea socialista”, n. 3, 3 novembre 1962; Attualità di Lenin, ivi, n. 4. 1970. ↑
- Per tutti questi aspetti sono da vedere: S. MERLI, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale: il caso italiano, La Nuova Italia, Firenze, 1972/1973, due volumi; G. PROCACCI, La lotta di classe in Italia agli inizi del secolo XX, Editori Riuniti, Roma (che nella parte centrale ricostruisce lo sciopero generale nazionale del 1905, il primo del genere in Italia); A. RIOSA, Il sindacalismo rivoluzionario in Italia e la lotta politica nel Partito socialista dell’età giolittiana, De Donato, Bari, 1976; R. DE FELICE, D’Annunzio politico. 1918-1938, Laterza, 1978: Mussolini il rivoluzionario. 1883-1920, Einaudi, 1965. ↑
- L’opera fu edita da Einaudi nel 1966. Ripubblicata con aggiornamenti nel 1972 e poi presso Derive-Approdi, Roma, 2006. ↑
- L’opera, a cura di A, Caracciolo e G. Scalia, fu edita da Feltrinelli, A Milano, nel 1959. ↑
- A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, Edizione dell’Istituto Gramsci a cura di V. Gerratana, Einaudi, 1975, quattro volumi. ↑
- A. SCHIAVONE, Sinistra! Un manifesto, Einaudi, 2023. ↑
- F. LIVORSI, Il Rosso e il Verde. L’idea della liberazione sociale, ecologica e spirituale dal XIX al XXI secolo, Golem Edizioni, Torino, 2021. ↑
- Per me era stato importante: A. NEGRI, Marx oltre Marx, Manifestolibri, Roma, 2003, ma pure, per ragioni che emergeranno, Pipe-line: lettere da Rebibbia, Einaudi, 1983. Poi ho letto, e recensito sul “Pensiero politico”, il libro di A. NEGRI e M. HARDT Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Rizzoli, Milano, 2002; Moltitudine. Guerra e democrazia nel nuovo ordine mondiale, ivi, 2004, e tutta quanta la fluviale autobiografia, che è pure una storia personalizzata del marxismo di sinistra dagli anni Sessanta a oggi: Storia di un comunista, Ponte alle Grazie, Milano, 2015; Guerra ed esilio. Storia di un comunista, ivi 2017. Mi è parso notevole pure: Dall’operaio massa all’operaio sociale. Intervista sull’operaismo, a cura di P. Pozzi e R. Tomassini, Multhipla, Milano, 1979. Ho sempre letto tutto con partecipe dissenso sul piano della linea politica, ma con fortissimo interesse filosofico e teorico-politico. ↑
- V. FOA, Il Cavallo e la Torre, Riflessioni di una vita, Einaudi, 1991. ↑
- Editori Riuniti, Roma, 1972 e poi 1977. ↑
- Al proposito rinvio ai miei contributi: A. BORDIGA, Scritti scelti, Feltrinelli, Milano, 1974; Bordiga. Il pensiero e l’azione politica, Editori Riuniti, 1976; Scienza e politica in Amadeo Bordiga. La critica dell’opportunismo, il settarismo e il determinismo, “Il Risorgimento”, Milano, LVII, a.2/3, 2005, pp. 263-302. ↑
- L. GEYMONAT, Scienza e realismo, Feltrinelli, 1977; E. BELLONE – L. GEYMONAT, G. GIORELLO, S. TAGLIAGAMBE, Attualità del materialismo dialettico, Editori Riuniti, 1974. ↑
- L. ALTHUSSER, Per Marx (1965), Editori Riuniti, Roma, 1972; con E. BALIBAR, Leggere il Capitale (1965), Feltrinelli, 1972; Lenin e la filosofia (1969), Jaca Book, Milano, 1969. ↑
- L. COLLETTI, Il marxismo e Hegel, Laterza, 1969; con C. NAPOLEONI, Il futuro del capitalismo. Crollo o sviluppo?, Laterza, 1970. ↑
- E. BERNSTEIN, I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia (1899), a cura di L. Colletti, Laterza, 1968. Ma si veda: F. LIVORSI, Turati. Cinquant’anni di socialismo in Italia, Rizzoli, Milano, 1984.Il saggio citato di Rosa Luxemburg contro Bernstein è pressoché integralmente pubblicato nei suoi citati Scritti scelti, a cura di L. Amodio. ↑
- R. MONDOLFO, Sulle orme di Marx (1919), Cappelli, Bologna, 1923; Da Ardigò a Gramsci, Nuova Accademia, Milano, 1962; Umanismo di Marx. Studi filosofici 1908-1966, a cura di Norberto Bobbio, Einaudi, 1968.Rodolfo Mondolfo è discusso, in rispettosa polemica, anche sull’”Ordine Nuovo” di Gramsci nel 1919-1920. È interessante notare che – come direttore dell’Enciclopedia italiana, la Treccani – Giovanni Gentile in pieno regime fascista affiderà al sempre socialista Rodolfo Mondolfo voci sul marxismo.Sul piano internazionale il maggior esponente di questo marxismo a sfondo idealistico, detto anche “marxismo occidentale”, è stato Karl Korsch, che dopo il 1930 rinnegò il marxismo. Si vedano soprattutto: K. KORSCH, Marxismo e filosofia (1930), Pgreco, Milano, 2012; Karl Marx (1938), Laterza, 1971. ↑
- N. BADALONI, Il marxismo come storicismo, Feltrinelli, 1962. ↑
- P. P. PASOLINI, Le ceneri di Gramsci, Garzanti, Milano, 1957. ↑
- K. MARX, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica. Grundrisse (sono quaderni preparatori del Capitale, scritti nel 1857-1858, ma editi postumi a Mosca nel 1939-1941), a cura di G. Backhaus, Einaudi, 1976, due volumi. Si confronti con: K. MARX, Scritti inediti di economia politica, tradotti e curati da M. Tronti, Editori Riuniti, Roma, 1963. ↑
- L’opera, a cura di G. Giorgetti, è uscita presso gli Editori Riuniti, a Roma, nel 1963. ↑
- A. NEGRI, Pipe-line: lettere da Rebibbia, Einaudi, 1983. ↑
- Dario Lanzardo, sia pure dando un titolo fuorviante rispetto all’operaismo, per suggestione di quegli anni, curò pure una bella raccolta di testi di RANIERO PANZIERI, La ripresa del marxismo-leninismo in Italia, Sapere, Milano, 1972. ↑
- Il riferimento è ad alcune paginette stampate di un giornalino del 1965 intitolato “Unità operaia”. ↑
- M. TRONTI, Sull’autonomia del politico, Feltrinelli, 1977; Soggetti, crisi, potere. Antologia di scritti e interventi, a cura di A. De Martinis e A. Piazzi, Cappelli, Bologna, 1980. Ma va soprattutto letto e studiato: M. TRONTI, Il demone della politica. Antologia di scritti. 1958-2015, a cura di M. Cavalleri, M. Filippi e M. H. Marcat, Il Mulino, Bologna, 2017. ↑
- Per la comprensione profonda e dall’interno di tutta questa problematica trovo prezioso: A. NEGRI, Dall’operaio massa all’operaio sociale, a cura di P. Pozzi e R. Tomassini, Multhipla, Milano, 1979. Ma si veda: A. NEGRI – M. HARDT, Moltitudine: guerra e democrazia nel nuovo ordine imperiale, Rizzoli, 2004. ↑
- T. PHILLIPS, Joker, film del 2019. ↑
- Anche Vittorio Foa era arrivato a tale conclusione, su cui nel ricordato Il Cavallo e la Torre ci sono pagine straordinarie. ↑
-
F. LIVORSI, Psiche e eternità. Alla ricerca del dio perduto, Moretti & Vitali, 2022. ↑
II) Operai e capitale nell’Italia in cammino: il “punto di vista” di Mario Tronti
03/12/2023
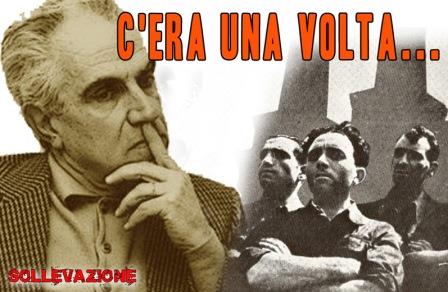 Torno a riflettere su Mario Tronti, sempre a partire dalla sua opera più famosa (Operai e capitale, 1966 e poi 1970), ma questa volta per portare l’attenzione sui suoi scritti ulteriori, compresi tra il 1971 e il 2023. Taluno potrà pure pensare che io sopravvaluti questo Pinco Pallino di Mario Tronti, che in fondo – si dirà – ha scritto un solo libro – per altro controverso anche per molti tra quelli “che se ne intendono” – veramente importante, appunto Operai e capitale[1], che nel mio saggio del 16 agosto io avevo continuamente in mente; e poi, dopo quella breve stagione tra “Quaderni rossi” (1961/1963) e “Classe operaia” (1964-1967), è stato un comunista di seconda fila del PCI, pure senatore “bersaniano” a un certo punto; e prima, per anni, professore di Filosofia in una media superiore, e per una ventina d’anni incaricato di “Filosofia politica”, credo mai ordinario, all’Università di Siena, scrivendo ovviamente in tutto quel tempo alcuni libri.
Torno a riflettere su Mario Tronti, sempre a partire dalla sua opera più famosa (Operai e capitale, 1966 e poi 1970), ma questa volta per portare l’attenzione sui suoi scritti ulteriori, compresi tra il 1971 e il 2023. Taluno potrà pure pensare che io sopravvaluti questo Pinco Pallino di Mario Tronti, che in fondo – si dirà – ha scritto un solo libro – per altro controverso anche per molti tra quelli “che se ne intendono” – veramente importante, appunto Operai e capitale[1], che nel mio saggio del 16 agosto io avevo continuamente in mente; e poi, dopo quella breve stagione tra “Quaderni rossi” (1961/1963) e “Classe operaia” (1964-1967), è stato un comunista di seconda fila del PCI, pure senatore “bersaniano” a un certo punto; e prima, per anni, professore di Filosofia in una media superiore, e per una ventina d’anni incaricato di “Filosofia politica”, credo mai ordinario, all’Università di Siena, scrivendo ovviamente in tutto quel tempo alcuni libri.
Si vedrà. Io credo che Tronti non sia certo stato né un Marx né un Lenin o Trockij o Rosa Luxemburg, ma penso pure che in una vera storia del marxismo italiano Tronti dovrebbe emergere tra i filosofi politici più importanti, quanto lo è Norberto Bobbio in un’ideale storia del liberalismo democratico. In una vera storia del marxismo in Italia, che non c’è, non sfigurerà affatto accanto a Antonio Labriola o Rodolfo Mondolfo, ma persino, per quanto la mia affermazione potrà parere assurda, accanto a Gramsci, almeno sul terreno filosofico politico.
Nella mia troppo lunga meditazione su Tronti nella storia del marxismo operaista del 16 agosto 2023, ho già fatto molti riferimenti al Tronti di Operai e capitale, ma c’era appunto ben altro, che sono poi andato a leggere o rileggere, prendendo un mare di appunti soprattutto su due grossi libri di Mario Tronti: Il demone della politica. Antologia di scritti (1958-2015) e Dello spirito libero. Frammenti di vita e di pensiero (2015).[2] Ora proverò a dire quel che ne ho ricavato, facendo parlare anche l’autore, per quel che si può vagliando con cura queste mille pagine circa, oltre a Operai e capitale e al resto. Mi sono pure premurato di andare ad ascoltare, prendendo appunti, diversi suoi interventi su Youtube, in occasione dell’uscita dei suoi ultimi libri negli ultimi dieci anni della sua vita e di taluni dibattiti su temi decisivi.
Taccio su quisquiglie (ne “Il demone della politica” pp. 12/13 e n. 2)[3], che però sarebbe bello approfondire, come la tesi di laurea in Filosofia (su che cos’era? E com’era?) discussa all’Università “La Sapienza” di Roma con l’importante filosofo gentiliano di sinistra Ugo Spirito, forse la testa più forte del socialfascismo dagli anni Trenta del Novecento al secondo dopoguerra, dove in piena guerra fredda, pur restando un fascista (sempre molto “di sinistra”), era apertamente più favorevole all’economia pianificata e all’URSS che non agli Stati Uniti, che detestava[4]. Costui aveva pure elaborato una filosofia attualista, gentiliana ma a sé stante, chiamata “problematicismo”, che non ho qui occasione di riprendere, ma che sul piano della filosofia della religione è interessante.
Comunque credo vero che sin dall’inizio Tronti sia stato un comunista, già a ventiquattro anni, nel 1956, segretario della cellula del PCI all’Università della Sapienza di Roma, cui erano iscritti studenti e docenti comunisti. Tra questi c’era pure Lucio Colletti, allora assistente di Ugo Spirito. Tronti, sempre “operaista” nell’anima, si sentiva, inoltre, prossimo dalla prima infanzia dei proletari e popolani del Testaccio e della Garbatella, plebe romana antica e nuova, a suo dire la stessa delle poesie di Gioacchino Belli, e che avrebbe dato a lui, e pure ai suoi figli, la “giusta dritta” nella vita (come dice nel “Demone della politica” in una bella pagina”). Lì, prima ancora dell’Università, avrebbe fatto le sue esperienze di vita come comunista tra i proletari.[5] Io pure nell’infanzia e prima fanciullezza ho avuto il mio Borgo San Paolo natio di Torino, mai dimenticato né da me dimenticabile, ma da cui la vita della mia famiglia mi portò via. Tronti, invece, restò nelle sue periferie semiproletarie sino alla morte.
Affacciandosi sulla scena della sinistra dopo la grande svolta del 1956, cercava una terza via nel marxismo. Certo non gli andava bene il marxismo “sovietico”, il famoso “diamàt” (materialismo dialettico), che cercava la dialettica già hegeliana tesi antitesi sintesi nelle cose stesse, pure nel movimento degli e negli atomi, ed era intriso di determinismo economico, esso pure con pretesa di riflettere rapporti “oggettivi”, e che Gramsci aveva criticato, nei Quaderni del carcere, in Bukharin; ma non gli andava bene neppure quello che sarà detto “italocomunismo”, qui nel senso di “italomarxismo”, che accentuava moltissimo il ruolo primario della coscienza nella storia (il sottofondo idealistico hegeliano del materialismo storico o marxismo), in un iter che sarebbe venuto tutto da Gramsci, ripreso da Togliatti, e che come hegelo-marxismo culminerà ne Il marxismo come storicismo di Nicola Badaloni (1962).[6] Lì, nel marxismo più legato all’hegelismo (o idealismo), prevalso nel PCI tra Gramsci e Togliatti, persisteva l’idea di un partito fonte di educazione delle masse popolari, “illuminato” da una Coscienza superiore, “illuminante” per suo tramite (piuttosto che parte “interna” delle masse stesse, quasi che la coscienza, come nell’idealismo hegeliano, irradiasse da una comunità etica collettiva, da un’entità sovraordinata, che lì era il “Partito Comunista” invece che lo Stato etico hegeliano, o neo-hegeliano). Tronti perciò prendeva un poco le distanze pure da Gramsci, come si vede ne “Il demone della politica”, nel saggio del 1959 (aveva allora ventisette anni) Tra materialismo dialettico e filosofia della prassi, Gramsci e Labriola[7].
Ricercava piuttosto un marxismo scientifico rivoluzionario, ma tramite una scientificità umanistica più che risolta nella pretesa oggettività dei rapporti economici (in ciò diversamente da Lucio Colletti): scientificità “umanistica” che pure pretendeva di cogliere nella realtà studiando il Marx filosofo economista dei Grundrisse e tutti i volumi del Capitale, che con evidenza egli conosceva a fondo[8]. Questa “nuova scienza”, intesa come marxismo creativo, mirava a cogliere, nella stessa economia in divenire, l’universalmente umano (hegeliano). Quest’ideale dell’universalmente umano, che Tronti cercava di cogliere nella realtà economica tramite le categorie di “critica dell’economia politica” caratteristiche del Capitale[9] e dei Grundrisse di Marx, avrebbe dovuto includere pure lo svelamento della soggettività rivoluzionaria. Questa soggettività rivoluzionaria, in tal caso del mondo operaio, era intesa da Tronti come una sorta di fuocherello sotto il paiolo della storia che si fa sempre collettivamente, tramite gli interni conflitti economico sociali politici e ideali: storia di cui i soggetti singoli sarebbero appena epifenomeni, un portato della storia, per quanto talora ci appaiano protagonisti veri, come Napoleone o Lenin. Lo sono, o sarebbero stati, ma solo come punta dell’iceberg sociale-politico che li ha fatti o fa venir fuori, e non certo “solo”, o “soprattutto”, come persone. In Tronti non c’era, e non ci fu mai, nessuna fascinazione per il mito del Capo, fosse pure quello trattato da Max Weber e approfondito da Schmitt[10]; certo a tratti può esserne stato suggestionato, ma sempre con la consapevolezza che i capi sono solo espressione e portavoce di un grande movimento collettivo, come insegnava Marx, ma in realtà già Hegel. L’impersonalimo, nel senso di società o intersoggettività anteriore all’individuo (che ne è solo una particolare espressione), rimase un tratto forte in Tronti quasi dall’inizio alla fine: un impersonalismo, o sovrapersonalismo, che però non condivido affatto, e in fondo non ho mai condiviso, pur riconoscendo che è un tratto forte del marxismo; ma in tal caso tanto peggio per il marxismo. Tronti poteva pure, alla fine, essere aperto all’inconscio (però collettivo), alla psicologia del profondo, qua e là con qualche cenno positivo a Jung e Hillman (in Dello spirito libero), ma in una visione in cui il “noi” viene prima dell’Io e spiega l’Io, o prima dello stesso inconscio individuale (compreso in quello collettivo). Il vero Io è, o sarebbe, sempre intersoggettivo, “tutti noi”, e in specie tutto il movimento collettivo fonte di storia. Di questo “noi” la singolarità potrebbe sì essere una straordinaria voce, ma che emerge da un humus comune, e sempre tale. Può darsi che questo sia pure l’A, B, C di Hegel e di Marx, ma in Tronti questo impersonalismo, o sovrapersonalismo, è stato molto interiorizzato (mentre da ciò Nietzsche e Kierkegaard mi hanno cauterizzato sin dal principio).
A un certo punto però pure Tronti, alla fine, ha scoperto che il singolo può prescindere dal “generale”, dal sovrapersonale o collettività umana, come “spirito libero”; ma in tal caso solo come l’anti-storia, in certo modo distaccandosene, con l’approccio che in Veneto direbbero un “trarse fora”, per opporsi ad una decadenza senza fine in cui la storia in questo tempo sciagurato sarebbe ora precipitata. Ma su ciò tornerò.
Ma ab ovo, sulla base di un marxismo inteso come “scienza della rivoluzione in cammino”, nel 1961 Tronti vedeva tutto il divenire come opera di collettività in cammino: in chiave comunista come collettività proletaria che nel profondo fa la storia, a prescindere dalla consapevolezza dei singoli. Diventò cofondatore dei “Quaderni rossi” di Panzieri, con cui però già nell’agosto 1963 ruppe da sinistra (come sinistra dell’estrema sinistra), con alcuni amici: non senza però aver pubblicato prima, sui “Quaderni rossi”, saggi che nel consenso come nel dissenso Panzieri aveva apprezzato moltissimo, come La fabbrica e la società (1962)[11], e Il piano del capitale (1963), che poi naturalmente Tronti avrebbe riproposto in Operai e capitale.
Qui emergeva già un punto differenziale importantissimo rispetto alla sinistra tradizionale, socialista e anche comunista. Di solito si diceva, pure da parte di Vittorio Foa, che nell’operaio c’è una duplice natura: da un lato l’operaio è forza-lavoro del capitale, ma dall’altro è persona, che vuole dipendere solo da sé stessa (mira in modo ancestrale all’”autonomia”)[12], cioè mira a non dipendere da nessuno. Ma Tronti unificava le due parti (l’essere l’operaio “forza lavoro” e libera persona), vedendo la classe operaia, o l’operaio (collettivo), contemporaneamente, e sempre, al tempo stesso come forza lavoro e persona. Lo affermava perché l’essere umano è “tutto quanto” materia, ma “materia umana”, materia pensante[13]; e poi perché nella prassi è sempre così (“sarebbe” sempre così): tanto più nel nostro mondo neocapitalista o super-capitalista. In tal caso l’operaio, essendo il soggetto sottinteso oltre che l’antitesi del Capitale (forza lavoro e libero-creativo), risultava (sarebbe risultato) il soggetto collettivo “del” e “nel” capitalismo: un capitalismo che l’operaio collettivo avrebbe fatto vivere benché fosse sfruttato (donde il grande titolo del suo opus del 1966, appunto “Operai” – al primo posto – e “capitale” – al secondo posto – anche se Marx non a caso aveva invece intitolato il suo opus “Il capitale” (perché lì, in Marx, l’operaio è soprattutto “v”, capitale variabile, salariato dipendente dal Capitale che lo compera al mercato, finché il Capitale non salti e venga fatto saltare per aria dalla rivolta dei lavoratori, che ferve dal principio, ma prigioniera del capitale, e sino alla rivolta contro il Capitale, o “alle” rivolte contro il Capitale, irriducibilmente tale, che sconvolgono le pretese leggi economiche oggettive del capitale, come il meccanismo del plusvalore e del profitto). E infatti nel vasto saggio Marx, forza-lavoro, classe operaia, del 1965, già in Operai e capitale[14], Tronti scriveva: “La figura schumpeteriana dell’imprenditore, con la sua iniziativa innovatrice, ci piace vederla rovesciata nella permanente iniziativa di lotta delle grandi masse operaie.”[15] Sarebbero proprio le masse lavoratrici in lotta contro il Capitale a forzare il Capitale allo sviluppo. Ogni evoluzione della tecnologia avverrebbe come tentativo del Capitale di seguitare a far profitto rispondendo ai problemi che la resistenza della classe operaia allo sfruttamento pone nel corso del tempo. Non è una faccenda politicamente sempre sotto la bandiera rossa, perché si manifesterebbe pure in contesti in cui l’apparenza sembrerebbe dire il contrario.
Ad esempio anni dopo (1970), nella seconda edizione di Operai e capitale, vagliando il rapporto positivo instaurato dagli operai americani, di solito detti integrati nel sistema capitalistico, col New Deal di Roosevelt del 1933-1934, poteva dire che “se mettiamo l’occhio sui risultati, vediamo che quanto ha ottenuto il nuovo sindacalismo industriale dentro il New Deal non lo ha ottenuto mai nessun partito della classe operaia”. E insisteva dicendo che “Una lettura ‘americana’ del Capitale e dei Grundrisse [di Marx] si raccomanda a chi possiede il gusto o il genio della scoperta critica.” E aggiungeva che “C’è una storia americana di organizzazioni che non sono partito, eppure sono vere organizzazioni operaie Così come c’è un filone americano di pensiero che non è marxista, eppure è vero pensiero operaio.”[16]
Questo consentiva di superare un “rivoluzionarismo” antico anche bolscevico che distingueva bene il “prima” e “dopo” la rivoluzione. In sostanza la rivoluzione operaia, essendo sempre operante per lo sviluppo del capitalismo (spinto suo malgrado oltre) e contro il capitalismo (per superarlo), sarebbe permanente, ben prima della conquista del potere se non addirittura a prescindere da essa. La classe operaia sarebbe sempre dentro e contro il capitalismo, come il capitalismo sarebbe sempre dentro e contro la classe operaia, con impostazione di compresenza tra opposti – operai e capitale – in vista di un oltre, o sintesi superatrice degli opposti. Direi che è come quando diciamo che nell’organismo c’è un cervello della testa e uno dell’intestino: c’è una logica o cervello sociale del lavoro dipendente e ce n’è una, altrettanto sociale, del Capitale; esse sarebbero nemiche, ma al tempo stesso interdipendenti. Questa visione che tramite l’urto dei contrari produce lo sviluppo, nella rivoluzione continua, che culminerebbe nella rivoluzione operaia, naturalmente trasuda di idealismo hegeliano e neo-hegeliano, o di marxismo hegeliano (ossia dialettico idealistico): però non come mera coscienza ideale immanente, come si credeva fosse la linea che da Antonio Labriola tramite Gramsci portava a Togliatti, ma come “scienza” (un’idea di “scienza” di cui Cacciari ha colto qualche eco della vichiana “Scienza nuova”, vista come “la Storia”, che potrebbe diventare scienza, più della cartesiana matematica, perché l’uomo, qui collettivo, la fa[17]). Tronti, in quella fase ultraoperaistica, sottolineava “la portata oggettivamente rivoluzionaria dello sviluppo capitalistico”: “Per cui, la rivoluzione operaia – diceva già in La fabbrica e la società (1962) – non deve avvenire dopo, quando il capitalismo è già crollato nella catastrofe di una crisi generale, né può venire prima, quando il capitalismo non ha neppure cominciato il suo specifico ciclo di sviluppo. Può e deve avvenire contemporaneamente a questo sviluppo, deve presentarsi come componente interna dello sviluppo e al tempo stesso come sua interna contraddizione …”[18].
In questa visuale, come in: La rivoluzione copernicana (1963)[19], sempre di Tronti, a fare la rivoluzione capitalistica è la classe operaia, in una sorta di rivoluzione appunto permanente, che tramite il perseguimento del proprio interesse collettivo anche immediato, e forse soprattutto immediato, attraverso la lotta disloca in avanti tutto il sistema cui inerisce. Si può cogliere il retroterra di tale vision in quello che Lenin, certo l’autore più caro a Tronti dopo Marx (o quanto Marx), aveva teorizzato nel 1905 in Due tattiche della socialdemocrazia, per spiegare la possibilità in Russia di fare il capitalismo tramite il potere “politico” della casse operaia (una “rivoluzione borghese senza borghesia”, diceva lì Lenin). In quel vasto saggio Lenin aveva spiegato che spesso la borghesia, sconfitto il precapitalismo (o i poteri feudali, i tratti parassitari più gravi che frenano lo sviluppo, cioè la “reazione”) ha interesse a cercare subito il compromesso con le forze del passato, come monarchia, latifondismo, chiesa, eccetera, per timore dell’avanzata del movimento operaio: mentre i proletari hanno l’interesse opposto, come i giacobini (Lenin chiamava i socialisti democratici rivoluzionari russi “giacobini marxisti”)[20]. Questa visione di un proletariato più interessato della stessa borghesia allo sviluppo del capitalismo, purché non dominato dalla borghesia, passava a Tronti.
Quest’impostazione però comportava pure – dopo il primo risveglio alla lotta degli operai della stessa FIAT (Torino, 1962) – anche se la ripresa “piena” delle lotte in grande stile lì sarebbe arrivata anni dopo – un’idea, in parte ingenua e in parte preveggente – in anni che visti a posteriori erano di palese preparazione del futuro autunno caldo – di attualità della rivoluzione operaia.
Su questo Raniero Panzieri non poteva concordare, in parte perché avendo nove anni più di Tronti e dei suoi pur stimatissimi amici romani era più scafato politicamente, come Tronti e compagni poco sapevano nonostante la frequentazione a Roma ancor prima dei “Quaderni rossi”, come si vede pure nell’intervento del 2005 – pur molto interessante – su Panzieri, dello stesso Tronti, di tanti anni dopo, L’eredità di quello che è stato (tratto da un volume su Panzieri del 2011 curato da Paolo Ferrero)[21], in cui sembra che non ci sia sospetto del fatto che Panzieri era stato segretario del P.S.I, della Sicilia, mandato da Rodolfo Morandi (decisivo Vicesegretario del Nenni di quel tempo), al tempo dell’occupazione delle terre nella Sicilia del secondo dopoguerra; era stato assistente volontario di della Volpe a Messina, e direttore, voluto e stimato da Nenni, del mensile del PSI “Mondo operaio”, oltre che redattore (licenziatosi credo nel 1961) all’Einaudi di Torino, e fondatore e direttore dei “Quaderni rossi” (1961/1966[22]). Panzieri si entusiasmava dei movimenti di massa spontanei, da vero luxemburghiano socialista, che poneva sempre la classe lavoratrice “sopra” il partito, e criticava sino alla rottura la dirigenza socialista e comunista del 1962 (che nei fatti di Piazza Statuto in cui operai FIAT avevano occupato per giorni la piazza e attaccato persino la sede della UIL, considerata allora padronale, aveva visto fascisti all’opera); ma ciononostante Panzieri non era neppure disposto a vedere nei movimenti spontanei degli operai una specie di rivoluzione già en marche, che un’avanguardia antagonistica, di cui il gruppo si considerava il nucleo, avrebbe potuto dirigere. Per lui andava fatto un lungo lavoro di conoscenza-intervento tra i lavoratori, in cui si accentuava il momento dell’educazione-autoeducazione all’antagonismo, incentrato sull’inchiesta tra gli operai. L’autogoverno operaio, come per Marx e Rosa Luxemburg, per Panzieri era la chiave di volta, ed attuale, ma senza possibili forzature da parte di gruppi pretesi d’avanguardia che “trascinassero” le masse (con approccio neo-leninista destinato alla sconfitta, e comunque pericolosamente aperto ad avventure di pretese piccole minoranze che si dicevano rivoluzionarie e “operaie”). La spontaneità operaia per Panzieri andava molto valorizzata, ma pure lungamente “lavorata”. Nessuno, però, avrebbe potuto né tantomeno dovuto trascinare o surrogare il protagonismo diretto delle masse, pur dando un’indispensabile mano. Tronti e compagni, per lo più educati dal PCI anche se l’avevano temporaneamente ripudiato (o nel caso di Tronti si erano messi da parte prescindendone), per contro credevano di essere un micromovimento rivoluzionario dentro una rivoluzione operaia in fieri, che aspettava solo loro, o avanguardie come loro, per manifestarsi. Così i dissidenti s’imbarcarono nell’avventura di “Classe operaia” (1964/1967).
Su ciò la testimonianza di Tronti, riferita a Panzieri, è comunque significativa: “Forse lo colse il timore di buttarsi in un’avventura più grande delle nostre forze. Era più prudente, aveva più esperienza, noi, più giovani, eravamo più incoscienti. Il pericolo dell’isolamento era forte. La sponda sindacale era caduta presto. L’ostilità dei partiti cresceva. Dopo il primo numero [dei “Quaderni rossi”], i nomi più altisonanti si erano subito defilati.” E qui si riferiva a Vittorio Foa, che nel ’61 aveva scritto l’editoriale del primo numero. “E lì si ritrovava con intorno questo gruppo di matti intelligenti. Certo, lo capisco più oggi che allora.” Riconosce che era stata una fuga in avanti: “Ma è vero – riconosceva -, lo sbocco sociale, subito, non ci fu. Ci fu però subito dopo, nel nuovo biennio rosso [1919-1920] 1968-1969.”
Poi però va più a fondo, osservando: “Direi, però, che non è ancora questo il punto. Il vero punto è che lui era un socialista e io ero un comunista. Mi piace a questo punto rileggere i nostri rapporti come un piccolo episodio novecentesco del nobile confronto fra tradizione socialista e tradizione comunista. In comune c’era il fatto che all’interno delle due tradizioni non sceglievamo né l’ortodossia né l’eresia, ma l’eterodossia, e dunque la ‘critica’ (…). Se per lui un riferimento possibile era a posizioni socialiste rivoluzionarie e luxemburghiane, per me il riferimento certo era a posizioni bolsceviche e leniniane. (…) A rileggerla adesso, la differenza con Panzieri mi appare quella tra spontaneità e direzione, tra autorganizzazione e organizzazione, tra Consigli e Partito[23].”
Questo aveva a che fare con quello che a metà degli anni Sessanta dicevamo essere il rapporto tra avanguardia e classe, tra minoranza organizzata e masse, tra partito di sinistra (o fosse pure un “partitino”, un gruppo che si pretendesse partito) e lavoratori. Allora si faceva spesso distinzione tra il partito come avanguardia “esterna” oppure “avanguardia interna” rispetto alle masse lavoratrici. La concezione del partito come “avanguardia esterna” era quella tipica del PCI (del partito che porta la coscienza ai lavoratori), ma anche di piccoli gruppi sorti sull’onda del 1968-1969, pretesi “avanguardia del proletariato” marxisti-leninisti, in specie maoisti: tutta gente che pretendeva di avere una scienza rivoluzionaria “vera” da innestare sulla spontaneità delle masse lavoratrici, che da sole “non ci potevano arrivare”. Così aveva detto Lenin nel Che fare?, nel 1902[24], che per loro era una Bibbia. Questo nel PCI era l’A, B, C, come lo era stato nell’Internazionale Comunista, Partito che riuniva in una sorta di superpartito i partiti comunisti del mondo (1919/1943), specie dal 1926 in poi. Come i cattolici spesso – talora compresi diversi preti e cardinali – credono più nella Chiesa che in Dio, il PCI credeva solo nel proprio essere – in quanto tale – la coscienza-volontà dei lavoratori (lo sapessero i lavoratori o meno).
Invece altri marxisti, di matrice socialista anche di estrema sinistra, credevano al ruolo di avanguardie interne al mondo operaio. Il primo tipo era detto partito preteso “di classe”, e il secondo “della” classe operaia. L’idea di avanguardia “interna” segnalava sì il carattere necessario dei dirigenti, ma solo emergenti nelle lotte o almeno dentro di esse (e non come un corpo “sovraordinato”, come il Partito per il PCI, ma pure per i pretesi micropartiti marxisti-leninisti, tipo “Servire il popolo” e forse anche “Avanguardia operaia”). La posizione fautrice dell’azione in prima persona della classe operaia, solo stimolata da avanguardie interne, “trontiana”, era pure stata raggiunta da ex comunisti (come ad esempio il genovese Gianfranco Faina), ma veniva da Rosa Luxemburg, segnatamente dal suo libro Sciopero di massa, partito e sindacati (1907). Per tale posizione i lavoratori vengono sempre prima del partito che pure sia o si pretenda la loro coscienza[25]. Lo diceva Rodolfo Morandi[26], il vicesegretario del PSI, come pure il suo amico Raniero Panzieri, cui avrebbe persino lasciato il suo studio e biblioteca a Torino in via Bligny.
In materia però, dall’inizio, la posizione di Tronti era un po’ un ponte tra le due (tra il “partito” o nucleo dirigente “esterno” o “interno” alle grandi masse lavoratrici, perché Tronti sottolineava pure, nell’avanguardia, uno scatto in più, un momento decisionistico, quasi di necessaria forzatura della storia, di cui per lui l’esponente massimo era stato Lenin stesso). Quello che sarebbe poi stato, anni dopo, il discorso di Tronti, post-operaista, sull’”autonomia del politico” (dal 1972 in poi), connesso pure a Carl Schmitt, o espressamente a Schmitt, aveva come filo rosso questo legame perenne col Lenin capo di una rivoluzione.
Non a caso il primo formidabile editoriale del numero uno di “Classe operaia” s’intitolava Lenin in Inghilterra. Bisognava forzare la storia come aveva fatto sempre Lenin nel ventennio tra 1905 e 1924 (quando era morto), col suo partito: leader e movimento trascinati dalla passione e determinazione, ma a misura dei problemi del capitalismo avanzato (in “Inghilterra, nel senso di operante nell’Occidente capitalistico avanzato, europeo e – almeno altrettanto – americano)[27]. E quest’articolo è stato, ed idealmente è, il Vangelo di Antonio Negri[28], malgrado il Tronti successivo del PCI (dal 1966 al 2023, naturalmente passando per i diversi “ribattezzamenti” e “metamorfosi”, sino al Partito Democratico). Sin dall’inizio c’era in Tronti, dentro un contesto pure molto operaio collettivo, ritenuto decisore virtuale o reale in permanenza, un’ipervalorizzazione del decisore politico, che nel saggio del 2001 Politica e destino lo porterà a fare il seguente parallelismo (metaforico) tra azione politica e musica: “La parte del solista è la politica, il destino è l’orchestra, Come il piano dirige l’orchestra, così la politica guida la storia.”[29]
Se nell’estate 1963 questo portava a rompere con Panzieri ritenendo attuale la rivoluzione operaia, già tre anni dopo lo stesso approccio, prendendo di sorpresa parecchi di questi operaisti estremi, portava Tronti a teorizzare, per sé stesso e per i suoi compagni, la necessità “rivoluzionaria” di rientrare nei partiti della sinistra (lui nel PCI, come sempre, ma taluno, come Asor Rosa, entrerà nel PSIUP): come “lotta di partito per la conquista dell’organizzazione; tattica leninista entro una ricerca strategica di tipo nuovo; processo rivoluzionario in un punto per rimettere in moto il meccanismo della rivoluzione internazionale. Alla domanda che fare, c’è ancora per poco tempo una risposta possibile da proporre. Lavorare tutti per anni su una sola parola d’ordine: dateci il partito in Italia e rovesceremo l’Europa!” (scriveva in La linea di condotta nel 1966, introducendo Operai e capitale). Così faceva eco al Lenin del 1903[30].
Non sembra ingeneroso, dopo oltre mezzo secolo, vedervi un certo velleitarismo da Lenin in Italia, del resto allora ricorrente in più di un “capo” di movimenti ultraminoritari pretesi rivoluzionari, ma egli pretendeva di svolgere tale ruolo conquistando il PCI alle posizioni antagonistiche di cui era fautore.
(Segue)
- M. Tronti, Operai e capitale, Einaudi, Torino, 1966 e poi 1970. ↑
- M. Tronti, Il demone della politica. Antologia di scritti (1958-2015), a cura di Matteo Cavalleri, Michele Filippini e Jamila M. H. Mascat, Il Mulino, Bologna2017, pagg. 656, e Dello spirito libero. Frammenti di vita e di pensiero, Il Saggiatore, Milano, 2015, pagg. 316. ↑
- M. Tronti, Il demone della politica, cit., pp. 12/13 e n. 2. ↑
- U. Spirito, Storia della mia ricerca, Sansoni, Firenze, 1971; Il problematicismo, Sansoni, 1948. Si veda pure: E. Serra, Il tema del comunismo in Ugo Spirito dal 1946 al 1960, “Democrazia e diritto”, febbraio 2020, pp. 99-119. ↑
- M. Tronti, “Politica e destino” (2001), in: Il demone della politica, cit., p. 576. Su ciò c’è un filmato, con sue dichiarazioni, “La mia parola messa a nudo”. Video intervista a Mario Tronti, s.d., su “Youtube”. ↑
- N. Badaloni, Il marxismo come storicismo, Feltrinelli, Milano, 1962. ↑
- M. Tronti, “Tra materialismo dialettico e filosofia della prassi, Gramsci e Labriola” (1959), in: La città futura. Saggi sulla figura e il pensiero di Antonio Gramsci, a cura di A. Caracciolo e G. Scalia, Feltrinelli, Milano, 1959 e in: Il demone della politica, cit., pp. 67-94. ↑
- I Grundrisse di Karl Marx. Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858, ma postumo a Mosca nel 1939), a cura di M. Mosto e con Prefazione di E. Hobsbawm, ETS, Pisa, 2015; K. Marx, Il capitale, I (1867 e poi 1873; II, postumo a cura di f. Engels, 1885; III, a cura di F. Engels, 1895; ma si parla pure di un IV, Teorie del plusvalore, a cura di K. Kautsky, 1895 ), tr. di D. Cantimori, I, con Prefazione di M. Dobb, Editori Riuniti, Roma, 1962/1968. ↑
- Il Capitale di Marx ha come sottotitolo, non certo casuale, Critica dell’economia politica. Voleva insomma smascherare la pretesa scientificità delle leggi dell’economia capitalistica e non semplicemente riproporle in chiave collettivista come si crede molto spesso. In casa ho pure una vecchia edizione della UTET di Torino del 1946, in cui in una nota, fatta sparire in edizioni successive maggiori, Marx diceva di essersi proposto di “far scoppiare i coglioni” degli economisti della borghesia. ↑
- M. Weber, Economia e società. L’economia, gli ordinamenti politici e sociali (1922, postumo, per iniziativa di Marianne Weber), a cura di M. Palma, Donzelli, Roma, 2022, cinque volumi. Si veda il quarto sul “dominio”. Per la teoria del capo carismatico di Carl Schmitt, si vedano, dello stesso: Le categorie del politico. Saggi di teoria politica, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Il Mulino, Bologna, 1972; Principi politici del nazionalsocialismo, a cura di D. Cantimori, Sansoni, Firenze, 1935. ↑
- M. Tronti, “La fabbrica e la società”, “Quaderni rossi”, giugno 1962, e Il demone della politica, cit., pp. 95-122 ↑
- In Foa c’erano molti echi del liberalsocialismo del movimento di Carlo Rosselli “Giustizia e Libertà”, sui cui “Quaderni” aveva scritto già con tale approccio liberale-libertario dall’inizio. Il tema anarchico dell’”autonomia” del lavoratore era valorizzato. Per tale lavoro clandestino, sotto il fascismo Foa fu imprigionato per nove anni. ↑
- Il tema dell’uomo come materia “umana” è decisivo specie a partire dalle Tesi su Feuerbach di Marx del 1845, in appendice a: F. Engels, Ludovico Feuerbach e il punto di approdo della filosofia classica tedesca (1886), Edizioni Rinascita, Roma, 1950. ↑
- M. Tronti, Operai e capitale, Einaudi, Torino, 1966 e poi 1970. ↑
- M. Tronti, “Marx, forza-lavoro, classe operaia”, del 1965, in: Il demone della politica, cit., pp.153-198, ma c’era già in Operai e capitale. V. qui p. 175. ↑
- M. Tronti, “Poscritto di problemi”, nella seconda edizione di Operai e capitale, del 1970, e in: Il demone della politica, cit., pp. 243-284, con riferimenti a p. 279 e 282. ↑
- Mario Tronti e Massimo Cacciari: “il demone della politica”, Youtube”, 2018. Vico diceva che la vera scienza che l’uomo può conoscere è la Storia, “perché la fa”. Così la classe operaia, come insieme dei movimenti che la costituiscono, “conosce” (cioè esprime”) il senso del divenire sociale, come fa pure a parti inverse il Capitale, che l’asservisce, in modo speculare. Così Cacciari interpretava Tronti. ↑
- M. Tronti, “La fabbrica e la società”, “Quaderni rossi”, 1962, e in: Il demone della politica, cit., pp. 95-122, ma v. qui pp. 119-120. ↑
- M. Tronti, “La rivoluzione copernicana” (1963, in Il demone della politica, pp. 123-136. ↑
- Lenin, Due tattiche della socialdemocrazia nella rivoluzione democratica (1905), “Opere complete”, Editori Riuniti, 1960, vol. IX, pp. 9-126. ↑
- M. Tronti, “L’eredità di quello che è stato” (2005), in: Raniero Panzieri. Un uomo di frontiera, a cura di P. Ferrero, Edizioni Punto Rosso / Carte, Roma, 2005, pp. 252-259 e in: Il demone della politica, cit., pp. 591-599. ↑
- Panzieri morì nel 1964, ma i “Quaderni rossi” uscirono sino al 1966. ↑
- M. Tronti, “L’eredità di quello che è stato”, 2005, cit., pp. 598-599. ↑
- Lenin, Che fare? (1902), a cura di V. Strada, Einaudi, Torino, 1972. Quest’edizione portava pure il verbale del congresso del Partito Operaio Socialista Democratico Russo svoltosi a Londra nel 1903, in cui si determinò la storica frattura tra “bolscevichi” (i maggioritari) e “menscevichi” (i minoritari). ↑
- R. Luxemburg, Scritti scelti, a cura di L. Amodio, Edizioni Avanti!, Milano, 1963; Scritti politici, Introduzione e cura di L. Basso, Editori Riuniti, 1967: entrambe le raccolte, in specie la prima, comprendono un’ampia scelta del testo della Luxemburg del 1908 Sciopero di massa, partito e sindacati, testo di riferimento di ogni cosiddetto spontaneismo rivoluzionario. ↑
- Rodolfo Morandi, storico Vicesegretario dello PSI di Nenni negli anni dell’unità d’azione con i comunisti, e vero riorganizzatore di quel partito dalla Liberazione in poi, diceva che “al di sopra del partito” aveva “messo sempre la classe lavoratrice”, e aveva sempre pensato che il partito non avrebbe mai potuto chiedergli nulla di più. Su quest’importante figura, decisiva nella formazione di quasi tutti i dirigenti del PSIUP (1964-1972), è da vedere il bel primo libro di Aldo Agosti: Rodolfo Morandi. Il pensiero e l’azione politica, Laterza, Bari, 1971. Ma si vedano le opere di Rodolfo Morandi: La democrazia del socialismo. 1923-1937, Einaudi, 1961; Storia della grande industria in Italia (1931), ivi, 1958: Lotte di popolo. 1937-1945, ivi, 1958; Lettere al fratello. 1937-1943, ivi, 1959; Il partito e la classe. 1948-1955, ivi, 1961. Più oltre, sempre di R. Morandi: Democrazia e riforme di struttura, ivi, 1997; La politica unitaria, ivi, 1997. ↑
- M. Tronti, “Lenin in Inghilterra”, “Classe operaia”, 1 gennaio 1964, e in Il demone della politica, pp. 137-144, ↑
- Emerge bene nel primo volume della sua fluviale autobiografia, interessante anche per conoscere abbastanza bene i dibattito della cultura filosofica e politica europea degli ultimi quarant’anni: Storia di un comunista, a cura di G. De Michele, Ponte alle Grazie, Milano, 2015 (II, 2018; III, 2020). ↑
- M. Tronti, “Politica e destino”, in: Il demone della politica, cit., pp. 563-590, ma p. 564. ↑
-
M. Tronti, “La linea di condotta”, introduzione del 1966 a Operai e capitale, cit., e in Il demone della politica, cit., pp. 199-220, ma p. 217. Così faceva eco ad una famosa affermazione di Lenin del 1903, il quale aveva detto: “Dateci un partito di rivoluzionari e rovesceremo tutta la Russia.” ↑
III) Comunismo italiano, “autonomia del politico” e “spirito libero” nel pensiero di Mario Tronti
07/12/2023
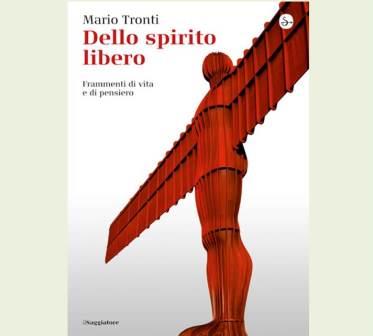 Va notato che Mario Tronti, per quanto filosofo della politica “vero”, lo era suo malgrado. La sua vocazione permanente era quella del “capo rivoluzionario”, o del politico in senso forte: una vocazione però rimasta più o meno insoddisfatta, da “profeta” disarmato, come sono quasi sempre i “profeti”. Del resto egli stesso ha pure teorizzare la figura del profeta dentro la storia vera, in un importante articolo del 1996, Politica è profezia, espressamente dedicato “alle voci profetiche dei ‘monaci’ don Giuseppe Dossetti, padre Benedetto Calati, Pietro Ingrao”, parlando del “profeta” come di uno “che sta dentro la storia del proprio tempo con lo sguardo gettato nell’oltre”. (E questo mi piace da morire). Lì cita positivamente il filosofo religioso “cattolico” Sergio Quinzio, del Mysterium iniquitatis (1995[1]), che a sua volta citava il seguente passaggio (tratto da dove?) del mio amatissimo Dostoevskij: “Quali terribili sofferenze mi è costata – e mi costa tuttora – questa sete di credere, che tanto più fortemente si fa sentire nella mia anima quanto più forti mi appaiono gli argomenti contrari.” La profezia è l’immaginare non un’utopia, ma un’altra storia possibile, ora però impossibile. O, dice lì citando un passaggio del Leviatano di Hobbes: “I profeti non furono dotati di una mente più perfetta, ma di una più viva facoltà di immaginare. (…), è “una funzione straordinaria e temporanea, che viene da Dio per lo più agli uomini buoni, ma talvolta anche tristi.”[2]
Va notato che Mario Tronti, per quanto filosofo della politica “vero”, lo era suo malgrado. La sua vocazione permanente era quella del “capo rivoluzionario”, o del politico in senso forte: una vocazione però rimasta più o meno insoddisfatta, da “profeta” disarmato, come sono quasi sempre i “profeti”. Del resto egli stesso ha pure teorizzare la figura del profeta dentro la storia vera, in un importante articolo del 1996, Politica è profezia, espressamente dedicato “alle voci profetiche dei ‘monaci’ don Giuseppe Dossetti, padre Benedetto Calati, Pietro Ingrao”, parlando del “profeta” come di uno “che sta dentro la storia del proprio tempo con lo sguardo gettato nell’oltre”. (E questo mi piace da morire). Lì cita positivamente il filosofo religioso “cattolico” Sergio Quinzio, del Mysterium iniquitatis (1995[1]), che a sua volta citava il seguente passaggio (tratto da dove?) del mio amatissimo Dostoevskij: “Quali terribili sofferenze mi è costata – e mi costa tuttora – questa sete di credere, che tanto più fortemente si fa sentire nella mia anima quanto più forti mi appaiono gli argomenti contrari.” La profezia è l’immaginare non un’utopia, ma un’altra storia possibile, ora però impossibile. O, dice lì citando un passaggio del Leviatano di Hobbes: “I profeti non furono dotati di una mente più perfetta, ma di una più viva facoltà di immaginare. (…), è “una funzione straordinaria e temporanea, che viene da Dio per lo più agli uomini buoni, ma talvolta anche tristi.”[2]
A questo punto siamo in grado di cogliere pure il protagonista politico, che si sentiva appassionato e adeguato, pur essendo rimasto personaggio in politica non di primo piano (più o meno come Machiavelli dal 1513 al 1527 quando morì, anche se Machiavelli era stato almeno un leader della sua Repubblica Fiorentina, prima della sua caduta, dal 1498 al 1512; ma poi lui pure era diventato un “profeta disarmato”). E infatti, nello stesso saggio su politica e profezia, Tronti scrive: “ … tra destinazione e destino c’è il campo, libero, della decisione politica, perché la politica è decisione, tra ciò che ti è dato e ciò che puoi fare, tra quello a cui sei chiamato e quello che tu sai di dovere con-rispondere. (…) ‘Proprio destino’: che cosa vuol dire? Qual è il mio proprio destino? Ecco la domanda originaria. Ed ecco l’abbozzo di una risposta non provvisoria. ‘Proprio destino’, per me, è quello della mia parte, quello della parte cui appartengo, la sua determinatezza storica, la sua situazione nel mondo, e quindi il suo tempo-ora (…). Adsum, appunto lì io sto, quello io sono. (…) Ecco. Arriviamo al punto. La mia condizione non è quella del pensatore politico. È quella del politico pensante. (…) E qui c’è lo specifico di una posizione: non l’appartenenza a una corrente di pensiero, neppure il marxismo. Il marxismo viene dopo. Piuttosto l’appartenenza a un pezzo di mondo sociale. Movimento operaio: ecco il nome. Classe più organizzazione (…). Credo di non aver mai scritto una riga senza avere in mente, lì e ora, i bisogni, gli interessi, le motivazioni, le aspirazioni di quel mondo del lavoro moderno, come universo di civiltà alternativo a tutto ciò che è.”[3] Qui c’è una forte vocazione del “politico”, però subito risolta nel collettivo (ma per lui, e storicamente, anche Lenin era così: s’identificava, liberamente e per Tronti giustamente, col “suo” partito bolscevico).
Perciò Tronti, nel suo ultimo libro, Dello spirito libero. Frammenti di vita e di pensiero (2015), ha potuto trovare accenti alla Carl Schmitt, in Max Weber, ma subito cogliendo, per il proprio marxismo, una taratura non da singolo capo “carismatico”, ma di tipo collettivo. Cita, infatti, le seguenti parole di Max Weber (tratte da Il lavoro intellettuale come professione, del 1918[4]): “Il possibile non verrebbe raggiunto se nel mondo non si ritentasse sempre l’impossibile. (…) Ma colui il quale può accingersi a quest’impresa deve essere un capo, non solo, ma anche – in un senso molto sobrio della parola – un eroe. E anche chi non sia né l’uno né l’altro, deve foggiarsi quella tempra d’animo tale da poter reggere anche al crollo di tutte le speranze, e fin da ora, altrimenti non sarà nemmeno in grado di portare a compimento quel poco che oggi è possibile.” Ma di suo Tronti, in La linea di condotta (1966) aggiunge sin da Operai e capitale: “La figura dell’eroe, ‘nel senso molto sobrio della parola’, non è una figura nemica. C’è stata una forza storica – si chiamava Movimento operaio – che ha fatto un’operazione straordinaria, ha fatto dell’eroe un’entità collettiva, una forza organizzata, un soggetto sociale, una potenza politica, capace del grande gesto, la guida di un processo rivoluzionario.”[5] Qui si può cogliere in positivo l’eco pure dell’idea del Gramsci dei Quaderni, su Machiavelli, in cui diceva che il moderno Principe, machiavelliano, che fa lo Stato forzando la storia (nel 1500 lo Stato moderno, “borghese”, e ora, si sperava, “operaio”), nella nostra epoca è il partito politico[6] (lì soprattutto, ma non solo, nel senso di partito in senso leniniano).
Nel suo lavoro, anche da studioso, Tronti ha modo di approfondire tale impostazione, in cui la storia è in particolare quella della classe antagonistica o operaia, subito in correlazione con la sua mediazione politica (movimento operaio), come legame tra sé stessa (classe) e il movimento politico (partito), che rinvia al capo carismatico di Weber per i tempi eccezionali, ma che qui appunto concerne un movimento carismatico rivoluzionario collettivo, in relazione a vari momenti essenziali della storia. Il capo non è il capo partito, ma è il partito, o se si vuole il partito che ha al vertice il capo che si merita.
Uno di tali momenti “clou” è Machiavelli stesso, in un saggio compreso nel libro di Tronti La politica al tramonto (1998), nel capitolo “Il Principe e l’Utopia”, in cui metteva a confronto il realismo politico rivoluzionario di Machiavelli, in cui il Capo lo è in specie come condottiero militare e con violenza e astuzia (ma per “fare lo Stato”), “capo” messo lì a confronto con l’umanesimo pacifistico erasmiano dell’Utopia di Thomas More, pubblicato nel 1516, solo tre anni dopo la stesura del Principe: un Principe qui considerato il “che fare?” leniniano del XVI secolo. L’utopia dice, anche suo malgrado, per negazione, quello che il realismo rivoluzionario, edificatore di quella cosetta che si chiama Stato moderno, fa, e per Machiavelli quello che i veri condottieri hanno sempre fatto: infatti – diceva Machiavelli – “’e romani “feciono quello che tutti e’ principi savi debbono fare (…), veggendo il discosto, gli inconvenienti, vi rimediorno sempre”.[7] Con guerra e violenza, quando erano necessarie. L’utopia lo nega, ma è come il guanto rovesciato del realismo politico.
Ancor più illuminante era, per Tronti, la lezione di Cromwell, che egli rapporta alla teoria dello Stato a lui opposta (assolutista, di Hobbes, importante per Cromwell – non so se espressamente o implicitamente – come Hegel per Marx e Lenin, almeno come filosofia implicita nella rivoluzione popolare), libro scritto da Tronti con A. Piazzi e M. Segatori, Stato e rivoluzione in Inghilterra. Teoria e pratica della prima rivoluzione inglese (1977). Il riferimento va naturalmente al grande movimento rivoluzionario calvinista, puritano, di cui Cromwell fu il capo, e che portò alla decapitazione di re Carlo I Stuart (1649) e all’unico decennio di repubblica dell’Inghilterra, retta da Cromwell con pugno forte e spirito progressivo, aperto alle libere opinioni “protestanti” in Parlamento e ad una stampa libera salvo che per i cattolici (in quanto ritenuti “intolleranti” e perciò da non tollerare), per quel periodo. Spiegando quelle strane corrispondenze tra pensiero assolutista e pensiero-prassi di tipo rivoluzionario, Tronti notava: “Non c’è pratica di governo senza teoria della sovranità. Non si arriva a Cromwell senza passare per Hobbes. E all’inverso. Non c’è teoria della sovranità senza comando sul diritto, senza il potere di fare le leggi. Non si arriva a Hobbes senza passare per Cromwell.” E qui citava un passaggio dal testo di Hobbes Dialogo fra un filosofo e uno studioso del diritto comune, in cui Hobbes diceva: “Non è la sapienza, ma l’autorità che crea la legge”[8]. In pratica lo stesso rapporto necessario che da Hegel porta a Marx (e Lenin) si avrebbe tra Hobbes e Cromwell, ma il nesso non è solo di successione, bensì d’interdipendenza, anche loro malgrado.
Va però notato via via uno spostamento sempre più forte nel pensiero di Tronti dal sociale al politico, dall’azione operaia diretta, alla lotta del “movimento” operaio per la conquista dello Stato; e, infine, dalla storia allo “spirito”. Si ha quasi inversione della relazione tra struttura e sovrastruttura, in un contesto che può ricordare pure la tesi di Gramsci per cui i problemi di struttura si pongono a livello della sovrastruttura. Il nucleo del ragionamento era già presente nella valorizzazione del Lenin che spostava la rivoluzione capitalistica, ancora lontana dall’essere compiuta in Russia, nelle mani del governo “operaio” (da Due tattiche del 1905, con l’obiettivo “giacobino marxista”, della “rivoluzione borghese senza borghesia”, alla Nuova Politica Economica del 1921, che prendendo atto della mancata rivoluzione a Occidente sarebbe tornato a Due tattiche, combinazione tra economia capitalistica e potere “operaio” nella Stato: lo Stato dei soviet che promuoveva, col potere “operaio”, lo sviluppo del capitalismo). Solo che, come sempre, Tronti cercava di ripensare Lenin nell’ottica dei paesi capitalistici avanzati, ma applicandovi uno schema che per lui non valeva più solo per paesi di capitalismo nascente come la Russia, ma pure dove il capitalismo è più sviluppato. Così nell’importante saggio Sull’autonomia del politico (1972), pieno di echi di Carl Schmitt ripensato dal punto di vista di Lenin, già spiegava – oltre a tutto mettendo ciò in corsivo – che “La classe operaia, sulla base della lotta dentro il rapporto di produzione, può vincere solo occasionalmente; strategicamente non vince, strategicamente è classe, in ogni caso, dominata.” Ma ancora una volta riemergeva il solito Lenin modello 1905 universalizzato, nel senso che il capitalismo, attraverso lo Stato, può essere governato dalla classe operaia. Qui viene in mente quanto mi era stato riferito da un giovinetto ventenne di Alessandria, che certo non aveva capito tutto ciò che quell’uscita sottendeva, presente alla discussione dell’agosto 1963 in cui i “trontiani” avevano rotto con i “Quaderni rossi”. Panzieri aveva detto che la linea proposta da Tronti, che connetteva pretesa attualità della rivoluzione operaia con il cosiddetto “punto di vista operaio” di una piccola avanguardia che avrebbe preteso di rappresentare carismaticamente la classe operaia , era la “scientificizzazione della strategia politica di Togliatti”, in cui “il politico” decide per la “sua” classe (il partito, o embrione di partito “proletario” si arroga il diritto di pensare-volere per il proletariato come vero interprete della sua volontà generale). Certo nel 1963/1966, il gruppo operaista credeva che pure la grande maggioranza dei lavoratori la pensasse a suo modo, ma esso si sentiva comunque l’incarnazione di tale volontà senza bisogno di ulteriori verifiche empiriche. Quando l’approccio fu portato alle estreme conseguenze, dal 1972 in poi, il “politicismo” sempre più sincronizzato con una sorta di togliattismo di sinistra, leninista-schmittiano, divenne il post-operaismo. Ma da un punto di vista politico-dottrinario il punto chiave è che per tal via alla fine il centro del “politico”, anche per fare il potere operaio, diventa lo Stato. In Tronti l’autonomia del politico, pur implicando sempre torsioni di tipo decisionistico, è soprattutto autonomia dello Stato, e dell’azione del “movimento operaio” – dimensione che comprende la classe operaia e il partito politico vero che vi si connette – nello Stato.
Va però colta la radice leninista, anzi “leniniana”, del forte interesse di Tronti per Schmitt, ma pure l’idea che Cromwell stia a Hobbes come Lenin sta a Schmitt. Lenin non conosceva Schmitt, ma Schmitt sarebbe importante per intendere il decisionismo di Lenin e Lenin per comprendere come venga fuori quello di Schmitt. Schmitt era coscientemente l’anti-Lenin, ma il suo pensiero lo presupponeva, e sviluppandosi chiariva l’altro, antagonista[9]. Questo però stava a significare che quello che è il perno del marxismo ab ovo, la dipendenza almeno in ultima istanza della sovrastruttura (politica, idee e Stato) dalla struttura (rapporti economico-sociali) non stava più in piedi, se non come mero substrato, per cui “lo stesso materialismo storico risulta un prodotto del primo capitalismo” [10].
Non stupisce la grandissima considerazione che Tronti mostrerà, dal 1972 in poi, proprio per le svolte importanti nella sinistra portate da Togliatti – partito nuovo, di massa ma sempre d’avanguardia, comunista “in toto”, e egemonia nella cultura, e la volontà di essere movimento democratico e comunista – partecipando alla presentazione dell’importante raccolta di suoi scritti curata soprattutto da Giuseppe Vacca nella più preziosa collana di filosofi e pensatori della Bompiani nel 2015. Concorda con la definizione di Togliatti come totus politicus data da Benedetto Croce. Lì c’era il decisionismo da Machiavelli a Lenin a Schmitt, nella grande tradizione del realismo politico, da Tronti sempre apprezzata, specie dal 1972 alla morte[11]. Del resto Tronti, in Senato, pronunciò una vera orazione celebrando i novantacinque anni di Ingrao, comunista che sentiva molto affine pure come tipo umano.
È possibile che in tale quadro a metà degli anni Settanta Tronti – sempre in funzione neocomunista e anti-socialdemocratica – abbia aperto al compromesso storico. Questo non è mai criticato, e neppure Berlinguer è “espressamente” criticato, anche se la strategia di tal genere è certo vista da Tronti come tattica per portare il movimento operaio alla direzione dello Stato (e non come strategia).
Ma ben presto la “rivoluzione operaia” del nuovo biennio rosso (1968-1969), come già il ’19-20, si risolvette in disfatta, nel 1978 (morte di Moro, e tutto il resto subito prima e dopo). Di lì per Tronti data una vera disfatta storica della sinistra, nonostante un qualche impegno da militante, e a un certo punto da parlamentare del Partito Democratico della Sinistra e poi del Partito Democratico bersaniano, impegno vissuto più o meno ai margini e in modo alquanto defilato, e probabilmente disincantato. Accettava il solito ruolo dell’intellettuale di sinistra che dà credibilità al mondo comunista nell’una o nell’altra istituzione elettiva, magari tra i dubbi e qualche intimo conflitto.
La comprensione della disfatta graduale della sinistra (che in sostanza dalla morte di Moro del 1978 arriva all’avvento di Berlusconi del 1994 e poi, tra alti e bassi, si fa rovinosa), è complessa, e per Tronti giustamente e dichiaratamente inspiegabile con categorie storico materialistiche, presunte o effettivamente marxiste. Infatti egli diceva – mostrando quanto fosse diventato interno alla logica del PCI e della sinistra dei partiti di lunga data – che anche l’autunno caldo non aveva trovato una sinistra inadeguata. Lo osservava nel 1980 ne Il tempo della politica: “C’erano stati naturalmente ritardi, incomprensioni, reciproche diffidenze, ma si può dire che alla fine degli anni sessanta partiti e sindacato da una parte, nuove masse dall’altra erano in buona posizione per incontrarsi.”
La spiegazione del mancato sbocco democratico di sinistra era sempre individuata nell’interesse della borghesia a frenare lo sviluppo politico sociale del suo stesso sistema, per non farsi sopravanzare dalla classe lavoratrice (Lenin colpiva ancora). E infatti seguitava: “Tutte le vicende dei primi anni settanta sono internamente e violentemente investite da questa reazione di sistema. C’è un filo oggettivo che lega la strategia della tensione, la ripresa neofascista, le rivolte meridionaliste, le campagne fanfaniane, un filo oggettivo che funziona come progetto politico di far arretrare la situazione complessiva, di abbassare il livello e il terreno di lotta, di spingere indietro gli equilibri avanti recentemente raggiunti tra organizzazione di classe e movimenti di base, di chiudere sulla difensiva le forze che stavano cercando una strategia d’attacco.” Il disegno di reazione capitalistica all’avanzata del movimento operaio così, tramite l’accordo Moro-Berlinguer, pareva fallire. Ma poi fallì quello del movimento operaio: “ … è la vicenda del biennio speculare al 1968-1969, quello del 1977-1978”. Insomma il 1977-1978 sono l’anti-’68 e l’anti-’69 e aprono a un’epoca di disfatta storica della sinistra (non autoritaria come quella scatenatasi nel 1921, almeno per ora, ma ugualmente grave, e cui le proteste del “dalli al fascista” potrebbero persino servire).
In sostanza la sinistra fu sconfitta di nuovo, come nel primo dopoguerra dal fascismo (se non peggio). Il grande tema delle ragioni della mancata risposta della sinistra a quella manovra controrivoluzionaria, forse sfumate in Tronti per il rifiuto del comunista – pur ex contestatore – di attaccare il proprio quartier generale, resta senza risposta.
Un punto chiave per Tronti, cui su ciò plaudo, sembra sia stato il fatto che la sinistra contrastò invece di assumere come primo problema la riforma dello Stato, che nella sostanza il capitalismo “reale” (o anche le forze politiche veramente egemoniche che l’incarnano), secondo Tronti non vorrebbe (e infatti dopo tanto rumor arriva sempre il nulla), perché nella sostanza la “nostra” borghesia, o la borghesia generale, “il sistema”, preferisce che le contraddizioni – per quanto durando senza essere risolte rendano marcio il sistema specie politico – non esplodano. Il capitalismo si salva accettando che lo Stato funzioni male, lasciando che le situazioni marciscano pur di durare, evitando così la drammatizzazione della crisi, che ci sarebbe se ci fosse una vera democrazia dell’alternativa tra blocchi storici opposti. Il capitalismo “vero”, o chi per esso (qui era la Democrazia Cristiana in primis, come forza egemone intrasistemica, e poi quel che il convento della “borghesia”, dominante e ormai “egemone”, ha passato da Berlusconi a Giorgia Meloni), preferisce un lento declino a contraddizioni che si farebbero per esso dirompenti, tali da metterlo in ginocchio, se i nodi venissero al pettine (spiegava già in modo antelucano nel citato saggio del 1972 Sull’autonomia del politico). Questo “quieta non movere” pur di durare, anche facendo marcire tutto, non era fatto per diabolico proposito di non funzionare lo Stato per frenare il “movimento operaio”, ma come reazione del ceto dominante quasi naturale (come d’istinto). La necessità spinge avanti un ceto politico dominante, intrasistemico, che si limita di continuo a mediare senza risolvere i problemi, anche a costo, come accade, di farli incancrenire peggiorando a poco a poco il sistema.
Questo però spingeva Tronti ad una conclusione che io pure, forse con diversa risposta (ma non tanto), ho ribadito sin dal 1989 innumerevoli volte: la riforma che dia vera governabilità allo Stato è il vero interesse del mondo dei lavoratori (che però la sinistra non vuol mai capire, per tante ragioni: in parte attinenti ad una sorta di paura antistorica del “Duce”; un po’ per vera e propria ignoranza storico-politica e soprattutto istituzionale, tanto più grave quando i dilettanti allo sbando non capiscono neanche di essere tali; in parte per corta visuale di gruppi dirigenti figli di due tristi tramonti, l’uno comunista e l’altro democristiano, con capi di calibro sempre più piccolo. (Se si guarda l’iter che da Togliatti di scalino in scalino arriva alla Schlein, nella filiera che dal PCI porta al PD d’oggi, la cosa si vede a occhio nudo). Ma, come diceva su ciò Tronti addirittura nel 1972, si tratta di “arrivare a prendere in mano questo processo di ammodernamento della macchina statale, di arrivare addirittura a gestire non, come si dice nel gergo, le riforme in generale, ma in particolare quel tipo di riforma specifica che è la riforma capitalistica dello Stato.”[12] (Sembra “di destra”, e invece è l’interesse primario della sinistra).
E ancora, in: Fare società con la politica (2008) notava: “Credo sia venuto il tempo di lavorare a proporre noi, da sinistra, la grande riforma costituzionale. Il nostro modello dovremmo farlo girare intorno al perno di un decisionismo senza presidenzialismo.”[13] (Com’è noto – aggiungo io – Renzi presidente del Consiglio e segretario del PD, sia pure con alcuni pasticcetti e soprattutto con un eccesso di nociva personalizzazione dello scontro, ci provò, nel 2016, ma invano. Sembra che da tempo immemorabile sia la sinistra a non volere alcuna forma di modifica profonda dello Stato: a lungo con ottime ragioni per temerlo, ma dallo scacco dell’ultima vera strategia della sinistra, dal 1979 almeno, credo io, per dabbenaggine autolesionistica, talora favorita dal cinismo semicriminale di avversari “moderati”).
Tutto il ciclo si conclude dunque, anche per Tronti, con una storica disfatta, diversamente dalla Rivoluzione francese, che aveva lasciato almeno il nuovo diritto. Qui invece non solo dopo Lenin era arrivato il dispotismo di Stato di Stalin e poi la sclerosi burocratica dell’URSS, ma dopo il Sessantotto e l’autunno caldo, e la morte di Moro, tra alti e bassi, è arrivata una disfatta epocale. Lo scriveva già nel saggio Über das geistige in der politik [“Sull’intellettuale in politica”](1992), quando non era ancora arrivato Berlusconi), chiedendosi: “E poi la regina di tutte le domande: il proletariato storico, la classe operaia moderna, poteva farcela a cambiare il mondo? A cambiare l’uomo: poiché era questo il fine, lo scopo finale (Endziel), del progetto e del percorso rivoluzionario. Il socialismo era un mezzo, una lunga transizione a questo.”[14] Già osava l’amara constatazione storica, con riferimento attualizzato alla Fenomenologia dello spirito di Hegel del 1807: “La tumultuosa fenomenologia dello spirito c’è stata, ma la Storia finisce qui. L’Assoluto ha raggiunto sé stesso, il Moderno borghese ha vinto. L’uomo dell’economia politica capitalistica, descritto da Smith, “l’individuo borghese”, l’”homo oeconomicus”, ha dimostrato di essere “l’uomo di natura”, “l’essere naturale”[15], che però non si può accettare, anche a costo di andare al di là della natura (scoprendoci, nel fondo, “spirito”). A me viene in mente André Gide, che nel romanzo I falsari ricordava che “in fondo si può evadere solo verso l’alto”[16].
Perciò nel suo ultimo libro, in certo modo testamento, Dello spirito libero (2015), diceva: “Dall’aristocratica Prussia [dell’Hegel delle lezioni di filosofia della storia, che aveva visto il culmine della storia nello Stato prussiano] il primato viene consegnato all’Inghilterra capitalistica e al suo dinamico figlio illegittimo, che scalpita al di là dell’Oceano [gli Stati Uniti] .”[17]
Si è, o sarebbe, inverata l’ipotesi catastrofica che Marx e Engels avevano pur fatto nel Manifesto del partito comunista del 1848: “… ancora una volta le lotte operaie avevano imposto al capitalismo lo sviluppo, ma questa volta con un risultato originale: la rovina non è stata solo di una classe, ma di tutte e due le classi in lotta. Marx era stato buon profeta.”[18] Ormai il grido di Zarathustra adatto a questi tempi non è “Dio è morto”, ma “il popolo è morto”. E perciò, già nel richiamato Politica e destino, del 2001, subito domandava: “Perché credete che ci sia il populismo? Ma, perché non c’è più popolo.”[19]
Tuttavia ciò ha comportato, nel nostro mondo, l’opposto della proletarizzazione: la “borghesizzazione”. In fondo è quello che il mio ex collega a Scienze Politiche a Torino, il politologo Luca Ricolfi, chiama ora “La società signorile di massa”, con i due terzi che sono diventati piccoli borghesi[20]: il che però in Tronti suscita un orrore che direi neo-marcusiano[21] , e che io totalmente condivido.
Non si sottrae alle conseguenze, che hanno strani punti di contato con il Bordiga specie vecchio, che credo Tronti non conoscesse quasi, a partire dalla critica della democrazia, che egli chiama “reale” (come Breznev diceva “reale” il socialismo sovietico: quello che c’era nella storia “vera”). Lo dice proprio in una relazione del 2005 espressamente intitolata Per la critica della democrazia politica, in cui segnalava l’omologazione avvenuta, in quest’età di secolarizzazione, con il piccolo borghese soddisfatto, “ultimo uomo” per Nietzsche.[22]
A questo punto la spiritualità diventa rivoluzionaria perché la “materia umana” si è rivelata o è diventata, sciaguratamente borghese. Insomma, pare che sia proprio solo la scoperta della dimensione spirituale a poter contrastare questa morta gora. Si tratta di costruire, quante più persone possibile, una sorta di fortezza interiore, che chiama “spirito libero”, contro quest’ estrema decadenza del capitalismo, che degenera sempre più per non morire (più o meno come aveva fatto il “socialismo reale”, quando dopo Kruscev dal 1964 aveva deciso di durare tal quale per non morire, marcendo a poco a poco). Oggi la “democrazia reale”, col suo Stato, marcio ma irriformato, forse non solo in Italia, ma ovunque, pure in America, sarebbe a questo punto.
Ma per ora a ciò si oppone e si può e deve opporre solo una coscienza interiore irriducibile, nella sua differenza ontologica, che si può persino serenamente, per quanto tragicamente, sottrarre all’abbraccio ormai letale di un sistema sempre più marcio. Lo spirito profondo dell’uomo e nell’uomo – proprio in quanto è irriducibile a uno stato del mondo non solo marcio, ma sempre più marcio – risulta essere la vera resistenza contro un mondo borghese in totale decadenza. Lo spirito è assunto come una sorta di antistoria, ma come resistenza a una storia fattasi troppo marcia. Tanto che in una specie di piccola-intervista in forma di film, parlando di questo ultimo suo libro, Dello spirito libero, Tronti – che pure in tanti scritti negli ultimi anni ha citato con totale assenso testi di San Paolo e Sant’Agostino, di Eckhart e infine pure di Rodano, Enzo Bianchi e Quinzio – negava di essersi convertito, e diceva che tale libro, Dello spirito libero, “è dieci volte più sovversivo di Operai e capitale. Qui il conflitto è col mondo e uomo che questa società ha prodotto. È la civiltà occidentale che è messa in questione.”[23]
Su ciò è interessante l’intervento del 2016 Lo spirito che disordina il mondo, in cui spiega che non si tratta di consolarsi col ritorno alla religione storica, come fanno tanti politici, né tantomeno a fondamentalismi religiosi, islamici e non. Piuttosto, dopo aver citato positivamente la filosofa mistico-libertaria Simone Weil, dice che la “espressione ‘sentire religioso’ mi piace di più perché evoca una disposizione dell’animo umano”. Si tratta, anche per lui, di spiritualizzare la vita contro la decadenza borghese dilagante: “ … e confesso che a volte mi sembra questa l’ultima e definitiva frontiera della resistenza nei confronti dell’aggressione proveniente dal mondo esterno. Io infatti considero il mondo ‘di fuori’ un mondo nemico. Dunque bisogna stare attenti a considerare la spiritualità come una sorta di ‘benessere interiore’, insomma la cura di sé per trovare l’armonia con il mondo. (…) Ecco: io contrappongo a tutto questo un’altra cosa, molto netta: stare in pace con sé, oggi, vuol dire entrare in guerra con il mondo.”[24]
Perciò nel libro Dello spirito libero, che in certo modo è pure stato il suo testamento politico filosofico, Tronti scriveva: “Che cos’è dunque, per me, spiritualità? È fondamentalmente interiorità, è il mondo interiore dello spirito umano, declinato in forma duale, al femminile e al maschile, come due modi differenti di essere, complementari e conflittuali. È coltivazione di sé, non per sé, ma contro il mondo. Non fuga mundi, come non è stata mai nemmeno per il monachesimo, ma presenza nel mondo, inattaccabile dall’esterno. Una sorta di vallum, eretto a difesa, entro cui si può dire: ecco voi qui, con le vostre idee, non mi prenderete, e da cui si può ripartire per sortite d’attacco agli assedianti. La guerra è ormai guerriglia. Anche la guerra del pensiero, l’unica che valga la pena di combattere.”[25] E al proposito, nello stesso testo cita San Paolo, in quel caso quello della “Seconda lettera ai corinzi”, che diceva: “Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno.”[26] E richiama, su ciò, anche uno stupendo aforisma, che io pienamente sottoscrivo, del mistico tedesco Angelus Silesius, del XVII secolo, il quale diceva che “Due occhi ha l’anima, uno guarda nel tempo. Ma l’altro si rivolge dritto all’eternità.”[27]
In ciò si connetteva a tutti i movimenti collettivi “contro”, com’è nella quintessenza dello spirito libero, notando appunto, in Dello spirito libero: “Dietro questo discorso c’è, sullo sfondo, una figura un po’ hegeliana e un po’ nietzscheana, che inviterei a frequentare, come si frequenta un amico in un mondo nemico. È il Freigeist, lo spirito libero, una figura novecentesca, che ha trovato un suo seguito nel principio-speranza di Bloch, nella coscienza del proletariato del giovane Lukàcs, nel comunismo teologico di Benjamin, in quello escatologico di Taubes, in quello della fine della storia di Kojève. E aggiungerei nel soldato bolscevico che, baionetta in canna, assalta il Palazzo d’inverno, nel partigiano condannato a morte della Resistenza che scrive la sua ultima lettera, nell’operaio di fabbrica taylorista che salta la scocca sulla catena di montaggio, nella donna che pronuncia la parola impronunciabile: rivoluzione femminile. La spiritualità è libertà. Libertà politica. Perché la libertà o è libertà dello spirito, o è solo un’altra forma di oppressione. Oppressione politica.”[28]
In questi riferimenti è molto presente un approccio che Tronti ha desunto da una famosa pagina di Angelus Novus di Walter Benjamin: il guardare al futuro dal punto di vista del passato, ma per andare oltre[29] (il che non so se sia marxista nel senso di Marx – ed io sospetto di no[30] – ma non è importante). Tronti, in Per la critica della democrazia politica (2005), lo semplifica con efficacia notando: “Ora io, come sapete, mi muovo dentro un impianto che chiamo autoironicamente neoclassico, nel senso che mi metto nel Novecento, pianto i piedi in quel secolo e poi da lì guardo indietro e in avanti e da lì non mi muovo e non intendo muovermi (p. 604).”[31]
Questa famosissima immagine del Walter Benjamin, di Angelus novus, elaborta ripensando molto liberamente un piccolo quadro di Klee, sull’angelo della storia che guarda agli oppressi di tutte le generazioni del passato mente un forte vento lo spinge al futuro, è ripresa e concettualizzata pure da Tronti. E sicuramente è ben nota al regista romano Nanni Moretti, che quasi certamente conosceva Tronti nell’ambiente culturale comunista della capitale, e a mio parere “di fatto” ritorna nell’apologo del finale del bel suo recente bel film “civile” e “politico” Il sol dell’avvenire, qui discusso con competenza e ampiamente dal mio amico Giuseppe Rinaldi, ma senza apprezzamento di questo punto “conclusivo”, che pare a me decisivo. Moretti, molto legato all’idea di un PCI marxista inteso soprattutto come un vivaio di fede e impegno per il riscatto da parte del mondo del popolo proletario romano degli anni Cinquanta, constata la fine di quel mondo, travolto sotto le macerie dell’involuzione burocratico-imperialista sovietica, evidentemente del 1991 (nella sua metafora sin dai fatti d’Ungheria del 1956, in cui il cingolato sovietico soffocò nel sangue un “paese fratello” ribelle). Il vero quadro comunista motivato ne è così sconvolto che vorrebbe impiccarsi, e così avrebbe dovuto finire il film. Ma il regista, del film nel film (Nanni Moretti stesso), alla fine s’inventa un altro finale, una conclusione che non c’era stata nella Storia vera, ma avrebbe potuto esserci, se il PCI per tempo (nella metafora sin dal primo irrompere del burocratismo imperiale sovietico a Budapest nel ‘56), si fosse ribellato rompendo con Mosca. Non accadde, certo per molti motivi storici. Ma ogni scenario sul “poter essere stato” guarda naturalmente al futuro, come a dire che quel che si dovrebbe fare è “di nuovo” una comunità di popolo coesa e moralmente motivata, senza i pesi morti del burocratismo liberticida che avevano inquinato e rovinato il passato.[32] Io non lo credo possibile, perché il futuro non è mai passato riveduto e corretto, e credo che imbarcandosi su tale strada sia troppo facile cadere nel “nostalgismo”, anche riveduto e corretto, che non paga. Però trovo che l’idea che solo una nuova comunità popolare variegata e alternativa a un mondo imbarbarito, riunificatrice delle anime del socialismo, nato col “sol dell’avvenire” dell’Inno dei lavoratori[33] di Filippo Turati del 1886, potrebbe “salvarci”, non sia da buttare, e in tale chiave pure l’Angelus novus benjaminiano può avere molto valore.
Nell’approccio del Tronti in questione gli spiriti liberi del passato parlano a quelli liberi del futuro, in quanto sono stati tutti contro il loro tempo, e non del e nel loro tempo. Pone perciò non già accordo, come il filosofo Max Scheler, tra spirito e vita, ma, come Klages, contrasto (come nota in: Con le spalle al futuro. Per un altro dizionario politico, già nel 1992).[34] Il tutto in Tronti si accompagna non alla riscoperta della religione “storica”, ma della religiosità. In ciò si sente concorde con l’identità tra lo spirito universalmente umano e Cristo teorizzata da San Paolo nella Lettera ai Galati, che fondava il dogma cristiano del corpo mistico, in cui nell’universalmente umano-divino spariscono tutte le differenze, come dice ne Il sorriso di Sara, nel 1992[35], con echi pure antiprotestanti (e gli Ugonotti? E i Puritani di Cromwell?) e controriformisti, che probabilmente portano all’ultimo Diego Fusaro (il cui La fine del cristianesimo, recentissimo, rimpiange Ratzinger[36]) : echi che non mi piacciono affatto, sia per la visione sovrindividuale della fede (“non sono più io, ma Cristo”) che per una trascendenza che è più e prima dell’immanenza, da cui pure per Tronti emana. Molto di tutto ciò mi piace, ma io sottolineerei con molta più forza il fatto che pure il Christus deve scaturire nelle individualità e non inghiottirle. Tuttavia mi ritrovo totalmente nell’istanza della religiosità in interiore homine, che trovo fondamentale, laddove Tronti dice: “Non si tratta più di ridefinire la rivoluzione, in termini puramente razionali e naturali. Non si può più fare critica della politica senza decifrare e decidere il segno che ha la crisi della politica. Occorre cominciare a pensare, a cercare, una fondazione totalmente diversa. Si è verificata una chiusura, o un’assenza di uscita, nella condizione attuale del mondo della storia, al punto che la rivoluzione in senso alto non è più rivoluzione contro la società feudale o contro la società borghese, ‘ma diventa il rovesciamento del segno della storia’.””[37] In ciò si connetteva a idee forti del grande studioso della stessa economia marxiana, Claudio Napoleoni, alla fine del suo percorso.
Ma nonostante tanti echi cristiani e cattolici in questi libri – con espliciti riferimenti specie alle Lettere di San Paolo (il più detestato da Nietzsche), al Sant’Agostino del De vera religione e soprattutto della Città di Dio[38], alla Controriforma stessa (riferimenti talora discutibili), a Enzo Bianchi ed a Rodano – sono fortissimi gli echi di Nietzsche, che pare essere il filosofo più riscoperto del suo ultimo periodo, specie in riferimento alla fase della filosofia dello “spirito libero” in Nietzsche, da Umano troppo umano (1878) alla prima parte del Così parlò Zarathusta (1883).[39] E infatti in Umano troppo umano (1878), qui citato in In Dello spirito libero, Nietzsche diceva, con apprezzamento di Tronti: “Si chiama spirito libero colui che pensa diversamente da come, in base alla sua origine, al suo ambiente, al suo stato e ufficio o in base alle opinioni dominanti del tempo, ci si aspetterebbe che egli pensasse.”[40] Nietzsche lo contrapponeva non solo al pensiero dominante, ma anche ai “dotti”, dicendo: “Lo spirito libero è diffamato, specie dai dotti”, i quali si distinguono dagli altri per la loro “esattezza e diligenza di formiche”, “pratici dell’intelletto, che credono di stare con i piedi per terra nelle cose del mondo”, ma in realtà “rassomigliano a quei viaggiatori che fanno la conoscenza di paesi e popoli dal treno”.[41]
L’approccio però guarda sempre a un oltre dello spirito, anche religioso, tanto che sulla scorta di Hölderlin, ma pure di Schelling e di Cacciari – e come io pure vengo facendo nella seconda parte della mia Trilogia, il romanzo “in uscita” Nietzsche dopo la follia. Romanzo dionisiaco[42] – a quel che ora ho notato pure Tronti proponeva l’unione tra Cristo e Dioniso, osservando, in Über das Geistige in der Politik (Con le spalle al futuro, 1992): “Cacciari: ‘La mitologia schellinghiana rappresenta essenzialmente un theoreîn tragico (…). Ma il dio del narrare-sapere mitologico, della sapienza che da lontano fa segno, è Dioniso, anzi la trinità dionisiaca, che Schelling – dice Cacciari – ‘chiaramente interpreta come preparatio evangelica’. Cristo fratello di Dioniso, come canta Hölderlin … .”[43] Non è tanto questione di nomi quanto di ritrovamento del divino non al di là o al di sopra della vita, ma nella vita, come Vivente della e nella vita, e svelabile nella mente umana. Dobbiamo spiritualizzare la materia e materializzare la vita, anche per sacralizzare e salvare la terra, e trovare l’eterno nel tempo e viceversa. Qui è il messaggio del mio Nietzsche dopo la follia. Romanzo dionisiaco, che sta venendo alla luce. Ma qui a parlare non è più Tronti, ma sono io. E con ciò?
Perciò, nel libro Dello spirito libero Tronti poteva felicemente affermare, connettendosi a Nietzsche ma rettificandone felicemente il pensiero: “Lo spirito libero è come il regno di Dio. Non si può dire: eccolo qui o eccolo lì. Non attira l’attenzione. Non si può dire: verrà alla fine dei tempi, o tornerà nella terra degli uomini. Lo spirito libero è in mezzo a voi. È Dio in noi. Fuga dagli ultimi uomini. Ma senza bisogno di un oltre uomo (p. 293).[44]” Parole sante.
di Franco Livorsi
- S. Quinzio, Mysterium iniquitatis, Adelphi, 1995. ↑
- M. Tronti, “Politica è profezia”, “Baillame”, n. 20, 1996, e in: Il demone della politica, cit., pp. 485-498, ma v. qui p. 490. L’op. cit. di S. Quinzio comparve da Adelphi, Milano, 1995. Per T. Hobbes, v. il cit. suo Leviatano. La materia, la forma e la potenza di uno Stato ecclesiastico e civile (1651), a cura di R. Giammanco, UTET, Torino, 1955, due volumi. ↑
- M. Tronti, “Politica e profezia” (2001), in: Il demone della politica, cit., pp. 573-574. ↑
- Max Weber, Il lavoro intellettuale come professione (1918), Einaudi, Torino, 1977, p. 121. ↑
- M. Tronti, “La linea di condotta” (1966), cit, in: Il demone della politica, cit., p. 218. ↑
- A. Gramsci, Quaderni del carcere, ed. dell’Istituto Gramsci a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino, 1975, quattro volumi. Fa parte dei quaderni su Machiavelli e lo Stato moderno. ↑
- M.Tronti, La politica al tramonto, Einaudi, 1998, e ora nel Demone della politica, cit., nel capitolo Il Principe e l’Utopia, pp. 535-548. Si vedano in particolare p. 535 e p. 547. ↑
- M. Tronti con A. Piazzi e M. Segatori, Stato e rivoluzione in Inghilterra. Teoria e pratica della prima rivoluzione inglese, Il Saggiatore, Milano, 1977, qui riportato nel saggio di Tronti Hobbes e Cromwell, pp. 333-368. Citava pure un passaggio dal testo di Hobbes Dialogo fra un filosofo e uno studioso del diritto comune (1666), e in “Opere politiche”, a cura di N. Bobbio, UTET, Torino, 1959, in cui Hobbes diceva: “Non è la sapienza, ma l’autorità che crea la legge” (p. 356). ↑
- C. Schmitt, La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe (1921), Laterza, Roma-Bari, 1975. Su questo pensatore è fondamentale: Carlo Galli, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Il Mulino, Bologna, 1996. ↑
- M. Tronti, “Sull’autonomia del politico” (1972), in Il demone della politica, pp. 285-312, qui p. 293. ↑
- P. Togliatti, La politica nel pensiero e nell’azione. Scritti e discorsi 1917-1964, a cura di M. Ciliberto e G. Vacca, Bompiani, Milano, 2015. Ma si veda, su You Tube, del 2015: Presentazione del volume “Palmiro Togliatti”, presso Treccani La Cultura.it. ↑
- M. Tronti, Sull’autonomia del politico (1972), cit., qui p. 297. ↑
- M. Tronti, “Fare società con la politica” (2008), poi in: AA.VV., Non si può accettare, Ediesse, Roma, 2009, e in Il demone della politica, cit., pp. 623-635, ma v. qui p. p. 629. ↑
- M. Tronti, “Il sorriso di Sara”, in: Con le spalle al futuro. Per un altro dizionario politico, Editori Riuniti, 1992, e in Il demone della politica, cit., pp. 435-454, ma qui p. 437. ↑
- M. Tronti, “Über das geistige in der Politik” (1992), in: Il demone della politica, cit., p. 453 ↑
- A. Gide, I falsari (1925), Bompiani, Milano, 1958. ↑
- M. Tronti, Dello spirito libero. Frammenti di una vita, Il Saggiatore, Milano, 2015, p. 13. ↑
- Ivi. 315. ↑
- M. Tronti, “Politica e destino” (2001), cit., in Il demone della politica, cit., pp. 576-577. ↑
- L. Ricolfi, La società signorile di massa, La nave di Teseo, Milano, 2019. ↑
- H. Marcuse, L’uomo a una dimensione (1964), Einaudi, Torino, 1967. ↑
- M. Tronti, “Per la critica della democrazia politica”, in: AA.VV., Guerra e democrazia, a cura di M. Tari, Manifestolibri, 2005, e in: Il demone della politica, cit., pp. 601-610. ↑
- La mia parola messa a nudo. Video-intervista a Mario Tronti, “Youtube”, s.d. ↑
- M. Tronti, “Lo spirito che disordina il mondo” (2006), in: AA.VV., Politica e Spiritualità, “Adista”, n. 6, gennaio 2007, e in: Il demone della politica, cit., pp. 611-622, ma v. p. 618. ↑
- M. Tronti, Dello spirito libero, cit., p. 226. ↑
- Ivi, p. 171. ↑
- Ivi, p. 292. ↑
- M. Tronti, Dello spirito libero, cit., pp. 231-232. ↑
- W. Benjamin, Angelus Novus. Saggi e frammenti, a cura di R. Solmi, con un saggio di F. Desideri, Einaudi, 2014. Ivi, nelle sue “Tesi sulla filosofia della storia”, in un passaggio famoso Benjamin scriveva: “C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta.” ↑
- Marx rimproverava i rivoluzionari del 1848 a Parigi di pensarla come repubblicani di epoche anteriori invece che incentrando l’azione sull’emergente proletariato (e sul socialismo), in: Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850 (1850), a cura di G. Giorgetti, Editori Riuniti, 1962, e, soprattutto, insegnava a vedere il presente dal punto di vista del futuro, considerando sempre il presente come morituro, spiegando la sua dialettica nel fondamentale Poscritto del 1873 alla seconda edizione del primo libro del Capitale, I, ivi, 1962. ↑
- M. Tronti, Per la critica della democrazia politica, cit., ne “Il demone della politica”, cit., pp. 601-610, ma v. p. 604. ↑
- Mi riferisco al bel film di Nanni Moretti Il sol dell’avvenire, del 2023, ampiamente discusso da Giuseppe Rinaldi, in Nanni Moretti e la morte del cinema, qui il 21 settembre 2023. ↑
- Filippo Turati, che a quel tempo oltre che giovane avvocato ventinovenne socialista, era poeta, compose l’Inno dei lavoratori all’inizio del 1886, su invito dell’operaio-leader Costantino Lazzari, per il suo piccolo Partito Operaio Italiano. L’Inno, famosissimo, col motivo della “libera bandiera” su cui splende “il sol dell’avvenire”, fu subito musicato da Zenone Mattei. Rinvio pure al mio libro: Turati. Cinquant’anni di socialismo in Italia, Rizzoli, Milano, 1984. ↑
- M. Tronti, “Über das Geistige in der Politik” (1992), in: Con le spalle al futuro. Per un altro dizionario politico, Editori Riuniti, Roma, 1992, e in: Il demone della politica, cit., pp. 435-454, ma 445. ↑
- M. Tronti, “Il sorriso di Sara”, nel 1992, cit., in: Il demone della politica, cit., pp. 455-484. ↑
- D. Fusaro, La fine del cristianesimo, Piemme, 2023, recentissimo, rimpiange Ratzinger. ↑
- M. Tronti, “Il sorriso di Sara”, in Il demone della politica, cit., pp. 477-478. ↑
- A. Agostino, De vera religione – La vera religione (389/391), a cura di M. Vanini, con testo latino a fronte, Mursia, Milano, 2012; La città di Dio (413/426), a cura di L. Alici, con testo latino a fronte, Bompiani, Milano, 2001. ↑
- Tra le innumerevoli edizioni di questo gruppo di opere, si vedano nell’edizione delle “Opere complete” del filosofo, a cura di G. Colli e M. Montinari, pubblicata in italiano da Adelphi. ↑
- M. Tronti, Dello spirito libero, cit., p. 265. ↑
- Ivi, pp. 267-268. ↑
- Vengo pubblicando una trilogia, Psiche e eternità, di cui alla fine del 2022 è uscito Psiche e eternità. Alla ricerca del dio perduto, Moretti & Vitali; all’inizio del 2024 uscirà la seconda, Nietzsche dopo la follia. Romanzo dionisiaco, e più oltre, in forma poetico-poematica, uscirà il terzo: Il dio nella vita. Lo svelamento dell’Essere dopo la “morte di Dio”. Cogliere in queste settimane tutte queste assonanze con il vecchio Tronti per me è stato un piacere. ↑
- M. Tronti, “Über das Geistige in der Politik (Con le spalle al futuro)”, 1992 e in Il demone della politica, cit., pp. 435-454, ma 442. ↑
-
M. Tronti, Dello spirito libero, 2015, cit., p. 293. ↑


Molto interessante, Franco. Potresti aggiungere, nella chiusa, anche il Claudio Napoleoni del “solo un Dio può salvarci” (citazione sicuramente inesatta perché fatta a memoria senza controllare). Ovviamente non condivido tutto, ma val molto la pena di far circolare il tuo testo